
Fate largo alle scuole libere

Articolo tratto dal numero di dicembre 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
«Fateci andare in giro nudi, ma lasciateci la libertà di educare», diceva don Luigi Giussani. Forse questo è il problema più importante che riguarda la nostra civiltà: lo smarrimento della nostra tradizione, l’impossibilità (teorizzata in forma maligna) di comunicarla, la negazione di un’esperienza buona che ci permetta di crescere, di arrivare a essere uomini liberi e adulti. Non è un problema dei cattolici: riguarda tutti, cristiani e musulmani, credenti e atei. E lo è perché il livello di sviluppo di una società si misura con la qualità del suo sistema educativo, perché l’educazione dei giovani è la premessa indispensabile per garantire il futuro, il benessere e la vita della società.
L’imminente introduzione della controversa nuova legge sull’educazione in Spagna ha risvegliato numerose reazioni nella società civile. Tanto il contenuto della legge quanto il suo iter hanno mostrato una grave incapacità di dialogo e di attenzione alla realtà sociale da parte del governo delle sinistre. L’indebolimento delle scuole paritarie cofinanziate mediante l’autorizzazione di nuovi posti solo nella scuola statale, del castigliano come lingua veicolare di tutti gli spagnoli nelle diverse regioni, del diritto dei genitori di scegliere il tipo di scuola che desiderano per i loro figli, dell’insegnamento della religione o della educazione speciale per i portatori di handicap, evidenzia una visione contraria al pluralismo e alla ricchezza della vita comune perfezionata nel corso della nostra storia. Lontana dalla moderazione socialdemocratica propria della sinistra europea, ha incrementato l’intervento dello Stato e la colonizzazione radicale dei contenuti.
Le questioni concrete che inficiano la qualità dell’insegnamento – mali endemici dell’educazione in Spagna – non sono affrontate praticamente sotto nessun aspetto nella nuova legge, e pertanto continuano a sussistere senza soluzioni: enorme percentuale di abbandono scolastico, programmi ridondanti e privi di approfondimento, mancanza di rigore nella preparazione accademica, indebolimento della cultura dell’apprendimento e della serietà degli studi, mancata corrispondenza della formazione professionale alle esigenze dell’impresa, demotivazione degli insegnanti o riduzione utilitaristica dell’educazione a pura istruzione…
In Spagna, e anche in altre parti d’Europa, predomina una cultura che guarda all’educazione offerta dalle scuole concertate (paritarie cofinanziate dallo Stato, ndr) come se si trattasse di una anomalia democratica; una certa sinistra pensa pure che si tratti di un privilegio generosamente tollerato dalla società e dallo Stato. Da dove nasce questa posizione? Questa è una questione fondamentale e rivela il pensiero totalitario che intende permeare tutta la vita sociale. Pertanto identificheremo i tre o quattro aspetti essenziali che ci aiutano a offrire un giudizio costruttivo a tutta la società.
Che cosa significa educare e chi deve educare?
Educare significa introdurre la persona alla realtà, aprirla al mondo, approfondire il senso che hanno le cose scoprendo il loro valore. Implica, pertanto, risvegliare domande decisive per la vita: «Non avere un maestro significa non avere qualcuno a cui domandare e ancora più profondamente non avere qualcuno davanti a cui domandarsi. (…) Restare bloccato come il Minotauro, debordante di impeto senza via di uscita» (Maria Zambrano).
Educare non è soltanto istruire o trasmettere insegnamenti di carattere tecnico-pratico. Educare è aiutare a introdurre i nostri figli e alunni nella grandezza e nella complessità del mondo e di loro stessi, tenendo conto di tutte le dimensioni della vita umana: storica, scientifica, linguistica, personale, eccetera. Un padre o una madre educano con i loro gesti e le loro parole, offrendo ai loro figli una concezione e uno sguardo su ogni cosa: il denaro, l’amicizia, la politica, l’affettività o la religione. Tutti noi soggetti della vita sociale, per tanto, siamo implicati e tutti abbiamo una responsabilità insostituibile nel compito di educare.
Per rispondere alle necessità della vita, le comunità umane tendono ad associarsi praticando la solidarietà in tutti gli ambiti: dalla casa alla sanità e all’educazione. E l’amministrazione statale ha la missione di orientare, garantire e organizzare in maniera adeguata detti servizi. Un esempio molto chiaro è il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione che vogliono dare ai loro figli. Uno Stato democratico deve favorire che sia la società ad assumersi la responsabilità del tipo di educazione che vuole offrire. È quello che si definisce principio di sussidiarietà. Sussidiarietà dello Stato rispetto alla società, non il contrario.
Purtroppo «per un certo progressismo e sinistrismo è realmente pubblico solo ciò che nasce dallo Stato, è controllato da esso ed è sottomesso alle sue direttive e a quelle dei suoi organi amministrativi. L’importante, la formazione delle menti dei futuri cittadini, deve stare completamente sottomesso alla gestione degli organismi pubblici. In questa area tanto importante della preparazione dei futuri cittadini non deve esserci nessun agente sociale e civile» (Joseba Arregi, “De lo público y lo privado”, El Mundo, 7 dicembre 2019).
L’amministrazione pubblica promuove l’uguaglianza nella misura in cui favorisce la presenza e l’azione di tutti i soggetti nella società e dentro alla scuola, e non quando genera un sistema uniforme. Lo Stato deve assicurare l’offerta e la libertà effettiva nella scuola statale senza esimersi dal favorire la creazione di centri di iniziativa sociale, con caratteristiche e identità le più diverse. La libertà dell’educazione e l’educazione alla libertà sono un test del grado di fiducia che uno Stato ha nei confronti della sua società. Coloro che temono questo elementare esercizio della libertà hanno una sola intenzione: controllare la società.
Anche la scuola concertata è pubblica ed è espressione di vera laicità
Ciò che definisce il carattere pubblico di una attività non è la sua titolarità, ma la sua finalità, che è pubblica nella misura in cui è accessibile a chiunque. Ci sono scuole di titolarità statale e altre di titolarità privata, però tutte offrono un servizio pubblico.
La libertà di educazione permette di sviluppare e trasmettere proposte culturali significative senza le quali non può darsi educazione integrale. Non stiamo chiedendo un privilegio per un determinato progetto educativo, ma libertà per tutti i progetti educativi. Pertanto, maggiore pluralità e uguaglianza.
Tuttavia al momento di organizzarlo appaiono due concezioni o modelli di scuola laica. Il primo nasce da una concezione laicista dello Stato, secondo la quale le istituzioni dipendenti da lui sono le uniche che possono svilupparsi in maniera legittima. Al margine dello Stato esistono solo di pieno diritto gli individui isolati, e ogni altra proposta comunitaria è considerata incapace di adempiere a una funzione sociale in vista del bene comune.
Il secondo modello esprime una concezione più equilibrata riguardo alle relazioni fra lo Stato e la società civile. In questo contesto, lo spazio pubblico non è uno spazio colonizzato dallo Stato, ma è l’ambito nel quale appaiono e si esprimono differenti identità. Qual è la conseguenza nell’ambito educativo? La libertà di educare e proporre scuole con caratteristiche e identità particolari.
Le scuole non sono laiche perché sono statali. Sono laiche le scuole che nascono nel seno della società civile e offrono se stesse al popolo come un contributo originale. Possono darsi scuole, confessionali o statali non importa, dal contributo educativo, culturale e sociale validissimo, e altre il cui apporto risulta ideologico, irrilevante o vuoto.
La nuova legge che si vuole approvare parte dalla supposta neutralità della scuola statale in opposizione all’“identità dogmatica” della scuola concertata. Ma questa idea di neutralità è un mito, qualcosa di irreale. Ogni educazione implica inevitabilmente il partire da una certa concezione dell’uomo, di determinati valori e princìpi, che vengono proposti agli alunni perché possano decidere liberamente che cammino intraprendere nella vita.
Per questo la scuola statale, se vuole educare e formare persone, deve – come la scuola non statale – prendere decisioni e definire proposte. L’educazione concepita solo come trasmissione di nozioni, tecniche e competenze è espressione di una laicità ridotta a indifferenza nei riguardi del senso del vivere. Senza questa sfida alla libertà dell’alunno non può esserci esperienza educativa. «Invece, educare è rendere possibile una esperienza comune a tutti, integrale, intellegibile ed elementare», come insegna il cardinale Angelo Scola. Per questo bisogna rifondare il rapporto fra laicità ed educazione. «La scuola neutra non esiste precisamente per questa natura della relazione educativa».
Pluralismo e democrazia
Viviamo in un’epoca nella quale le civiltà e le culture si sono mescolate dentro ad ogni società. Non c’è più un sistema comune di valori e significati fra i diversi attori della comunità scolastica. Non è possibile in questo momento immaginare una scuola unica e uniforme capace di trasmettere in maniera affidabile i supposti valori che custodirebbe la società nel suo insieme. In una società aperta, il pluralismo delle scuole rende possibile la partecipazione a una proposta educativa che consente uno sviluppo reale della persona. La libertà dell’educazione riguarda il cuore della vita sociale. Questa è la grande tentazione portata a termine dai totalitarismi: individui isolati al servizio di un ordine incrollabile.
Non si tratta di una battaglia confessionale, ma della difesa della libertà per evitare il monopolio dello Stato. Perché ci sia una società libera e plurale non può esserci un unico educatore. Se fosse così, saremmo di fronte a un grave deficit democratico, una povertà per la società che ci allontanerebbe in modo gravissimo da un autentico progresso nella convivenza sociale. In questa avventura il protagonismo del soggetto, il protagonismo del popolo sono insostituibili.
C’è pluralismo quando nel seno di una società le diverse tradizioni culturali e identità si riconoscono e si aiutano reciprocamente. Proprio per questa ragione si comprende la valanga di critiche che sta ricevendo la legge Celaá sull’educazione da parte della società civile. La scuola è l’ambito nel quale si costruisce il destino di un paese e per questo è tanto importante salvaguardare la sua libertà.
***
Juan Ramón de la Serna Carbajo, autore di questo articolo, è il direttore del Colegio Internacional J. H. Newman di Madrid


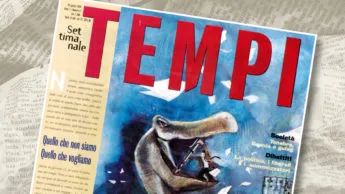
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!