
Europa e Euro. Basta leggere qualche libro per capire in che guaio ci siamo cacciati

Da qualche giorno nelle librerie elettroniche si trova il dialogo che Giulio Sapelli e io avevamo già pubblicato sul Foglio tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. Il titolo è Italia. Se la Merkel è Carlo V. Sottotitolo: “Dalla resa di Milano al sacco di Roma. 1494-1527 e 1992-2013. Moro e Cuccia, Serenissima e Berlusconi, Clemente VII e Napolitano e altri parallelismi” (Goware, 4.99 euro). Al centro del dialogo l’analogia – assunta pur sottolineando le tante irriducibili differenze tra i periodi comparati – tra la crisi degli stati italiani cinquecenteschi e quella del nostro stato unitario negli ultimi venti anni: crisi accompagnata da uno smarrimento delle élite sia nel Cinquecento sia tra il 1992 e il 2014 e da una parallela subalternità ad altri stati ben più consolidati del nostro. Non spetta a me parlare della qualità di un’opera a cui ho lavorato, mi interessa indicarne però l’obiettivo centrale: uscire da analisi centrate solo sul glamour dei singoli eventi e degli stati d’animo che ne derivano inseguendo un dover essere che produce solo luoghi comuni. Chiedersi, invece, perché e come le vicende dell’Italia abbiano preso un certo corso, e non cercare solo le colpe dei singoli o magari quelle collettive (posizione diffusa tra gli italiani anti-italiani) come se la ricerca storica fosse essenzialmente pedagogia & propaganda. E nello spiegare le nostre vicende contemporanee credo indispensabile tenere conto quanto condizionante – ben oltre altre grandi nazioni europee – sia il quadro internazionale. Anche in questo caso si tratta di astenersi dalle teorie complottistiche: i colloqui segreti, i padroni universali, i misteriosi yacht dove si decidono le sorti delle nazioni, i club esclusivi. Basta un’attenta lettura del Financial Times o del Wall Street Journal per seguire i movimenti della storia senza bisogno del buco della serratura.
Italia. Se la Merkel è Carlo V. Sottotitolo: “Dalla resa di Milano al sacco di Roma. 1494-1527 e 1992-2013. Moro e Cuccia, Serenissima e Berlusconi, Clemente VII e Napolitano e altri parallelismi” (Goware, 4.99 euro). Al centro del dialogo l’analogia – assunta pur sottolineando le tante irriducibili differenze tra i periodi comparati – tra la crisi degli stati italiani cinquecenteschi e quella del nostro stato unitario negli ultimi venti anni: crisi accompagnata da uno smarrimento delle élite sia nel Cinquecento sia tra il 1992 e il 2014 e da una parallela subalternità ad altri stati ben più consolidati del nostro. Non spetta a me parlare della qualità di un’opera a cui ho lavorato, mi interessa indicarne però l’obiettivo centrale: uscire da analisi centrate solo sul glamour dei singoli eventi e degli stati d’animo che ne derivano inseguendo un dover essere che produce solo luoghi comuni. Chiedersi, invece, perché e come le vicende dell’Italia abbiano preso un certo corso, e non cercare solo le colpe dei singoli o magari quelle collettive (posizione diffusa tra gli italiani anti-italiani) come se la ricerca storica fosse essenzialmente pedagogia & propaganda. E nello spiegare le nostre vicende contemporanee credo indispensabile tenere conto quanto condizionante – ben oltre altre grandi nazioni europee – sia il quadro internazionale. Anche in questo caso si tratta di astenersi dalle teorie complottistiche: i colloqui segreti, i padroni universali, i misteriosi yacht dove si decidono le sorti delle nazioni, i club esclusivi. Basta un’attenta lettura del Financial Times o del Wall Street Journal per seguire i movimenti della storia senza bisogno del buco della serratura.
Spunti critici e coraggiosi
Nel nostro dialoghetto abbondano i paradossi sin dal primo capitolo su Ludovico il Moro paragonato a Enrico Cuccia: una forzatura evidente. Ma anche una via per superare quel ragionare per luoghi comuni al momento predominante. Naturalmente una provocazione anche utile non è risolutiva: servono analisi e ricerche non estemporanee. Soprattutto sul nesso tra contesto internazionale-crisi del nostro stato nazionale, un nesso definito innanzitutto da come si è evoluto il processo di unificazione europea. Su questo argomento, peraltro, la fa da padrona la retorica. Così saggi come La via maestra. L’Europa e il ruolo dell’Italia nel mondo di Giorgio Napolitano e Federico Rampini (Mondadori, 2013, euro 9,99), o La democrazia in Europa. Guardare lontano di Sylvie Foulard e Mario Monti (Rizzoli, 2012, euro 9). Libri tanto edificanti quanto privi di quella analisi critica oggi necessaria per capire il guaio in cui ci siamo cacciati. Né aiuta molto il nuovo pensiero europeista di tipo radicale, sia quello di vecchi protagonisti come Daniel Cohn Bendit che insieme a Guy Verhofstadt nel 2012 per Mondadori ha fatto uscire Per l’Europa! Manifesto per una rivoluzione unitaria, sia quello proposto da più nuovi come Slavoj Zizek e Srécko Horvat con il loro Cosa vuole l’Europa? (Ombre corte, 2014), con la prefazione di Alexis Tsipras, la star del momento. Nei vecchi radicali europeisti si sente la stanchezza di un pensiero nato col nichilismo sessantottesco, divenuto furbamente ecologista e infine riproposizione di una ipersecolarizzazione sempre più sfiatata anche se ancora una delle vere anime di Strasburgo. I nuovi radicali europeisti hanno almeno la vivezza (oltre a un certo talento filosofico come con Zizek) di una storia vissuta sulla loro pelle, degli errori commessi dall’egemonia bottegaia tedesca: dalla gestione della crisi della Jugoslavia fino all’austerità che ha stremato la Grecia. Non si coglie però nel loro argomentare vera densità di pensiero tipo quella che sorresse il movimento socialista nell’Ottocento: la propaganda domina su un approccio critico, sia pure ideologicamente critico.
 Meglio in questo senso l’elaborazione di Ulrich Beck, erede di un altro colto europeista tedesco legato alla London School of Economics come Ralf Dahrendorf: in Beck si trovano analisi informate, un po’ troppo politically correct, ma con spunti critici coraggiosi come sugli eccessi di egemonia della Germania. Di Beck esce ora Europa tedesca. La nuova geografia del potere (Laterza, 10,20 euro). Di un altro livello qualitativo Questa Europa è in crisi di Jürgen Habermas (Laterza, 2012, euro 11,90): qui si sente la mente del grande filosofo che va al cuore del problema delle istituzioni continentali burocratiche (anche gli europarlamentari sono poco più che funzionari) perché prive di vere modalità che coinvolgano i cittadini.
Meglio in questo senso l’elaborazione di Ulrich Beck, erede di un altro colto europeista tedesco legato alla London School of Economics come Ralf Dahrendorf: in Beck si trovano analisi informate, un po’ troppo politically correct, ma con spunti critici coraggiosi come sugli eccessi di egemonia della Germania. Di Beck esce ora Europa tedesca. La nuova geografia del potere (Laterza, 10,20 euro). Di un altro livello qualitativo Questa Europa è in crisi di Jürgen Habermas (Laterza, 2012, euro 11,90): qui si sente la mente del grande filosofo che va al cuore del problema delle istituzioni continentali burocratiche (anche gli europarlamentari sono poco più che funzionari) perché prive di vere modalità che coinvolgano i cittadini.
Venendo all’Italia, imperdibile il nuovo saggetto di Sapelli Dove va il mondo? (Guerini, 12,50 euro): denso e coinciso il libro affronta ampi aspetti della scena globale e, per quel che riguarda i temi di questo articolo, in particolare le due linee, quella tedesca e quella americana, per affrontare la crisi post 2008, entrambe segnate da un’astrazione di fondo rispetto all’economia industriale e al contesto sociale e caratterizzate da una certa subalternità anche culturale rispetto alla finanza globale, ma almeno quella studiata a Washington mirata allo sviluppo e non alla suicida austerità predicata a Berlino. Sui guasti dell’egemonia economica tedesca scrive anche Antonio Pilati: Europa sovranità dimezzata (Ibl libri-Foglio, 2013, 10 euro). In Pilati la riflessione è centrata sulla moneta unica, come si è man mano determinato l’uso di questo mezzo da parte di Berlino per costruire la propria egemonia provocando insieme una stagnazione innanzitutto degli stati mediterranei dell’Unione.
Sul tema dell’euro il saggio più rilevante uscito nel 2013 è quello di un grande giurista italiano, Giuseppe Guarino. Già il titolo spiega la sua tesi: Un saggio di “Verità” sull’Europa e sull’euro. Sottotitolo: “1.1.1999 il colpo di Stato – 1.1.2014 Rinascita!?”. Si tratta della magistrale disamina di come fu tradita la lettera dei trattati dalla burocrazia comunitaria nella semi-inconsapevolezza degli stati membri, con poi l’analisi delle conseguenze di questo tradimento. Lo potete scaricare da Google a costo zero.
Il centenario della Grande Guerra
La discussione sull’Europa e sul suo ruolo intanto si intreccerà con la riflessione che il centenario della Prima guerra mondiale ha già aperto. D’altra parte è da tempo che nella discussione americano-anglosassone il tema della relazione delle contraddizioni tra Prussia e Gran Bretagna con quelle tra Cina e Stati Uniti è sollevato, con un grande protagonista della diplomazia come Henry Kissinger che sostiene (vedi il suo Cina, Mondadori, 2011, euro 18,70) come una relazione con il 1914 esista ma la contraddizione sia dominabile, e storici come Niall Ferguson (così in Occidente. Ascesa e crisi di una civiltà, Mondadori, 2012, euro 18,70) più pessimisti (e che lo sia 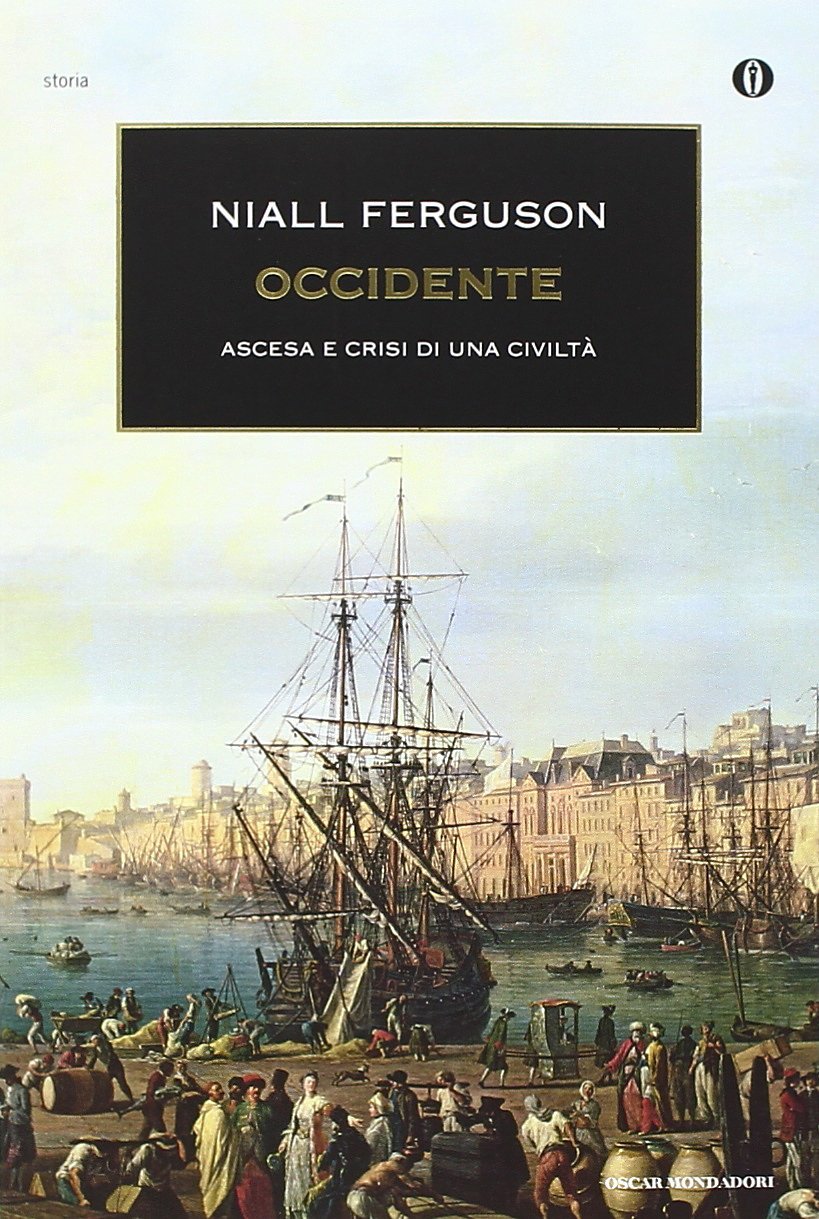 anche il giapponese Shinzo Abe anche lui riferendosi al 1914 preoccupa ancora di più).
anche il giapponese Shinzo Abe anche lui riferendosi al 1914 preoccupa ancora di più).
Ma da “atlantica” la discussione sta diventando anche molto continentale, perché una della tesi assai diffuse è che lo svilupparsi di una egemonia senza contrappesi come quella di una grande nazione come la Germania non possa non creare squilibri nel medio periodo difficili da gestire. Di questa tesi è ben consapevole Angela Merkel che ha citato uno dei più bei libri sul 1914 uscito lo scorso anno e ora tradotto anche in italiano: I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla Grande Guerra di Christopher Clark (Laterza, 29,75 euro). Lo ha fatto quasi per esorcizzarlo, anche se l’attenzione nel libro per l’ipertrofia prussiana è centrale.
A sostegno delle tesi della cancelliera è uscito 1914: attacco a Occidente di Gian Enrico Rusconi, (il Mulino, 2014, 20,40 euro), lanciato da Paolo Mieli sul Corriere della Sera del 4 marzo scorso. Scrive Mieli che «La Germania del 2014, mette in chiaro Rusconi, “non ha nulla in comune con quella del 1914 salvo l’eccellenza economica, ma in un contesto internazionale e geopolitico inconfrontabile; il processo della sua integrazione europea e occidentale è irreversibile, a meno di imprevedibili disastri; se esiste un problema tedesco, è perché esiste un problema europeo, ma questo a sua volta non può essere adeguatamente compreso con l’apparato concettuale tradizionale con il quale abbiamo analizzato le vicende che culminano nella Grande Guerra”». Come sempre, in Mieli (e di riflesso in Rusconi) c’è grande intelligenza analitica e giusta critica del becerume semplificatorio, ma c’è pure indifferenza per i rapporti di forza tra nazioni, con annessa olimpica disattenzione per un’anche minima sovranità dell’Italia.
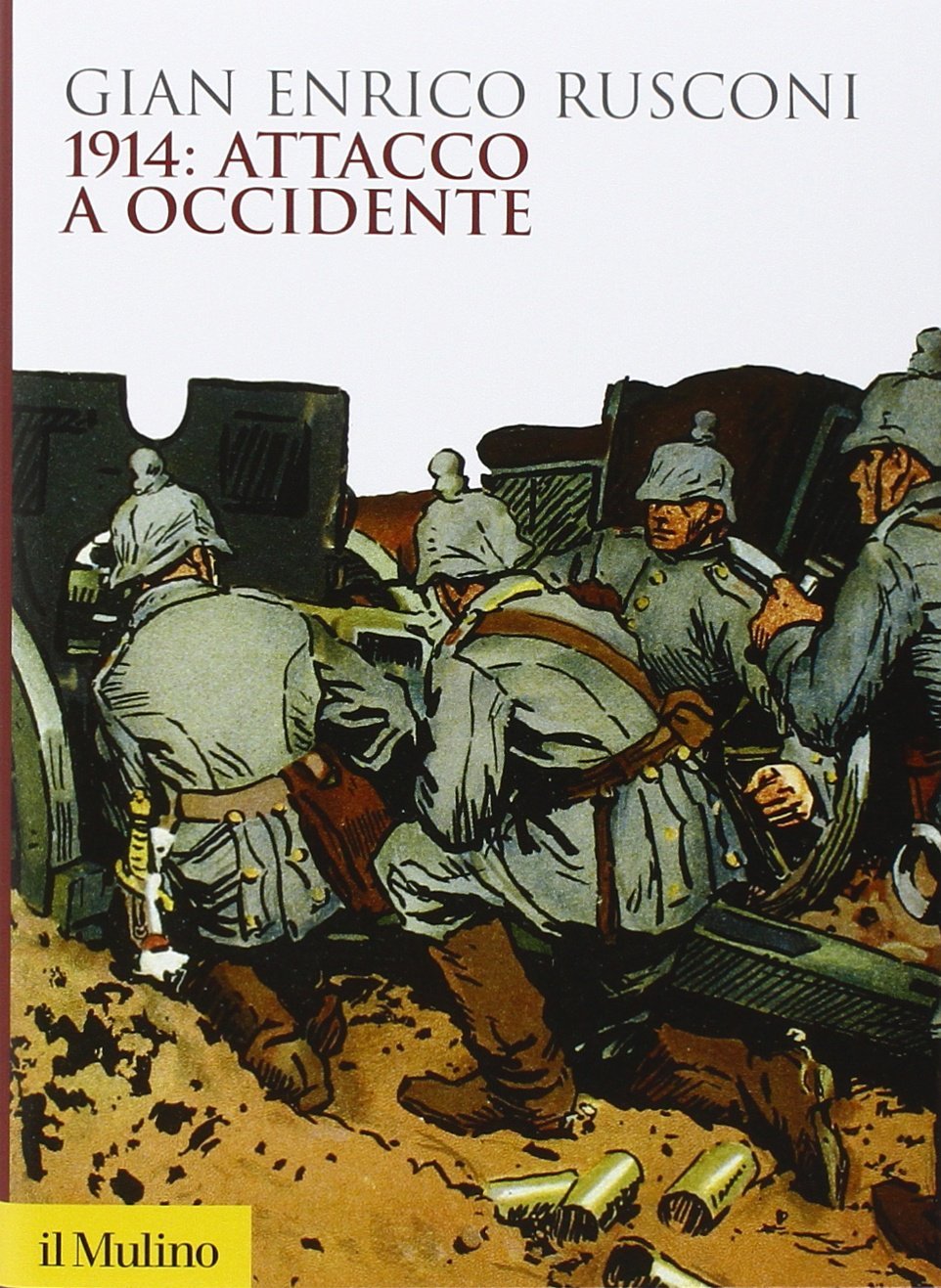 Per risvegliare le coscienze
Per risvegliare le coscienze
In questo senso, pur respingendo tesi comparative stupidamente semplificatrici, non si può rinunciare a investigare i problemi che pone l’eccesso di egemonia della Germania anche oggi. Molto più di Mieli ci sembra interessante quel che scriveva un gran filosofo hegeliano, un po’ bonapartista e poi gollista (nonché consigliere dell’Europa in formazione) come Alexandre Kojève che in L’impero latino (ripubblicato nel Silenzio della tirannide, Adelphi, 2004, 25 euro) discuteva già nel 1947 di come la Germania sarebbe ridiventata la principale potenza economica europea; riducendo la Francia al rango di potenza secondaria nell’Europa continentale; che gli stati-nazione erano finiti; che c’era bisogno di “imperi”. Ma alla base di questi imperi non ci poteva essere un’unità astratta che prescindesse da cultura, lingua, modi di vita e religione: i nuovi imperi dovevano essere «unità politiche transnazionali, ma formate da nazioni apparentate». Per questo, egli proponeva alla Francia di proporre un “impero latino”, che unisse economicamente e politicamente le tre grandi nazioni latine (Francia, Spagna e Italia). Tesi al limite del paradosso, ma certamente che aiuta a fare i conti con quel politically correct che addormentando le coscienze, genera mostri.
Articoli correlati
1 commento
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

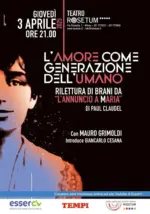
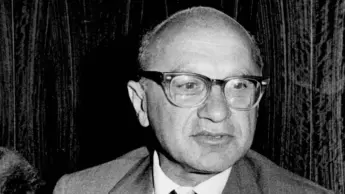
Lodovico Festa for president: yes we can!!!