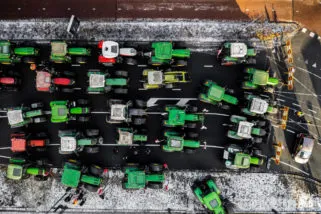
Essere nel bel mezzo


Ci fu quella volta che un amico disse che detestava Una vita da mediano di Ligabue e io non fui capace di ribattere in modo efficace. Sosteneva che era un inno al ribasso, ad accontentarsi e non avere grandi sogni; non ero d’accordo e rimasi a rimuginare qualcosa che ruotava attorno al ricordo del mio calciatore preferito, Alessandro Bianchi, un invisibile nome comune nell’Inter dei grandi cognomi, Zenga – Bergomi – Mattehus. Fu il suo modo di stare a centrocampo in modo creativo e generoso a suggerirmi che il mediano non è mediocre. O forse a convincermi che mediocre non è una brutta parola. Essere nel bel mezzo di qualcosa, si dice. Stare in mezzo è bello, dunque.
«Tutti vogliono un fenomeno», canta giustamente Fibra, ma forse il mai dimenticato Medioman di Fabio De Luigi è un vero supereroe e non la parodia delle quotidiane ovvietà. Ho un puzzle di nomi nella testa, tanti pezzetti di storie che raccontano che stare «sempre lì, lì nel mezzo» è un’impresa da giganti. Ci sono i miei figli, Dante, Niccolò Fabi, Jutta Von Sponheim e Frodo Baggins; ce ne sono molti altri, ciascuno completerà questa provvisoria lista di mediani a modo suo.
La scena si apre sul sempre caotico momento della cena, quando mio marito tarda ad arrivare a casa, intorno a me frullano tre bambini agitati e io devo inventarmi qualcosa con quel che resta nel frigo. La serafica pazienza va a farsi benedire perché, proprio quando mi dirigo verso il lavello con una pentola piena di acqua bollente, un figlio a caso mi taglia la strada, rischio di ustionarlo e finisco per gridare: «Sei sempre in mezzo!». La spontaneità è lo specchio dell’anima, verrebbe da dire, e nell’anima bazzicano pensieri non solo angelici. Il mio grido parte da lontano, da quando facevo finta di non voler ammettere che i figli sono stati un’obiezione ai miei sogni. Si sono messi in mezzo, quando io ero nel mezzo del mio cammino.
Anche Virgilio tagliò la strada a Dante e lo tirò fuori dalla selva oscura. Il buio, spesso, è essere in mezzo alle vicende, cioè non essere né all’inizio né alla fine, stare a galla nel pantano della normale routine; allora sì è benedetto che qualcuno si metta in mezzo, perché solo un ostacolo ci costringe a cambiare strada o prospettiva e dunque a svegliarci. La rotta tracciata dai nostri desiderata non sempre è il meglio per noi, tanto che quel matto di Don Chisciotte faceva decidere le sue avventure al cavallo, il quale ogni giorno prendeva la strada che voleva.
In mancanza di un cavallo ci sono imprevisti a non finire. I miei tre piccoli cavallini domestici che trottano tra le mie gambe nei momenti meno opportuni mi hanno portato dove non volevo, ma adesso che ci sono non vorrei essere in nessun altro posto. Fin troppo a lungo sono stata vittima dei lustrini inconsistenti di «talento» e «meritocrazia» legandoli indissolubilmente alla felicità. Spiccare non è per forza sinonimo di soddisfazione gioiosa, c’è una lieta pienezza mentre si svolge un compito semplice, invisibile, necessario.
L’entusiasmo è tipico dell’inizio, il compiacimento arriva raggiungendo un traguardo, ma cosa succede per tutto il tempo che la palla è in gioco a centrocampo tra un pressing vigoroso e passaggi imperfetti? Tutte le sudate finiscono nel dimenticatoio quando l’attaccante finalizza il gioco? Sono solo un noioso pedaggio da pagare? Il mediano è solo una comparsa? Devo molto a Niccolò Fabi che ha risposto a tutte queste domande con una sola canzone, anch’essa legata in modo convincente alla felicità. Costruire mette a tema il variegato mondo di meraviglie che si apre a chi sta davvero in mezzo alle cose che vive. L’inizio è esaltante, il finale è teatrale, ma «nel mezzo c’è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire è potere e sapere rinunciare alla perfezione».
Perfetto è qualcosa di finito e dunque intoccabile; perfetto è inumano perché non è vivo. L’imperfetto scalcia, si lamenta, sbuffa ed perciò pienamente umano nella sua vivacità; è in corso d’opera; è attesa attiva; è fatto di tanti tentativi ed è per questo la fucina della felicità. Si può semplicemente essere felici mentre le vicende si spalancano con i loro paradossi, felici di mettere mano al vivo del mondo, scommettendo un’ipotesi da raggiungere – uno scopo – e godendo di avere un’occasione per battersi in suo nome. Godere anche della fatica e della noia, senza buttarle nel secchio dell’indifferenziata.
Tutti i pezzetti di questo puzzle sono diventati delle premesse indispensabili grazie a cui ho potuto incontrare la vera protagonista di questo mio discorso: Jutta Von Sponheim. Il libro di Lucia Tancredi Ildegarda, la potenza e la grazia è un viaggio in un mondo bistrattato, quello della clausura. La Tancredi spezza ad uno ad uno i pregiudizi con parole che dipingono una vita vissuta in pienezza, quella che noi – anime sperse nei centri commerciali – ci sogniamo. Jutta è un angelo in carne ed ossa, fu badessa del monastero di San Disibod e tutrice di Santa Ildegarda, nei secoli tutt’altro che bui del Medioevo. Fu destinata al convento e questo è uno squarcio della sua vita: «Suo padre aveva fatto costruire per lei, addossata alla chiesa, una cella di clausura da alcuni chiamata sepulchrum, da altri ergastulum. Aveva, questa cella, tre finestre: una comunicava con la chiesa, una con un parlatoio dalla cui grata chiunque poteva ricevere una parola o una benedizione. L’altra era la sua specola specialissima sul cielo. Per molti anni non vidi mai Jutta uscire da quello che pure ai monaci pareva un sepolcro murato.
Certe gabbie mettono disordine nell’animo. Altre, al contrario, operano e agiscono per forza di levare. Levano materia, calce e mattoni, sgomberano il campo visivo. […]. Da quel momento Jutta non si era più separata dal suo Bene, da quel centro che aveva trovato dimora nella cella. La sua vera gioia era nel tacere, in quel soccombere alla ragione, nel guardare il cielo incollandolo agli occhi, nell’ascoltare i casi della gente – disgraziati che le gettavano addosso le miserie e i guasti del mondo di fuori» (Lucia Tancredi, cit., pp. 36-37).
Jutta è il mediano di spinta, chiusa tra una finestra sui lamenti umani e una sui colori muti del cielo. Lei ascolta. C’è una finestra sulla disperazione e una sulla speranza: da una proviene il grido della gente comune che le rovescia addosso il dolore di vivere, dall’altra arriva il messaggio che il Creatore ha scritto nelle nuvole e sulle stelle. Lei sta nel mezzo tra il finito e l’infinito. Si trova in una cella che è nel bel mezzo del mistero umano: trovare una strada dall’inferno al paradiso. È un’ergastolana convinta, sta lì a pressare l’avversario del mondo senza sapere né l’inizio né la fine delle storie della gente che implora il suo aiuto. È tosta, Jutta.
Eppure non è tutto rose e fiori, non è affatto facile, mentre lo si fa. Ricordo la domanda tremenda che la Madonna pose al re Alfred del Wessex in poema di G. K. Chesterton: «Sai provar gioia senza un motivo, dimmi hai fede senza una speranza?». Su questo pilastro fondante si separa il coraggioso dallo stupido. Sai conservare la fede nel bene anche se tutti i tuoi sforzi, alla fine, dovessero finire in malora? Continui ad aggrapparti lietamente al tuo ideale anche quando le circostanze ti precipitano in una situazione disperata? È l’esito di ogni azione o il tuo ideale di bene che sostiene e dà senso alla fatica quotidiana? È tosta pure la Madonna.
Le sue parole tonanti sono una scossa per l’anima, indicano una strada attraente ma vertiginosa; per fortuna ci sono altre parole sussurrate che fanno compagnia lungo la strada, pronunciate da due piccoli amici sperduti nel grande regno dell’ombra. Nella trilogia di Tolkien ho sempre preferito il libro di mezzo, Le due torri. Frodo e Sam sono messi a dura prova, non hanno l’entusiasmo impavido dell’inizio e non sanno come finirà la loro impresa, anzi ogni cosa sembra suggerire che stiano andando verso morte sicura.
Quando sento su di me l’ombra pesante della disperazione, anche per eventi non così clamorosi, vado a rileggermi il capitolo Le scale di Cirith Ungol de Le due torri. È ombra e salita ovunque, lì; Frodo e Sam sono stremati. Eccoli farsi compagnia in un momento cupo per entrambi:
«”Nulla di tutto ciò che mi circonda mi piace – disse Frodo – sasso o gradino, vento o macigno. Terra, aria, acqua, paiono tutte maledette. Ma questo è il nostro sentiero”.
“Sì, così è – disse Sam – e noi non saremmo qui, se avessimo avuto le idee un po’ più chiare prima di partire. Ma suppongo che accada spesso. Penso agli atti coraggiosi delle antiche storie e canzoni, signor Frodo, quelle ch’io chiamavo avventure. Credevo che i meravigliosi protagonisti delle leggende partissero in cerca di esse, perché le desideravano, essendo cose entusiasmanti che interrompevano la monotonia della vita, uno svago, un divertimento. Ma non accadeva così nei racconti veramente importanti, in quelli che rimangono nella mente. Improvvisamente la gente si trovava coinvolta, e quello, come dite voi, era il loro sentiero. Penso che anche essi come noi ebbero molte occasioni di tornare indietro, ma non lo fecero. E se lo avessero fatto noi non lo sapremmo, perché sarebbero stati obliati. Noi sappiamo di coloro che proseguirono, e non tutti verso una felice fine, badate bene; o comunque non verso quella che i protagonisti di una storia chiamano una felice fine. […] Chissà in quale tipo di vicenda siamo piombati!”.
“Chissà! – disse Frodo – Io lo ignoro. È così che accade per ogni storia vera. Prendine una qualsiasi fra quelle che ami. Tu potresti sapere o indovinare di che genere di storia si tratta, se finisce bene o male, ma la gente che la vive non lo sa, e tu non vuoi che lo sappia”».
Perché, Frodo – Tolkien, mi dici così? Perché non vogliamo che il protagonista sappia dove e come andrà a finire? Forse perché questo è il privilegio di un avventuriero, godere del tremito di poter perdere tutto e perciò amare più intensamente ogni persona o cosa che si vorrebbe salvare. Essere nel bel mezzo.



1 commento
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!