
Dentro il trauma senza smarrirci

Articolo tratto dal numero di novembre 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
Sono passati otto mesi dalla sera più buia della prima ondata, quando i cancelli del cimitero di Bergamo si sono aperti e i camion dell’esercito carichi di bare hanno iniziato la triste e silenziosa processione: volgeva a notte il 18 marzo e l’Italia atterrita assisteva al corteo dei morti della città falciata dal virus; l’immagine – hanno scritto in tanti – sarebbe entrata nella storia del paese. Ma cosa è avvenuto dopo? Come hanno fatto lo sgomento e il richiamo alla responsabilità a tradursi nella feroce caccia al colpevole, responsabile di contagi e punizioni collettive, la paura, quando non l’invito alla delezione, a diventare l’arma principe sguainata contro la pandemia?
Ha parlato di «grande trauma collettivo» lo psichiatra Eugenio Borgna guardando per Vita e Pensiero alle nostre esistenze private di strette di mano, carezze, la possibilità di avvicinarsi ad una persona amata, o amica. Un trauma che non si è spento nemmeno quando il virus sembrava aver perso vigore: l’isolamento aveva piantato radici alimentate dalla paura del contagio e da una morte che i media ci avevano fatto conoscere «lacerata nella sua dignità, e nella sua riservatezza, una morte slabbrata e reificata», «la dignità e la pietas non erano più presenti nelle immagini che scorrevano sugli schermi: l’umano torturato e sfregiato da qualcosa di radicalmente estraneo al senso della morte che è l’altra immagine della vita».
Il bacio al lebbroso
Sono passati mesi, eppure, afferrati dalla stessa paura, continuiamo a vivere in emergenza, ad affidarci alla sola speranza di un vaccino e a curarci nell’attesa proprio con l’isolamento. Come è possibile non soccombere a un orizzonte di vita e salvezza dipendente dal “dato” – non dono ma conteggio, di infetti, morti, ricoverati – e dalla scienza? «Un trauma collettivo, scandito dall’isolamento e dalla paura di una morte ferita e slabbrata, è dilagato nei primi mesi dell’anno, ed è risorto oggi con una veemenza improvvisa e tumultuosa, ostinata e febbrile», ripete a Tempi Borgna, primario emerito di Psichiatria dell’Ospedale Maggiore di Novara e libero docente in Clinica delle malattie nervose e mentali all’Università di Milano. «Sì, da questo trauma collettivo non si esce se non insistendo nell’isolamento e nelle mascherine, e attendendo il vaccino salvifico. Tuttavia la paura è utile al fine di evitare quelle che possono essere le fonti di contagio, ma non è più utile quando diviene una paura anonima, diffusa, generalizzata e bruciante nei suoi roveti ardenti, che accresce crudelmente la consistenza del trauma collettivo. Nell’attesa che giunga una cura che ancora non c’è, non lasciamoci sommergere dalle grandi ondate di questa paura incontrollata che ci fa stare male, molto male, anche senza essere contagiati».

Eppure la paura è entrata di diritto nell’arsenale del governo per fronteggiare la pandemia, la mascherina un simbolo quasi religioso. Stupisce negli appelli di politici e medici a custodire il prossimo la «dissimetria» tra l’eroe di un tempo, che esponeva la propria vita per proteggere quella degli altri, e l’eroe odierno, che per proteggere la propria vita e quella degli altri deve evitare di esporsi al prossimo: ne ha scritto in questi esatti termini Fabrice Hadjadj al Figaro: «Ieri ammiravamo il bacio al lebbroso. Oggi promuoviamo il gesto barriera». Non è facile rispondere a una domanda sul destino che ci attende, spiega Borgna, che come il filosofo francese tiene a precisare che il contraltare alla barriera non è mai l’apologia del rischio: «La mascherina è obbligatoria, questo è il gesto che tutti vediamo, ma il suo significato cambia nella misura in cui la riconosciamo necessaria, o meno. Se la consideriamo necessaria, non faremmo fatica nel tenerla in volto, e risponderemmo responsabilmente ad un dovere radicale. Questo, direi, è chiaro, ma cosa dire della dissimmetria di cui si parla nel grande quotidiano francese? Sì, per proteggere la nostra vita, e quella degli altri, non possiamo oggi non mantenere le distanze, ma il bacio ad un lebbroso non ci avrebbe contagiati anche ieri? Ancora: nei mesi scorsi un sacerdote ha sacrificato la sua vita per proteggere quella di una persona più giovane, alla quale ha donato il suo respiratore, salvandola. Cosa vale in questi casi la metafora della dissimmetria?».
Martina, Giuseppe, i banchi vuoti
L’abnegazione si intreccia al grande tema del sacrificio: tutti abbiamo da perdere qualcosa dalla pandemia ma non tutti temono di perdere la stessa cosa. Chiediamo a Borgna a questo proposito cosa suggeriscano a lui tre immagini erette dalla stampa a simbolo della seconda ondata. La prima è il selfie di Martina Ricci, infermiera del reparto Covid del Cardarelli di Napoli che con i segni dei dispositivi di protezione sul viso sfida chi nega il virus: «Vi farei assistere a un nostro turno, vedere i pazienti, i loro occhi che implorano aiuto, vi farei tornare a casa come torno io con i segni e con la tristezza per le persone che non hanno resistito». «Non si è infermieri, e non si è medici, se in un ospedale non ci si confronta con i pazienti, senza immedesimarci nel loro dolore e nella loro angoscia, nella loro tristezza e nella loro disperazione», commenta lo psichiatra. «Così è sempre stato, ma in questi mesi di coronavirus infermieri e medici non si sono solo presi cura dei loro pazienti, bensì hanno sempre corso il pericolo di ammalarsi anche loro. Se in passato non è mai avvenuto, oggi continua ad avvenire. Si entra in ospedale, e prima ancora di vedere una paziente, o un paziente, non si è sicuri di non essere contagiati; e nondimeno non si sfugge al dovere di entrare in una corsia, o in una stanza, con coraggio, e con determinazione. Le parole, e ancora di più il volto lacerato dal dolore e dalla tensione febbrile, di Martina Ricci mi dicono la sua indicibile altezza morale, e la sua meravigliosa determinazione, che sono quelle delle sue colleghe, e dei suoi colleghi. Manteniamo viva nel cuore, e nella memoria, la sua immagine esile, e luminosa, mite, e sconsolata».
Di contro c’è la foto scattata da Elena Tonon al padre Giuseppe, titolare di un ristorante nel Trevigiano: siede da solo all’ingresso con lo sguardo sconfitto e la mascherina slacciata, ha saputo che dovrà chiudere il locale alle 18. «È la mazzata finale», ha detto alla figlia, che si sfoga: «Non ci sto. Non siamo gente che va a dire in giro che il Covid non esiste, siamo gente che ha sempre avuto una dignità. E la rivogliamo. Ce la faremo papà». In questa immagine, «nella solitudine che la contrassegna dolorosamente di Giuseppe Tonon, padre di Elena, si colgono lo sguardo desolato e l’atteggiamento rassegnato di una persona seria e gentile, che sta perdendo il lavoro, ed è solo su una sedia in un locale con tante luci che sono ormai inutili. La sua immagine e le sue parole mi fanno ricordare le tante persone, anziane e non anziane, che in questi mesi e in queste settimane hanno perduto il lavoro, e hanno temuto di essere contagiate. Le parole di Elena mi dicono nondimeno che la speranza, una fragile speranza, continua a non morire nel loro cuore».
Poi c’è la terza immagine, quella terribilmente asettica di una classe dell’istituto professionale Buontalenti di Firenze: sono appena arrivati i banchi nuovi scintillanti, monoposto e con le rotelle, ben disposti e distanziati ma vuoti. Prima dei banchi è arrivato il virus e gli studenti sono a casa. Una foto che secondo Borgna «dice come i nostri progetti, quelli nella vita quotidiana, e quelli dalle conseguenze enormemente più gravi nella vita politica, possono franare da un momento all’altro, e anzi prima ancora che abbiano ad incominciare. Come non essere immersi in un grande sconforto pensando alle disillusioni e agli smarrimenti, alle inquietudini dell’anima e alla ribellione degli studenti, a casa in quarantena, senza che sappiano quando sia possibile riprendere le lezioni».
Qualcosa può germogliare
Dolore, solitudine, smarrimenti: tutte e tre le immagini sono state diffuse riportandoci alla responsabilità, uno dei concetti più abusati durante la pandemia da politici, virologi, medici, giornalisti. Responsabilità come sinonimo di colpa. Chi si ammala, perde il lavoro, è in quarantena, non è mai in una posizione neutra: o è vittima dell’irresponsabilità altrui o è a sua volta un irresponsabile che diffonde l’infezione. «Non è facile», osserva lo psichiatra, «definire una parola, come questa di responsabilità, che oggi dilaga nel linguaggio politico e sociale, giornalistico e filosofico, con significati che cambiano vertiginosamente di cultura in cultura. Seguendo la sua etimologia, responsabile è una azione che germoglia da scelte consapevoli di quelle che ne siano le conseguenze, e allora tenere in volto una mascherina, e tenere le distanze, sono azioni responsabili perché, solo facendole, evitiamo di contagiarci e di contagiare gli altri. La colpa la dovremmo sentire se rifiutiamo di compiere azioni, come queste, che dicono cosa sia responsabilità». Tutto sta nel seguire le regole senza divenire prigionieri di un trauma collettivo, «che ci renda estranei alla amicizia e alla solidarietà, alla accoglienza e alla ospitalità, alla gentilezza e alla tenerezza, e alla speranza». Come ha già ricordato Borgna citando George Bernanos, «dalla disperazione non può forse germogliare una nuova speranza che come un ponte mette in contatto la nostra speranza con quella di chi la abbia perduta?».


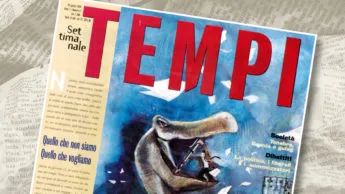
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!