
È proprio davanti a Brunetto Latini che Dante ci spiazza di più

È arrivato e se n’è andato il Dantedì, e ognuno ha avuto il suo Dante Alighieri. Quello di chi ha ripetuto ancora una volta che è lui che ha fatto l’Italia, e quello di chi ha scritto che è l’Italia che ha fatto Dante. Giustamente il direttore di Tempi ha bacchettato tromboni e mistificatori, annidati ovunque. Il mio Dante è più intimo, più prossimo alle ferite della memoria. Me lo ha ridischiuso la lettura dello Zibaldino di un prof in quarantena di Matteo Saccone, dove a un certo punto si evoca il canto XV dell’Inferno, quello dove l’Alighieri incontra il suo maestro di lettere in vita, Brunetto Latini.
Un Dante fuori dagli schemi
In questi giorni da più parti è stata evocata una presunta modernità del sommo vate, che trasparirebbe dal fatto che colloca all’inferno (e in purgatorio) papi morti e papi ancora in vita, dimostrando un’autonomia intellettuale molto lontana dall’immagine del cattolico che rinuncia al senso critico per sottomissione al vertice ecclesiastico, o nel fatto che mostra complicità emotiva con adulteri come Paolo e Francesca e consacra le loro figure per l’eternità, destino a cui le cronache del tempo non li avrebbero certo consegnati. A ciò farebbe da contrappunto il Dante arcigno medievale, che condanna a correre sotto una pioggia di fuoco i sodomiti e gli eretici a giacere in sepolcri percorsi da fiamme inestinguibili.
In realtà proprio nel XV canto, quello che descrive la punizione dei sodomiti, succede qualcosa che è totalmente fuori da qualunque schema, che esula dalle dicotomie moderno/medievale, buonista/intransigente, eccetera. Qualcosa che forse risultava incomprensibile ai suoi tempi e ancora più lo risulta oggi: Dante mostra un affetto inestinguibile per un dannato; manifesta vera gratitudine e sincera devozione per un’anima infernale, al punto di accennare una carezza al suo volto e di tenere la faccia rivolta verso il basso in segno di deferenza.
La gratitudine al maestro Brunetto Latini
Nella Commedia il fiorentino non parla mai di suo padre (del bisnonno e del trisavolo sì), ma di Brunetto Latini dice:
«[…] ’n la mente m’è fitta, e or m’accora,/ la cara e buona imagine paterna/ di voi quando nel mondo ad ora ad ora/ m’insegnavate come l’uom s’etterna:/ e quant’io l’abbia in grado, mentr’io vivo/ convien che ne la mia lingua si scerna».
Che io personalmente parafraso così: nella mia mente è viva e mi commuove la cara e buona immagine paterna di voi che mi insegnavate come l’uomo realizza il suo destino, e quanto io vi sia grato di ciò, fino a quando sarò in vita lo si saprà perché continuerò a ripeterlo.
Il bene compiuto in vita resta
Insomma, Dante riconosce un’eterna paternità spirituale nei suoi confronti a un uomo che soffrirà eternamente le pene dell’inferno, un uomo da cui sarà separato per sempre (Caronte gli ha predetto il purgatorio dopo la morte). Dante ha perduto il suo maestro Brunetto Latini definitivamente, perché alla prima morte si è aggiunta la morte seconda, dalla quale non c’è resurrezione. La malvagità dell’intellettuale fiorentino è stata giudicata tale in modo definitivo, non c’è più speranza di ricongiungimento fra padre (spirituale) e figlio, la separazione è definitiva.
Ma il bene che Brunetto ha compiuto in vita resta, non va perduto, è integrato alla persona stessa di Dante, e di ciò lui è eternamente grato; e questa gratitudine si traduce in un durevole sentimento di tenerezza nei confronti dell’antico maestro. Un sentimento che non si traduce in protesta nei confronti di Dio per la durezza del giudizio finale: Dante dice che se avesse il potere di realizzare i suoi desideri, Brunetto sarebbe ancora in vita; non dice che sarebbe in paradiso: la giustizia del giudizio di Dio è indiscutibile al punto da non sollevare nessun sentimento di avversione nel “figlio” che ha perduto il padre.
Il Dante che sento più mio
Il bene compiuto in vita dai malvagi è salvato; i dannati non sono salvi, ma il bene che hanno fatto sì: transita nell’eternità beata insieme alle persone che lo ricevettero, e permane nell’eternità dannata insieme a chi lo ha compiuto. Se mai Hitler si è chinato a sollevare un bambino caduto a terra, se mai Stalin ha consolato una madre, se mai Mao Zedong ha sostenuto un anziano che faticava a camminare, tutto questo bene continua a palpitare eternamente anche nelle profondità dell’inferno.
Perché questo è il Dante che sento più mio, il più intimo alle ferite della memoria? Perché, come molti altri, non mi rassegno all’apparente fatalità che il bene fatto e ricevuto venga meno insieme ai rapporti che l’hanno generato. Non mi rassegno alla parabola per cui la fine di un amore, di un’amicizia, di una comune appartenenza consegna alla dimenticanza il bene che le persone si sono scambievolmente fatte, lo rende irrilevante, lo cancella come se non ci fosse mai stato.
Il bene travolto dal male
Quasi sempre, quanto più intensi e importanti sono stati l’amore, l’amicizia, la comune appartenenza, tanto più forti sono il rancore, la delusione, l’estraneità che ne segue. Poi il tempo, nuovi incontri e nuove esperienze rimarginano le ferite e la vita ritrova senso e scopo. Ma quante volte pensiamo agli amici non più amici, all’amata non più amata, ai fratelli non più tanto fratelli come a persone che ci hanno fatto anche tanto bene e verso le quali perciò nutriamo sentimenti di gratitudine, benché le rotture intervenute le abbiano rese irraggiungibili?
Ci pensiamo raramente o mai perché il pensiero del bene ricevuto è immediatamente sovrastato dal dolore che il concomitante ricordo della rottura, della fine dell’amicizia o dell’amore, rinnova. Non si riesce a rievocare il bene senza rievocare la crisi e il disincanto, con la cascata di sentimenti dolorosi e odiosi che hanno comportato.
C’è una via di uscita da tutto questo? Io credo che ce ne siano due. Entrambe hanno in comune un elemento: l’attenzione non è concentrata sul ricordo dei bei momenti vissuti, ma su qualcos’altro.
Ma in Dio nulla è perduto
L’attenzione, per prima cosa, va concentrata sui durevoli cambiamenti che quei rapporti, interrotti e finiti per sempre, hanno prodotto in noi. Ci sono tratti della nostra personalità, virtù, propensioni che sono state modellate dalla lieta familiarità e dall’appassionata frequentazione con coloro che poi abbiamo perduto. Come la statua tratta da un blocco di marmo resta tale nel suo splendore anche dopo la morte dell’artista che l’ha scolpita, così per molti aspetti la nostra anima – se non siamo stati troppo egoisti e narcisisti nei nostri rapporti – porta la duratura impronta dell’amore dato e ricevuto. Questa constatazione è un motore potente di gratitudine e di tenerezza verso chi è stato all’origine di questo, ma non ne ha più consapevolezza.
E in secondo luogo, con la stessa fede di Dante possiamo comprendere che tutto il bene compiuto a questo mondo, anche quello fatto dai cattivi, è al sicuro fra le braccia di Dio. Non è perduto. Come scrive Saccone:
«Se Dio non ci fosse, il bene che gli uomini fanno svanirebbe con loro, al massimo durerebbe quanto dura la memoria dei beneficati. I frustoli di bene, poi, che non mancano nemmeno nelle vite più sciagurate, andrebbero sicuramente perduti. Ma Dio c’è. E nulla va perduto. Uno sguardo cattolico è pieno di questa consapevolezza, e Dante – che ce l’ha – può contemplare con totale rispetto, anzi con tenerezza, il viso deturpato del suo vecchio maestro».
Il frutto del sacrificio
Tante volte, per spiegare il coraggio dei martiri della fede e dell’ideale che ho incontrato nel corso della vita, ho citato il famoso brano del Vangelo di Giovanni: «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12, 24). Sempre insistendo che senza sacrificio il bene non prolifera, che le giustificazioni per scansare la testimonianza fino al martirio servono solo a produrre carestia spirituale.
Solo da poco mi sono reso conto che il sacrificio, da solo, non è sufficiente: non è sufficiente che il seme muoia, occorre che ci sia la terra, che ci sia buona e fertile terra ad accogliere il suo sacrificio. E questa buona terra altro non è che Dio stesso. Dio che parla nella coscienza degli uomini raggiunti dalla notizia del sacrificio del seme. Dio in cui tutto sussiste, e in cui il bene continua a sussistere anche quando sembra che sia svanito.
È attraverso queste due vie che possiamo ritrovare la gratitudine e la tenerezza verso l’amico, l’amata, il fratello nella fede perduti. E sentire misteriosamente in noi la loro voce che, come Brunetto Latini a Dante, ci dice ancora:
«Se tu segui tua stella,/ non puoi fallire a glorioso porto».


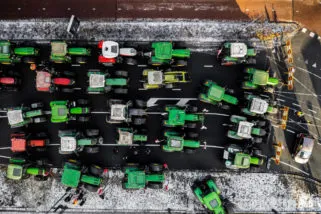
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!