
Dateci una bussola per questi tempi malconci. Dateci un’amicizia civile

 Non è una lettura facile, il libretto Un’amicizia civile di Pietro Lorenzetti. Eppure conviene addentrarvisi per non perdere alcune perle preziose. Non è nemmeno un saggio. È piuttosto a metà strada tra la raccolta di riflessioni, articoli e diario personale. Soprattutto, è un cammino partecipe, personale e pensoso dentro la crisi contemporanea, alla ricerca di una bussola che possa tenere assieme gli uomini dentro questa società malconcia. Forse è, ancora di più, l’espressione personale dell’autore di un suo bisogno reale di essere partecipe di una “amicizia civile” che provi a ricostruire là dove l’ideologia e profitto per il profitto hanno lasciato deserti.
Non è una lettura facile, il libretto Un’amicizia civile di Pietro Lorenzetti. Eppure conviene addentrarvisi per non perdere alcune perle preziose. Non è nemmeno un saggio. È piuttosto a metà strada tra la raccolta di riflessioni, articoli e diario personale. Soprattutto, è un cammino partecipe, personale e pensoso dentro la crisi contemporanea, alla ricerca di una bussola che possa tenere assieme gli uomini dentro questa società malconcia. Forse è, ancora di più, l’espressione personale dell’autore di un suo bisogno reale di essere partecipe di una “amicizia civile” che provi a ricostruire là dove l’ideologia e profitto per il profitto hanno lasciato deserti.
«La nostra convivenza sociale è mancante, bisognosa di uno scopo ideale, di un motivo per lavorare che possa essere oggetto di esperienza comune, fattore di costruzione e di solidarietà», scrive Lorenzetti, in una proposta di “manifesto” per un’amicizia cristiana dentro il lavoro. Aggiunge poco oltre che «la parola amicizia – al di là di tutte le riduzioni possibili – ha valenza e dignità sociale perché indica l’origine personale di una solidarietà che può essere senza confini. Non possiamo aspettarci da una razionalizzazione tecnocratica o da un programma precostituito e imposto dall’alto la risposta ai problemi della nostra società».
Nella ricerca di come possa dunque accadere un’amicizia che abbia i connotati plausibili e suggestivi per mettere assieme persone al di là degli schemi politici e ideologici, l’autore passa anche in rassegna ai legami tra amicizia e amore e ai rischi semantici ai quali è inevitabilmente soggetta la parola, così come altre. Ad esempio fraternità. Nel capitoletto “distinzione terminologica”, un provocatorio “amicizia versus compagnia”, in realtà senza contrapporle, chiarisce però acutamente i limiti di una possibile riduzione concettuale della pur bellissima “compagnia”: segnare un confine tra chi è dentro e fuori, oppure tutelare gli interessi dei compagni a dispetto del bene pubblico.
La contrapposizione in realtà è falsa, si affretta a chiarire il nostro, che tuttavia usa l’analisi terminologica per segnalare la sua preferenza alla parola amicizia, perché implica più nettamente il movimento della persona.
Come annota acutamente nella premessa Mauro Magatti, parlare di amicizia civile di questi tempi è perlomeno inattuale. La disgregazione impera nei rapporti umani ad ogni livello, la sfiducia tra persone e istituzioni galoppa; ci vuole perciò del coraggio per proporre questa prospettiva. Eppure, conviene Magatti, anche istituzioni e imprese funzionerebbero meglio se, alla base, ci fosse una ripresa poco alla volta di responsabilità personale tra le persone, assieme, liberi e nella concretezza dei passi. Esiste, per Lorenzetti, anche qualche prova che sia possibile, nonostante quanto registrava Magatti della situazione contemporanea.
Tra i “casi pratici” l’autore cita quanto avvenuto in Emilia tra le persone colpite dal terremoto. Si potrebbe altrimenti rileggere la crisi dell’università e la sua apparente irriformabilità, con Lorenzetti, come necessità di ripartire dal rapporto umano tra persona e persona, imparando la drammatica lezioni di persone che, altrove nel mondo, sono disposti a morire per la verità.

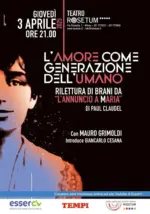
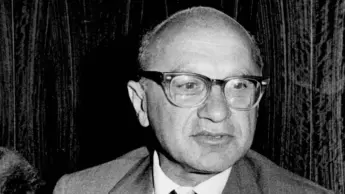
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!