
Sotto il Cielo di Dante brilla un perdono sconosciuto ai pagani

Chiedo ai miei alunni di prima liceo cosa ne pensino de L’imperatore di Portugallia, bellissimo romanzo del Nobel Selma Lagerlöf, il quale ho loro assegnato come lettura domestica. La vicenda narra di un padre che perde il lume della ragione pur di non accettare il traviamento della figlia, andatasene lontana da casa. La ama così tanto da non poter concepire che lei possa compiere qualcosa di sbagliato. In lei egli vede solo la propria bellissima bambina. Investita da questo amore, la ragazza torna sulla diritta via, e grazie al perdono ridiventa se stessa.
Al che un alunno alza la mano e sentenzia: «Secondo me non è giusto».
Cosa non è giusto?, gli domando. «Che lui la perdoni. Lei si è comportata molto male con suo padre, e il perdono proprio non se lo meritava. Lui è pure diventato pazzo per colpa sua!».
Rincasando, medito sulla durezza degli adolescenti, sulla loro incrollabile esigenza di coerenza, sul filo di ferro del loro giudizio, pretenzioso metro con cui misurano noi adulti e tanto più se stessi. Come se noi grandi però ci comportassimo molto diversamente. Ha ragione il mio alunno: il perdono è uno scandalo.
“Perdonare” è un verbo coniato nel Medioevo. È derivato dal più antico condonare, sopravvissuto fino ad oggi con significato circoscritto all’ambito penale e alla contrazione di debiti. Entrambi i verbi etimologicamente significano la stessa azione: “donare completamente”. È infatti questo il senso aggiunto al verbo donare sia dal prefisso per-, che dal prefisso con-.
Una tremenda infelicità
Il verbo che gli antichi romani utilizzavano con più frequenza per dire “perdonare” è ignoscere, che letteralmente significa “io non so”, “io non conosco” o “io non riconosco” (il verbo di base è (g)noscere, “conoscere”, “sapere”, saldato al prefisso negativo in-). Perdonare qualcosa a qualcuno, nel senso di fingere di non aver visto l’errore. È l’equivalente del nostro “chiudere un occhio”.
Questo verbo rintocca due volte con accento di condanna nel passo più commovente delle Georgiche di Virgilio: la catabasi di Orfeo per riconquistare alla luce la defunta fidanzata Euridice.
Il mitico cantore è ormai di ritorno, è sulla soglia del mondo dei vivi. È riuscito a strappare Euridice alla morte. Gli manca tanto così, e saranno felici. Quando però lo coglie una subita dementia, un’improvvisa follia. Si volta infatti a cercare con lo sguardo la ragazza, contraddicendo così il comando divino che gli proibiva di farlo finché non fossero usciti. Euridice gli è strappata per sempre; Orfeo è condannato a una tremenda infelicità.
Tutta colpa di una apparentemente lieve dementia, che Virgilio si affretta a commentare così: «Ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes» (perdonabile, senza dubbio, se solo gli dèi inferi sapessero perdonare). De-mentia significa, letteralmente, “perdere la testa”, inciampare “fuori dalla propria mens”, che è la nostra facoltà intellettiva, la ragione. Dante, seguendo l’Etica aristotelica, l’avrebbe catalogata nell’Inferno come incontenenza (XI 82-4), istintività passionale, ossia il meno grave tra i peccati. Ma tanto basta a Orfeo: non c’è perdono sotto al cielo pagano.
Il tema del perdono doveva bruciare nel cuore dell’ombroso Virgilio, poiché il suo capolavoro, l’Eneide, è madido del sangue degli insontes, innocenti, tutti peraltro uccisi in giovane età, per i quali né gli uomini né gli dèi mostrano compassione: Creusa, Polidoro, Didone, Palinuro, Miseno, Marcello, Eurialo, Niso, Camilla, Pallante; solo per citare i più famosi. Il Fato che non deve spiegazioni ad alcuno svolge la propria trama promettendo un bene (Roma) di là da venire, di cui nessuno nel poema fruirà. Nell’edificare questo monumento, falcia ugualmente buoni e cattivi.
Questo è il dramma di cui Enea si ritrova ad essere passivo personaggio; non protagonista, ma pietoso strumento di un Destino impietoso. Il poema stesso si chiude sull’immagine di Turno, il nemico ormai sconfitto, che implora pietà, senza riceverla.
Agli dèi sembrò altrimenti
L’Eneide è un calice amaro. Il perdono – quello rotondo, non peloso, non clemente, non tollerante –, il vero per-dono in natura non esiste. Comprensibile che il mio alunno, vedendolo, se ne scandalizzi. Diceva infatti Baudelaire: «L’uomo ucciderebbe la propria madre. Occorre che qualcos’altro subentri e gli insegni a non farlo».
Virgilio era appena morto, che il lugubre orizzonte chiuso del mondo antico, tutto fremente e a capo chino, fu squarciato da Cristo. L’inaudita, imprevedibile buona novella: il Destino, Deus, caritas est. Egli è via, veritas, vita; è giustizia e misericordia. Può e deve catalizzare tanto la nostra ragione quanto il nostro affetto. Egli stesso, poi, è il primo degli insontes.
Non è un caso che Virgilio nel Medioevo cristiano sia stato amato e copiato, paragonato ai profeti, fatto perfino oggetto di devozione popolare. C’è una lettura più superficiale di questo fenomeno, cioè prendere e sventolare la quarta Ecloga, quella che preannuncia la nascita del puer miracoloso; versi che respirano un autentico desiderio di rinascita cosmica, ma anche intessuti di stilemi tipici della letteratura celebrativa alessandrina, e che ovviamente non hanno nulla di profetico. E c’è una lettura più profonda, che è quella di Dante.
Il poeta fiorentino colpisce non tanto perché sappia a memoria l’Eneide (Inferno XX 114), ma poiché prova per Virgilio una compartecipazione umana che non ha precedenti nella storia ed è ineffabile per quanto è profonda. Nella Commedia Dante è sinceramente addolorato che Virgilio non sia in Paradiso. Non poteva essere diversamente, poiché la Chiesa affermava perentoria che per essere salvi occorre esser battezzati e aver creduto in Cristo: è Virgilio stesso a spiegarlo a Dante (Inferno IV 31-42).
Ciononostante, Dio concede al mentore pagano di Dante il privilegio eccezionale di accompagnarlo fin sulla cima del Purgatorio, che è già terra dei redenti. Cerco di immaginare cosa debba aver provato Dante nel comporre quei versi, e mi commuovo.
Ma non è finita qui. In pieno Paradiso, in un momento in cui Virgilio e il suo dramma sembrano ormai essere acqua passata, troppo legati alla Terra per echeggiare fin lassù, Dante ci sbalordisce, e sbalordisce il se stesso personaggio, tanto da fargli esclamare: Che cose son queste? (Paradiso XX 82). Infatti, tra gli spiriti beati del cielo di Giove, dove han dimora eterna coloro che in vita furono giusti, a Dante viene presentato Rifeo. Chi?
È un personaggio minore dell’Eneide, scelto volutamente per essere sconosciuto. Di lui nel suo poema Virgilio dice soltanto che fu «iustissimus unus/ qui fuit in Teucris», il più giusto fra i troiani. Muore ammazzato nell’ultima notte di Troia, in barba al suo essere iustissimus (Eneide II 426-8). Tanto che subito Virgilio aggiunge amaramente: «Dis aliter visum», agli dèi sembrò altrimenti.
No, gli risponde Dante milletrecento anni dopo. Se gli dèi pagani non lo videro, Dio però se ne accorse. Guarda, ha pure trovato il modo di salvarlo. Senza contraddizione con i fermi precetti della Chiesa, com’è poi spiegato: è il tema della “rivelazione implicita”, dibattuto dai teologi dell’epoca, e dell’insondabile profondità dei giudizi di Dio. Per approfondire, leggasi Paradiso XIX-XX.
Non è giusto, ma è possibile
Il trucco, in sintesi, è che: «Regnum celorum vïolenza pate/ da caldo amore e da viva speranza,/ che vince la divina volontate:/ non a guisa che l’omo a l’om sobranza,/ ma vince lei perché vuole esser vinta,/ e, vinta, vince con sua beninanza» (Paradiso XX 94-9). Ossia: l’amore e la speranza degli uomini possono vincere la volontà di Dio, poiché essa stessa desidera essere vinta, per trionfare in questo modo con la propria infinita bontà.
Il perdono non è giusto, ma è possibile, come sa solo chi viene perdonato.
Mi immagino Virgilio sorridere. Mi immagino anche il mio alunno, tanti alunni, tutti noi, che leggiamo e rileggiamo questi versi. Grazie, buon Dio, per Dante.


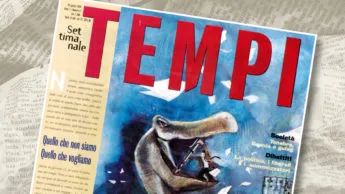
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!