
Crisi o suicidio dell’Occidente?

Quando parliamo di liberalismo, nella sua connotazione contemporanea, anglosassone e soprattutto americana, si deve tenere a mente quanto detto sostenuto da Giovanni Sartori: si tratta di una forma di socialismo in un Paese che non ha mai conosciuto il socialismo. Data questa premessa, l’ormai classico lavoro del teorico politico americano James Burnham (1905-1987) appare meno oscuro – sul suo pensiero complessivamente inteso si rimanda alla monografia di Giovanni Borgognone James Burnham. Totalitarismo, managerialismo e teoria delle élites (2000). Il riferimento è a Il suicidio dell’Occidente, pubblicato originariamente nel 1964 e tradotto in italiano già l’anno seguente, ora nuovamente disponibile grazie alla cura di Francesco Ingravalle e alla casa editrice Oaks. Un’opera, a dirla tutta, che segue altri importanti lavori di Burnham, come La rivoluzione manageriale (1941) e Nel nome di Machiavelli. I difensori della libertà (1943), anch’esso da poco ripubblicato dalla medesima casa editrice e per mezzo dello stesso curatore.
Lontani dall’idea liberale classica
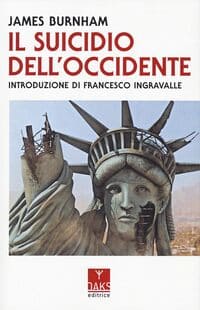
Uomo di sinistra nel corso degli anni Trenta, e segnatamente di matrice trotzkista, Burnham finisce qualche anno dopo col rigettare la fede politica che lo aveva avviluppato. L’Unione Sovietica, scriverà infatti, manifestò evidenti e irrefutabili tendenze imperialistiche e sfruttatrici. Il Patto Ribbentrop-Molotov dell’agosto 1939, le invasioni della Polonia, dei Paesi baltici e della Finlandia lo dimostrarono senza possibilità di appello. Tutto questo poté avvenire anche per mezzo di quello che Burnham definì suicidio dell’Occidente. Secondo lui, quello spazio geografico-culturale che siamo soliti chiamare con tale espressione dimostrò tutta la propria insipienza e la propria fiacchezza morale col ritenere che il comunismo fosse una dottrina, per così dire, parente del liberalismo.
Siamo lontani dall’idea liberale classica: una mutazione che è stata molto ben analizzata da Antonio Masala in alcuni suoi lavori (Crisi e rinascita del liberalismo classico, ETS 2012, e Stato, società e libertà, Rubbettino 2017). Quello di cui parla Burnham, piuttosto che essere una dottrina, è una sindrome che certamente parte da un impianto individualistico e liberale, ma poi giunge a esiti molto distanti. Il liberalismo moderno si avvale infatti dello Stato come strumento volto a redimere la società, a salvare gli uomini e a creare una società buona. In sostanza, se il liberalismo classico concepiva lo Stato magari anche come strumento utile, ma entro ambiti ristretti e ben delimitati, la sua mutazione tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento vede nel dispositivo statale lo strumento sicuro per il progresso e il miglioramento sociale. Burnham parla di un vero e proprio «capovolgimento», tale per cui il liberalismo si è avvicinato al socialismo e quest’ultimo, analogamente, ha compiuto passi di avvicinamento al liberalismo. La sintesi è un nuovo tipo di liberalismo che poco a poco ha fatto retrocedere la libertà della persona dal vertice della propria gerarchia valoriale, ponendo invece ai primi posti la giustizia (sociale), l’eguaglianza e il benessere collettivo.
Senza verità, è anarchia
Se così stanno le cose, cosa differenzia il liberalismo dal comunismo? Difficile dirlo, almeno stando a quanto scrive Burnham. Ciò che rimane unicamente di distintivo tra i due è l’individualismo – sebbene il moderno liberalismo abbia la tendenza a sciogliere la componente individualistica negli aggregati e nelle collettività. I liberali nella variante analizzata, scrive il teorico politico americano, «non sono in grado di combattere con sufficiente fermezza contro i comunisti, sia internamente che internazionalmente, perché sentono oscuramente che nel far ciò ferirebbero in certo qual modo se stessi».
Forse, però, come scritto da un altro esponente del presunto movimento conservatore americano di metà Novecento – secondo la classica, ma per certi versi discutibile classificazione operata dallo storico George Nash – è la coscienza a distinguere in primo luogo il liberalismo classico. Secondo John H. Hallowell, infatti, è essa a costituire il baluardo del liberalismo integrale. Riferendosi in particolar modo al nazionalsocialismo, e qualche anno prima di Burnham, Hallowell così si esprimeva: «Il liberalismo ha distrutto le proprie convinzioni negando alla coscienza un ruolo valido nello schema delle cose. Infatti, senza un’affermazione comune di verità e valori oggettivi, il liberalismo non può fare a meno di degenerare in anarchia. E l’anarchia si manifesta politicamente come tirannia».
***
Disclaimer: grazie al programma di affiliazione Amazon, Tempi ottiene una piccola percentuale dei ricavi da acquisti idonei effettuati su amazon.it attraverso i link pubblicati in questa pagina, senza alcun sovrapprezzo per i lettori.
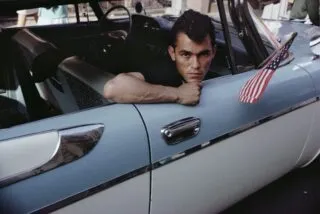


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!