
Good Bye, Lenin!
Più lo mandi giù e più ti butta giù. La «crisi del caffè» del 1977 a Berlino Est
 Dopo i moti operai del ’53 e prima che abbattessero il Muro nell’89, Berlino Est fu seriamente minacciata da un rivolta interna, provocata non da uno slancio ideale o dal profumo della libertà ma… dall’aroma del caffè.
Dopo i moti operai del ’53 e prima che abbattessero il Muro nell’89, Berlino Est fu seriamente minacciata da un rivolta interna, provocata non da uno slancio ideale o dal profumo della libertà ma… dall’aroma del caffè.
È quanto emerge dai documenti declassificati e messi on line recentemente dall’Autorità federale tedesca per gli archivi della Stasi. Si tratta di rapporti riservati stilati tra il ’53 e l’89 dalla sicurezza di Stato e poi inviati ai livelli superiori della nomenklatura, una specie di «rassegna stampa» che raccoglieva gli umori della popolazione, le tendenze dell’opposizione politica, ecc. Tra di essi ve ne sono alcuni dedicati alla cosiddetta «crisi del caffè» del 1977.
Il caffè, cantava De Andrè, «pure ‘n carcere ‘o sanno fa’» – figuriamoci in Germania Est e specialmente in Sassonia, dove la tradizione del caffè e relativi servizi di porcellana risale al ‘700. Nei primi anni del dopoguerra, il neonato paese satellite beveva caffè importandolo da mamma URSS ma dal 1954 dovette trovare da sé i soldi per acquistarlo pagandolo in valuta pregiata. Negli anni ‘70 la tazzina di caffè in casa o in ufficio era di fondamentale importanza nella quotidianità del cittadino tedesco-orientale: il consumo pro capite era di 3,6 kg all’anno, i cittadini spendevano annualmente 3,3 miliardi di marchi per il caffè, la stessa cifra sborsata per l’arredamento e il doppio di quella per le calzature. I più fortunati si facevano spedire quello buono da parenti e amici dall’Occidente, un aiuto tollerato e prezioso anche per le finanze statali. Finché nel ’76 un cattivo raccolto in Brasile, il maggior esportatore mondiale, fece crescere drammaticamente il prezzo del caffè sul mercati internazionali e Berlino Est, per potersi garantire le 50.000 tonnellate annue, si trovò a dover pagare 300 milioni di dollari, una cifra quattro volte superiore alla spesa prevista, perciò dovette correre ai ripari.
 Nell’estate del ’77 fu interrotta la produzione della qualità popolare «Kosta» e aumentati i prezzi delle qualità «Rondo», «Mona» e «Mokka-Fix-oro», per lanciare sul mercato, a prezzo popolare, il «Kaffee-mix», una miscela composta per il 51% di caffè di varietà «robusta» assai scadente, e il resto di segale, cicoria, barbabietola da zucchero, persino piselli. Il sapore di patate ammuffite faceva l’effetto delle madeleines di Proust riportando chi lo beveva al caffè del dopoguerra. Fu la goccia che per poco non fece traboccare il vaso. Honecker in persona dovette convincere la popolazione che si trattava di una soluzione inevitabile a causa delle serie difficoltà economiche, e promise ai sudditi che presto avrebbero importato caffè buono da paesi amici come l’Angola e l’Etiopia, in cambio di macchinari, camion e armi. Un pacchetto di miscela costava inizialmente 16 marchi (invece dei 60 del Kosta) e per favorire la clientela fu scontato a 4, ma, oltre a rovinare il palato, conteneva sostanze che ostruivano inesorabilmente i filtri delle caffettiere e rovinavano i distributori automatici. La situazione andò normalizzandosi solo all’inizio degli anni ’80. Intanto Berlino Est finanziò il Vietnam socialista, un paese che fino ad allora aveva coltivato solo il tè, perché avviasse la coltivazione intensiva di caffè.
Nell’estate del ’77 fu interrotta la produzione della qualità popolare «Kosta» e aumentati i prezzi delle qualità «Rondo», «Mona» e «Mokka-Fix-oro», per lanciare sul mercato, a prezzo popolare, il «Kaffee-mix», una miscela composta per il 51% di caffè di varietà «robusta» assai scadente, e il resto di segale, cicoria, barbabietola da zucchero, persino piselli. Il sapore di patate ammuffite faceva l’effetto delle madeleines di Proust riportando chi lo beveva al caffè del dopoguerra. Fu la goccia che per poco non fece traboccare il vaso. Honecker in persona dovette convincere la popolazione che si trattava di una soluzione inevitabile a causa delle serie difficoltà economiche, e promise ai sudditi che presto avrebbero importato caffè buono da paesi amici come l’Angola e l’Etiopia, in cambio di macchinari, camion e armi. Un pacchetto di miscela costava inizialmente 16 marchi (invece dei 60 del Kosta) e per favorire la clientela fu scontato a 4, ma, oltre a rovinare il palato, conteneva sostanze che ostruivano inesorabilmente i filtri delle caffettiere e rovinavano i distributori automatici. La situazione andò normalizzandosi solo all’inizio degli anni ’80. Intanto Berlino Est finanziò il Vietnam socialista, un paese che fino ad allora aveva coltivato solo il tè, perché avviasse la coltivazione intensiva di caffè.
I documenti della Stasi riportano allarmati le vivaci discussioni che si svolgevano in ampi strati della popolazione, le lamentele per le caffettiere rotte sostituite da pericolosi bollitori a immersione che «violano le norme antincendio», e le critiche sarcastiche nei confronti dell’incapacità del regime di concedere ai cittadini almeno una tazza di caffè decente:
– Qual è la differenza tra la miscela e un Pershing 2?
– Nessuna, perché entrambi sterminano la popolazione.
 La tensione sociale salì al punto che in alcuni locali pubblici «il personale di servizio viene insultato dai clienti e indotto a replicare per le rime, quando per la disperazione non lascia il posto di lavoro». Ma la cosa peggiore per gli analisti della Stasi era la diffusione di giudizi mediati dalla stampa occidentale: «È un imbroglio ai danni dei lavoratori»; com’è possibile – si chiedeva qualcuno – parlare di uno Stato «degli operai e dei contadini» se al lavoratore non viene concessa nemmeno una tazza di caffè? Significa allora che siamo economicamente al capolinea, indebitati fino al collo. Anche all’interno della struttura di potere non mancarono critiche di «forze progressiste» secondo le quali il Partito «come al solito» aveva atteso troppo prima di comunicare alla popolazione la reale situazione degli approvvigionamenti di caffè, e in questo modo si era concesso altro «vantaggio al nemico».
La tensione sociale salì al punto che in alcuni locali pubblici «il personale di servizio viene insultato dai clienti e indotto a replicare per le rime, quando per la disperazione non lascia il posto di lavoro». Ma la cosa peggiore per gli analisti della Stasi era la diffusione di giudizi mediati dalla stampa occidentale: «È un imbroglio ai danni dei lavoratori»; com’è possibile – si chiedeva qualcuno – parlare di uno Stato «degli operai e dei contadini» se al lavoratore non viene concessa nemmeno una tazza di caffè? Significa allora che siamo economicamente al capolinea, indebitati fino al collo. Anche all’interno della struttura di potere non mancarono critiche di «forze progressiste» secondo le quali il Partito «come al solito» aveva atteso troppo prima di comunicare alla popolazione la reale situazione degli approvvigionamenti di caffè, e in questo modo si era concesso altro «vantaggio al nemico».
Ma come mai tante storie per una specie di «miscela Leone»? Al potere era sfuggito che i cittadini misuravano il tenore di vita anche da cose semplicissime come l’aroma del caffè. La tazzina quotidiana significava per il tedesco-orientale la normalità, se il caffè era in grani e ben macinato allora tutto era in ordine, era la sicurezza psicologica che, nonostante tutto, erano ormai lontani i tempi bui del primo dopoguerra. Il caffè buono era un piacere anche in Germania Est.
Articoli correlati
2 commenti
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!
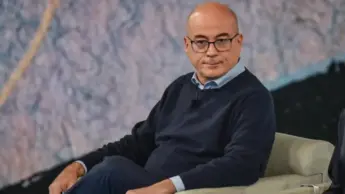


e oggi?
E in Italia?
http://www.affaritaliani.it/economia/caffe-prezzi170314.html
http://news.biancolavoro.it/news/2097-aumenta-l-iva-per-i-distributori-automatici-e-la-pausa-caffe-diventa-piu-amara
Qualche analogia??