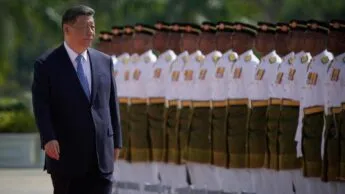
Cosa significa l’incendio di Notre-Dame? Conversazione con Olivier Roy

Tratto da le Grand Continent – Traduzione di Sandra Biondo e Eloisa Capezzuto
Politologo, specialista delle religioni, fine conoscitore dello stato della Chiesa, Olivier Roy analizza la reazione della Chiesa e del mondo cattolico all’incendio di Notre-Dame. La constatazione è senza appello: la catastrofe è un ulteriore segno di un’istituzione in crisi, che al momento sembra “disorientata, pressoché impotente”.
Come interpreta la reazione all’incendio di Notre-Dame, che da giorni sembra corale, omogenea, internazionale, al di là delle distinzioni di classe?
Il cordoglio comune di credenti e non credenti degli ultimi giorni mi sembra un paradosso. Quest’apparente unità nasconde un profondo disaccordo: i laici pensano all’oggetto culturale – se l’incendio si fosse prodotto al Louvre, la reazione sarebbe stata la stessa -, i cattolici piangono una prova di fede di cui non comprendono – o non vogliono comprendere – il senso, e che tendono a spiegare con la classica rappresentazione dell’ira divina. Nel frattempo, il vescovo e il cappellano dei pompieri tirano un sospiro di sollievo: la pietra soffre, ma lo spirito è salvo.
Le sembra che la reazione dei laici e quella dei credenti sia stata fondamentalmente diversa?
La maggior parte delle persone non vanno a messa: non hanno mai visto la cattedrale come un luogo di culto. Per i parigini, Notre-Dame è un monumento storico, parte del paesaggio affettivo della città. Ognuno vi associa dei ricordi personali. La Cattedrale incarna il passare dei secoli, la lunga storia di Parigi. In un certo senso, è il luogo del culto degli antenati, del passare del tempo. Tutto ciò senza conoscere il rito cattolico – che è ciò che costituisce il senso di una cattedrale.
La differenza di significato che si attribuisce a Notre-Dame ha avuto un impatto sulla reazione politica all’evento?
Il Presidente della Repubblica, e tanti commentatori, non hanno quasi affatto citato la comunità cattolica. Quest’ultima si è sentita esclusa, quasi privata della sua cattedrale. Beninteso, Notre-Dame fa parte del patrimonio di tutti. Includere una dimensione nazionale nel discorso fa sì che implichiamo una dimensione selettiva del fatto religioso. L’arcivescovo di Parigi, Monsignor Aupetit, ha dichiarato che avrebbe amato che il presidente Macron citasse i fedeli nel suo discorso.
L’arcivescovo ha sorpreso ancor di più quando si è interrogato sul senso dell’incidente chiedendo “cosa vuol dirci il Signore attraverso questa prova?”
Bisogna capire che le intenzioni sono diverse. Ufficialmente, per lo Stato e per la maggior parte dei francesi, non si parla di messa, né di rito, né di Chiesa. È una questione di patrimonio storico. Dal punto di vista della Chiesa, per chi crede alla Provvidenza, un evento di tale portata, e in un momento così simbolico dell’anno liturgico com’è la Settimana Santa, non può essere un incidente. L’incidente ha sempre un senso. Questo spiega la dichiarazione dell’arcivescovo: la Chiesa ha il compito di interpretare il senso, di orientare il tempo. In fondo, si tratta di dare un ruolo istituzionale alla Chiesa nella vita dei suoi fedeli.
Quando l’arcivescovo parla di “prova” quindi, non c’è un senso laico – non si indirizza ai cittadini francesi, agli elettori europei?
No. Nel suo discorso, l’arcivescovo si rivolgeva ai suoi fedeli: parlava del senso dell’incendio dal punto di vista dei credenti.
Quindi non le sembra ci sia un intento politico nelle sue dichiarazioni? In fondo, l’incendio di Notre-Dame sarebbe stato il momento ideale per chiedersi nuovamente se l’Europa è cristiana [ndt : l’autore ha dedicato un articolo alla questione nell’autunno 2018].
Non mi è sembrato di cogliere una dimensione politica nelle dichiarazioni ecclesiastiche dopo l’incendio. La Chiesa cerca un senso meta-storico, al di là del fatto politico e del dibattito di società. È una questione un po’ astratta, che tocca ai luoghi simbolici della fede, e che si indirizza solo a chi crede. La prova ne è che i cattolici sono soprattutto alla ricerca di un segno miracoloso che aiuti ad interpretare o giustificare l’accaduto.
Viene subito in mente l’immagine dell’altare e della croce indenni nel bel mezzo di braci e macerie…
Certo. Le reliquie sono state messe in salvo, la croce è intatta. È normale ci sia una messa in scena, una disposizione rituale al miracolo – resa particolarmente efficace dalla composizione architettonica e la densità simbolica della cattedrale. Si insiste particolarmente sul fatto che i simboli della fede siano rimasti intatti: sembra tutto voler indicare che che c’è un messaggio. E se c’è un messaggio, bisogna interpretarlo. E questo è il compito, la funzione che assume la Chiesa.
La questione della funzione della Chiesa passa anche dal senso che possiamo ancora attribuire alle chiese, nel loro aspetto materiale. Spiegare, insomma, perché Notre-Dame non è il Louvre.
Una cattedrale, esattamente come il Louvre, è innanzitutto un insieme di blocchi di pietra. La questione, in fondo, è abbastanza semplice: bisognerebbe sapere cosa sono i blocchi di pietra, e perché vi attribuiamo un senso. Nel cristianesimo occidentale, i cattolici (o quasi) sono gli unici a considerare che la pietra abbia una reale importanza. Il senso religioso della Chiesa cattolica passa anche attraverso la religiosità degli edifici. Ogni chiesa-edificio è, in fondo, una sineddoche della Chiesa-istituzione. Per tornare alla dichiarazione dell’arcivescovo: se ha detto che avrebbe amato che Macron usasse più spesso la parola “cattolico”, è perché si è sentito espropriato di qualcosa che gli è prezioso. Nell’emozione generale, si è forse messo da parte il cattolico dell’evento.
Il dibattito attuale sulla ricostruzione della guglia contribuisce a cristallizzare il problema?
Sì, perché è un dibattito che va oltre la questione del patrimonio storico. Il concetto di autenticità è problematico: il gotico di Viollet-le-Duc è un gotico fantasmato. Non si tratta di ricostruire la forma com’era prima, ma della forma che bisognerebbe ritrovare superando la forma presente. Allo stesso modo, il mito dell’autenticità di oggi si fonda su un malinteso. Quasi nulla della Notre-Dame che conosciamo è “autentico”: possiamo solo riferirci al fantasma dell’autenticità.
Saremmo tentati di chiederci se una struttura in acciaio, pensata con le tecnologie di oggi, che ricostruisca l’aspetto esterno della guglia di Viollet-le-Duc basterebbe a placare la “sete di autenticità” che hanno espresso alcuni neonazionalisti?
È tutto il problema! L’aspetto esterno basterebbe, ma solo perché non sappiamo entrare in relazione con il resto dell’edificio.
Una guglia identica all’esterno posata su una struttura ipermoderna non sarebbe la miglior metafora possibile per illustrare il suo proposito, secondo cui i movimenti neonazionalisti si sono appropriati del cristianesimo? Possiamo dire che propongono una struttura d’acciaio, con un aspetto esterno che imita la versione autentica?
Assolutamente sì. Il cristianesimo sbandierato da tali movimenti è solo un’apparenza, e la Chiesa non si lascia ingannare. I neonazionalisti non si interessano all’insieme: si prenda l’esempio di Salvini, divorziato, piuttosto sessantottino nei costumi, che d’un tratto si crede più cristiano del Papa, e che lotta – parzialmente contro la dottrina della Chiesa che esprime Francesco, per difendere la famiglia patriarcale tradizionale. Con l’Europa bianca e cristiana che rivendicano Orban e Salvini, siamo nel campo della dichiarazione, dell’apparenza. Non nel senso, nell’intenzione, ma nella farsa.
Vi hanno sorpreso le dichiarazioni del Papa, volte a mettere in evidenza il carattere nazionale di Notre-Dame bypassando l’attenzione che la comunità europea ed internazionale ha consacrato a questo simbolo?
Non sono sicuro di aver compreso pienamente ciò che il Papa intendesse. E’ chiaro però che quest’ultimo non risulti particolarmente sensibile alla questione dell’identità cristiana dell’Europa. Non essendo europeo, avrà tendenza a considerare il tragico evento come una crisi inerente al patrimonio nazionale. Possiamo notare che il Papa ha pressoché la stessa posizione di Macron: entrambi concepiscono Notre-Dame come un mero elemento del patrimonio nazionale. Per lui si tratta di un incidente che ha a che fare con l’edificio e le sue pietre. In realtà, il problema è molto più profondo.
A tal proposito, la distruzione di Palmira può essere citata come esempio emblematico. In quel caso si trattò essenzialmente di un atto politico. Il patrimonio culturale a propriamente dire, veniva fragilizzato da un approccio di marketing contemporaneo più propizio a stimolare l’immaginario teologico e politico. In effetti, i templi di Palmira sono ormai scevri di senso religioso. Sono delle pietre, le nostre pietre.
C’è una prospettiva interessante che emerge da questa analogia. In tutti i fondamentalismi c’è una profonda indifferenza alle pietre, ai templi. C’è un iconoclastia radicale e profonda. Questo approccio si è peraltro manifestato anche nel cristianesimo, si ritrova per esempio nella genesi del movimento luterano. La chiesa cattolica però è a favore delle pietre. In un certo qual modo cerca di implementare un processo di cristianizzazione di quest’ultime. Basti pensare a tutte le chiese che furono erette a partire da edificati pagani. L’accento è messo sugli oggetti, ma l’impronta è fortemente territoriale. La Chiesa è per definizione territoriale, il che si manifesta in particolare attraverso l’edificazione di cattedrali. I protestanti al contrario, non hanno improntato le loro istituzioni su dei luoghi così cruciali e pregni di simbolismo. Manca la dimensione di attaccamento al territorio che invece caratterizza la Chiesa cattolica. La ricerca di un luogo simbolico passa anche attraverso una forma di valorizzazione della religione popolare: la chiesa ha sempre valorizzato, pur smarcandosene, le forme di devozione popolare. Questa tendenza, che si iscrive nel lungo periodo, contraddice lo spirito generale dell’epoca – che era invece di fare tabula rasa. Il problema non è più quello di creare opere che perdurano nel tempo, ma piuttosto quello di creare un oggetto performante o per meglio dire una performance: un vero e proprio evento. In fin dei conti oggi, ciò che è in voga, è proprio questo.
Ritiene che questa contraddizione con lo spirito generale dell’epoca sia vissuta dalla chiesa in maniera antagonistica?
E’ una questione molto complessa. In effetti entra in gioco l’idea di apocalisse. Ma la concezione apocalittica dell’avvenire non è per nulla antagonistica allo spirito del nostro tempo. Basti vedere le pubblicazioni più recenti il cui contenuto si può riassumere con l’idea di una decadenza inevitabile ed incontrastabile, senza nessuna forma di lotta o di progetto di lungo termine. Secondo questa logica, non sorprende che alcuni reazionari abbiano pensato che Daesh non avesse alcun interesse a bruciare Notre-Dame poiché siamo perfettamente in grado di farlo da soli. L’idea che il cristianesimo si stia lentamente sgretolando e che si stia avviando verso un inesorabile declino impregna una larga parte dell’opinione pubblica europea.
Come spiegarlo? Ci vedete una forma di influenza maurrassiana?
Certamente. Con la differenza sostanziale però che Maurras credeva in qualcosa e proponeva un antagonismo. Per Houellebecq invece, o per gli altri autori dello stesso filone, non c’è più un futuro possibile. Con il crollo demografico, il futuro è già finito. Questa interpretazione catastrofista si ritrova anche nell’allarmismo, peraltro non ingiustificato, sulla crisi climatica. A prescindere dall’origine ad ogni modo, l’apocalissi è imprescindibile. Le cattedrali spariranno. Il terrore escatologico che si cela in queste tragiche interpretazioni della nostra società, non solo travalica la dimensione religiosa e del credo, ma mette in luce una Chiesa incapace di rispondervi.
Roland Barthes si domandava quali fossero le cattedrali moderne3. Per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo quasi avuto voglia di credere che la cattedrale moderna non fosse altro che una cattedrale antica nella misura in cui il periodo liturgico e gli affetti ecclesiastici erano in linea con il periodo storico. Come interpretate questa coincidenza?
Se anche avessimo voluto farlo di proposito, non ci saremmo riusciti così bene! Il momento è straordinario. Le teorie complottiste che circolano sono il frutto di un incessante dubbio esistenziale che affligge la società: perché Dio colpisce la propria comunità? Il momento storico, il luogo, etc. portano naturalmente i credenti a porsi questo tipo di domande.
Eppure c’è un paradosso. Perché la chiesa non coglie l’occasione per innescare un processo di riforma, di rifondazione – processo peraltro in linea con gli obiettivi enunciati da Papa Francesco al momento della sua nomina? Un’omelia di Pasqua sulle rovine della cattedrale sarebbe stata un’occasione d’oro per dare il via ad un processo politico particolarmente complesso, oggi sempre più stagnante. Come interpreta questa forma di esitazione a voler utilizzare questo delicato momento come vettore di cambiamento? Non le sembra che ci sia una ritrosia nel volersi schierare o nel voler fare leva su un pretesto così potente?
La Chiesa è paralizzata da una crisi interna che si manifesta sino ai più alti vertici. Per quanto si possa far finta di nulla, dobbiamo tenere in conto che ad oggi a Roma ci sono ben due Papi! La chiesa contemporanea si è certamente fondata sul Vaticano II ma si appoggia in toto sulla nozione dell’infallibilità papale. Un Papa che dà le dimissioni, è un Papa che riconosce di non poter dire né detenere la verità assoluta. Ed il Papa attuale ha firmato una lettera in cui attesta che la crisi della pedofilia è un chiaro segno della perdita della fede nella chiesa.
È comunque straordinario che questa presa di posizione forte sia avvenuta proprio qualche giorno prima dell’incendio di Notre Dame…
Potete ben immaginare cosa questo evento possa significare quando si è rappresentanti della Chiesa. La Chiesa crolla? Il minimo che si possa dire è che i tetti crollano… La paralisi istituzionale della chiesa dovuta agli scandali di pedofilia, si manifesta finanche nella distruzione della pietra. La chiesa sembra quasi un corpo corrotto, infiammato. Ciò che sorprende è che questo evento non è stato strumentalizzato per dare il via ad un nuovo inizio. La Chiesa sembra quasi paralizzata, totalmente incapace di prendere iniziativa.
Paralizzata da cosa? Teme forse uno scisma occidentale?
Forse. O forse è una paura dalle cause ignote. Si tratta senza dubbio della sua incapacità a dare una forma specifica – che sia sociale o politica – a questa complessa tradizione millenaria. La chiesa non è in grado di proporre ai propri fedeli contemporanei un tema differente da quello della sofferenza. I soli leitmotiv proposti sono quelli della penitenza, del supplizio, con queste premesse è complicato riuscire ad immaginare una rinascita.
Non vedete dunque delle prospettive edificanti che potrebbero eventualmente emergere da questa negatività?
No, e non riesco neppure ad identificare un qualcuno che possa addossarsi questo ruolo. Le istituzioni vaticane sono fragilizzate dalla profonda crisi interna che le attraversa. Il Papa è immobilizzato. La confusione è pregnante: la Chiesa oggi si batte contro il nuovo paganesimo, tutto il mondo sembra essergli rivale.
Come interpretate in questo contesto la recente serie di atti profanatori delle chiese cha hanno suscitato l’interesse dei media e che hanno animato il dibattito polemico sull’origine dolosa dell’incendio di Notre Dame?
È molto semplice: l’aumento delle profanazioni delle chiese è semplicemente correlato al loro abbandono. È peraltro une delle verità più scomode per i reazionari contemporanei. Se le chiese vengono profanate è anzitutto perchè non c’è più nessuno che vi si interessi in città. L’interpretazione delle cause, chiaramente, diverge dai punti di vista: l’estrema destra ad esempio lascia intendere che sia colpa dei musulmani, grandi nemici dell’occidente e dell’Europa, capaci di attaccare le chiese. Però, se si getta un occhio alla cartografia, si comprende che questi atti vandalici sono prodotti essenzialmente da adolescenti in crisi, vogliosi soprattutto dell’adrenalina derivante dall’atto di distruzione. L’islam non c’entra proprio nulla.
Non credete dunque che la ricostruzione della chiesa possa basarsi su un processo di chiarimento delle contraddizioni presenti all’interno della chiesa, superando la triade: Stato, grandi magnati, dibattito pubblico?
Assolutamente no. La Chiesa, così come Notre-Dame, è, ad oggi, totalmente priva di mezzi per poter realizzare un tale obiettivo.
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!