
Shin Dong-hyuk, nato e “disumanizzato” in un gulag nordcoreano. Fuggì dopo aver fatto giustiziare la madre e il fratello
Sarà proiettato oggi, 10 settembre, alle ore 17.00 al Teatro Studio di Milano il documentario Camp 14 – Total Control Zone, che ieri tempi.it ha visto in anteprima nel corso del Milano Film Festival: il film è il racconto in prima persona della terribile esperienza di Shin Dong-hyuk, nato e cresciuto in un gulag norcoreano, dal quale è riuscito a fuggire dopo aver sperimentato e visto ogni sorta di trattamento disumano e disumanizzante (una storia di cui tempi.it aveva già parlato ampiamente in questo articolo). Shin Dong-hyuk ha accettato di raccontare la sua vita davanti al regista Marc Wiesse, tedesco, presente all’anteprima italiana del film.
STORIE INCROCIATE. Wiesse è stato anche il primo a riuscire in un altro intento, raccogliere la testimonianza di due degli aguzzini del Camp 14: Hyunk Kwon, ex comandante della sorveglianza del campo, e Oh Yangnam, agente della polizia segreta di Pyongyang che nel gulag conduceva gli interrogatori e le torture degli internati. Camp 14 è anzitutto un film dove i ricordi nitidi di Shin Dong-hyunk e i suoi lunghi silenzi carichi del dolore vissuto, si intrecciano senza alcun commento “esterno” ai ricordi di chi dirigeva il campo per conto del regime comunista. Non si indugia certo nell’emozione, in questo documentario in cui tutti i protagonisti, anche per ragioni culturali, non mostrano lacrime, tanto da che spesso non sembrano neanche avere coscienza di ciò che hanno vissuto.
[internal_video vid=117438]«NON SAPEVO PIANGERE». Shin Dong-hyuk è nato 31 anni fa nel Campo 14, dove sono detenuti almeno 30 mila dei 200 mila internati coreani. Una delle regole principali del campo, insieme all’obbligo di delazione tra tutti i compagni di prigionia, è il divieto di contatti fisici e umani tra uomini e donne che non siano collegati al lavoro (al Campo tutti i prigionieri, compresi i bambini, lavorano nelle miniere): la stessa mamma di Shin era stata ottenuta in moglie da un uomo come “premio speciale” per il duro lavoro svolto in prigionia. «Sono cresciuto senza conoscere il significato dei rapporti affettivi, senza alcun senso di umanità», ammette Shin. «Non sapevo che quando si vede morire la propria madre o il proprio fratello si piange. Nessuno me lo aveva insegnato: quello che mi insegnavano era ad obbedire ai guardiani, se non volevo essere punito. A non fuggire, se non volevo essere ucciso». Per ventitré anni Shin vive una routine alienante, costretto a mangiare, ad esempio, solo due cucchiate di mais per tre volte al giorno, 365 giorni all’anno. «L’unica carne che mangiavamo era quella dei topi che riuscivamo ad uccidere».
GULAG A VITA PER UNA SIGARETTA. Dall’altra parte del campo i ricordi scorrono descrivendo scenari disumani, con parole secche e crude, prive di rimorso. I due dirigenti spiegano nel film che in Corea del Nord si può finire nei campi di concentramento per i motivi più stupidi: «Molti coreani per farsi le sigarette, se finivano le cartine, erano soliti usare la carta dei giornali. Così magari non si accorgevano nemmeno di rollare una pagina con la foto di Kim Il-Sung. Per questo venivano però arrestati, torturati e internati a vita». Quella descritta dagli aguzzini è una quotidianità fatta di torture e violenze: «Avevamo creato una sorta di acquario in cui immergevamo i detenuti fino alla bocca. E poi schiacciando un pedale li facevamo immergere completamente sott’acqua. La loro vita dipendeva dal nostro piede». I due raccontano per esempio che per loro era possibile avere tutte le donne del campo che desideravano. E se le prigioniere rimanevano incinte, erano loro stessi a eliminarle.
DELATORE DELLA MADRE. A 14 anni, per caso, Shin scoprì che la madre organizzava di nascosto la loro fuga insieme a suo fratello. Per di più vide che la madre offriva a quest’ultimo una razione di cibo. Colto da un’improvvisa gelosia, memore delle percosse ricevute perché apprendesse l’obbligo di delazione, fu lui stesso a denunciare entrambi ai soldati del campo. Arrestato e torturato a sua volta, fu rilasciato insieme al padre per assistere all’esecuzione di madre e fratello. Rimase colpito dalle lacrime del padre, perché lui, figlio dei gulag dove l’umanità è dissacrata, non conosceva il senso della più elementare commozione umana. Successivamente Shin conobbe un altro prigioniero, appena arrivato a Camp 14, che gli raccontò della vita all’esterno. Un mondo per lui sconosciuto da cui rimase affascinato: «È stato quando mi ha raccontato che fuori si poteva mangiare riso, pollo, carne, che ho deciso di fuggire». Il 2 gennaio 2005, rocambolescamente, riuscirà a evadere. E una volta uscito da quella jungla di sopraffazione e violenza, inizierà un lungo cammino di riavvicinamento all’umanità. Per un caso del destino, oggi Shin Dong vive a Seul proprio come i suoi due aguzzini.
«NON SARANNO GIUDICATI PER QUESTO». «Nessuno sa come i due agenti siano riusciti a fuggire dalla Corea del Nord», ha raccontato il regista Wiesse ieri al termine della proiezione. «È probabile che abbiano stretto un accordo con i servizi segreti della Corea del Sud: informazioni militari in cambio di una nuova identità a Seul. Nessuno di loro è stato o verrà processato davanti ad un tribunale, anche per il semplice motivo che non esiste una Corte per i diritti umani che si occupi della Corea del Nord». Wiesse ha spiegato di aver deciso di non usare alcuna colonna sonora nel film, perché il racconto rimanesse il più semplice e diretto possibile: l’unico effetto cinematografico che si è concesso sono le piccole inserzioni animate che accompagnano alcuni dei ricordi di Shin sulla vita nel campo. «Il comandante Kwon mi ha consegnato delle registrazioni del campo che aveva realizzato con una telecamera privata», ha detto il regista. «Sono le uniche immagini di quella realtà disponibili in tutto il mondo». È stata una precisa scelta di Wiesse quella di incrociare le due testimonianze, «perché possiamo avere un’idea precisa di quali sono le due facce della realtà umana, senza stereotipi. Quando ho raccolto le testimonianze dei due comandanti del campo, per ore mi hanno raccontato nel dettaglio le torture, non dico senza piangere, perché questo fa parte della cultura nordcoreana, ma anche quasi mostrando un certo compiacimento. La traduttrice più volte mi ha chiesto di interrompere, ma non ho voluto. Ho creduto che queste lunghe interviste siano servite anche a loro per portare a galla quello che hanno vissuto».
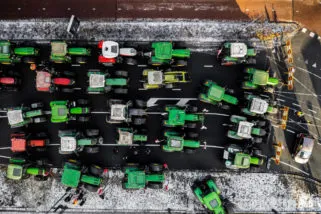


1 commento
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!