
Il Deserto dei Tartari
Contro il linguaggio inclusivo

Qualche giorno fa ho assistito a un divertente siparietto su La7 nel corso della trasmissione Otto e mezzo. Si parlava, come spesso accade, di migranti e a discuterne erano stati chiamati l’ex presidente della Camera Laura Boldrini in studio e il giornalista de La Verità Francesco Borgonovo in collegamento. A un certo punto Borgonovo ha fatto riferimento a Sara Casanova, sindaco di Lodi, promotrice del contestato provvedimento col quale alle famiglie degli studenti stranieri viene chiesto di produrre certificazioni che documentino il possesso o meno di beni immobiliari e altre disponibilità economiche nei paesi d’origine, per stabilire se possano essere esentate da un contributo finanziario da versare per accedere alle mense scolastiche comunali. Borgonovo ha chiamato la Casanova “la sindaca di Lodi”, ma si è subito corretto è l’ha definita “il sindaco di Lodi”. Immediatamente è intervenuta Laura Boldrini, con un largo sorriso: «Perché si corregge? Non abbia paura del femminile, è così bello!». Da quel momento in avanti Borgonovo ha sempre e soltanto usato il maschile “sindaco” per riferirsi a Sara Casanova, nell’evidente intento di provocare reazioni censorie o stizzite nelle partecipanti alla trasmissione. E si può dire che c’è riuscito. Non con la Boldrini, che ha subito capito l’antifona e ha evitato di esporsi, ma con la conduttrice Lilli Gruber, che ha voluto impartire a Borgonovo una lezioncina: «Scusa, Francesco, ma quando si parla di te e di me, si dice il giornalista e la giornalista, si distingue maschile e femminile; perciò sindaca anziché sindaco per Lodi va benissimo». Esempio più sbagliato la Gruber non poteva fare: se il criterio è di rendere riconoscibile il sesso del professionista o del funzionario attraverso l’articolo maschile o femminile, quando il primo cittadino di una città è una donna non si dovrebbe dire la sindaca, ma semmai la sindaco. Questa del resto è la formulazione che l’Accademia della Crusca prescrive per i nomi di funzione che terminano col suffisso –ente, per cui si dirà il presidente e la presidente, il dirigente e la dirigente, ecc.
La trasmissione volgeva al termine, e nessuno si è preso la briga di rintuzzare Lilli Gruber, ma è evidente che era stato scritto un altro capitolo televisivo della saga della lotta contro il cosiddetto linguaggio sessista e a favore del cosiddetto linguaggio inclusivo. Che però inclusivo non è, ma piuttosto divisivo. Come spiega Bérénice Levet, critica radicale del femminismo radicale, nel suo libro Liberiamoci del femminismo! (non ancora tradotto in italiano) ma anche in un suo articolo che appare su Tempi di novembre,
«La femminizzazione del linguaggio rivendicata dalle femministe – dice questa pensatrice che quattro anni fa ha incenerito le teorie del gender definendole «il mondo sognato dagli angeli» – si basa su una concezione estremamente degradata e degradante delle donne: le donne si sentirebbero prese in considerazione solo da una lingua, da parole e da una sintassi che portano il marchio del femminile. La donna sarebbe dunque una specie di cane di Pavlov che non reagisce se non davanti a segnali sessuati. La scrittura inclusiva è un imbroglio perché non include nessuno: separa proprio quando pretende di riunire. La scrittura inclusiva mette i due sessi uno di fianco all’altro, li rinchiude nella loro identità, come se non avessero niente in comune, nessuna esperienza che li accomuna. Il maschile a portata universale, cioè il maschile al quale la lingua francese assegna il compito di dire l’universale, testimonia al contrario l’universalità della condizione umana, che non riguarda l’appartenenza a un sesso o all’altro».
Le femministe radicali vogliono abolire il linguaggio a portata universale, col pretesto che sarebbe connotato da un’egemonia maschile, e dunque fintamente universale. Quando si scrive e si dice “tutti” e “l’uomo” per intendere qualcosa che riguarda l’insieme degli uomini e delle donne, dei loro bambini e delle loro bambine, in realtà si riaffermerebbe la superiorità gerarchica del maschile sul femminile. Da qui la necessità di femminilizzare tante parole usate abitualmente al maschile per esprimere l’universalità di un concetto o di una funzione, oppure formule come “tutti e tutte”, “l’uomo e la donna”, ecc. Questa interpretazione del linguaggio come prodotto della lotta fra i sessi però è palesemente falsa, e non solo perché esistono molte parole di genere femminile che indicano concetti universali (l’umanità, la libertà, la verità, l’intelligenza, la ragione, la razionalità, la fede, la religione, la storia, la filosofia, la scienza, la fisica, la medicina, la biologia, la chimica, la giurisprudenza, la politica e chi più ne ha più ne metta), ma perché esistono anche molte parole di genere femminile che indicano funzioni e ruoli sociali che possono essere ricoperti tanto da uomini che da donne, e che anzi nella maggioranza dei casi sono ricoperti da uomini. Pensiamo a parole come la guida, la sentinella, la guardia, la vedetta, nel gioco del calcio l’ala e la mezzala, la maschera (nel senso di personaggio della commedia dell’arte), la staffetta (nel senso di corriere) e chissà quante altre. Se gli uomini che ricoprono una di queste funzioni fossero suscettibili come le femministe radicali, chiederebbero di essere ribattezzati il guardio, il sentinello, il guido, il maschero, ecc., così come le femministe radicali esigono che si dica la sindaca, la ministra, l’assessora, ecc.
Il femminismo radicale, è evidente, interpreta la realtà secondo lo stesso schema del marxismo, semplicemente sostituendo alla lotta fra le classi economiche la lotta fra i sessi. L’errore, come nel caso del marxismo, non sta nell’evidenziare che nella vita e nella storia si danno lotte e conflitti fra soggetti identificati da ruoli e funzioni diverse, ma nel pretendere che tali lotte siano la chiave di interpretazione di tutta la realtà: la vita e la storia sono fatte anche di lotta, ma non solo di lotta; i rapporti fra gli uomini e le donne sono conflittuali, ma non sono solo conflittuali, sono anche di reciproca attrazione, amicizia, collaborazione, amore. Per le femministe radicali, come per i marxisti, il senso della vita e della storia è la lotta per il potere, e ogni sovrastruttura, per usare la terminologia marxista, è impregnata dell’esito di tale lotta: il linguaggio non fa eccezione; dunque esso altro non è che il risultato del dominio degli uomini sulle donne, e dovrà cambiare man mano che i rapporti di forza si modificano (strutturalisti come Roland Barthes e marxisti come Pierre Bourdieu dicono cose simili riferendosi alla lotta di classe, al ruolo della borghesia, ecc.). Il principio che il linguaggio debba contenere termini universali, di genere maschile o femminile, è considerato un principio ideologico, che nasconde la vera natura conflittuale dei rapporti fra i sessi e il fatto che i maschi sono i dominatori.
Le conseguenze fatali di questo modo di vedere le cose sono le stesse del marxismo o della filosofia di Nietzsche: non esiste più un mondo comune agli uomini e alle donne, ai fornitori di capitale e ai fornitori di lavoro, ai deboli e ai forti, ai sani e ai malati. Non esistono più fatti, ma solo interpretazioni, tutto è soggettivo, tutto è sottomesso a interessi di parte. In una parola: non c’è alcuna verità, tutto è relativo. E chi si è rallegrato della fine della verità, perché da essa deriverebbe la liberazione dell’uomo (pardon: dell’uomo e della donna) e la possibilità per lui di ridefinirsi come superuomo (superdonna), farebbe bene a ricredersi: non la verità, ma il relativismo è la prigione sempre più claustrofobica nella quale vengono rinchiusi gli esseri umani. Perché in assenza della verità, che accomuna l’intero genere umano e permette di vedere il mondo come mondo comune, l’approccio alla realtà è definito dalla somma delle caratteristiche accidentali che ci confinano in gruppi umani sempre più ridotti e chiusi su stessi. Sesso biologico, genere sessuale, orientamento sessuale, colore della pelle, classe sociale, classe d’età ci incatenano in gruppi che conoscono solo se stessi e conoscono il mondo solo a partire dalle specificità del gruppo di appartenenza. Non ci può essere autentica comunicazione fra i vari gruppi, perché nessuno può emanciparsi dal soggettivismo della propria visione. Non si potrà più leggere una poesia, ammirare una pittura o una statua, ascoltare un brano musicale ricercando in essi un contenuto universale, perché anche l’arte sarà riassorbita nella logica del gender. Bisognerà decodificare le produzioni artistiche per riconoscere una poesia maschilista, una pittura femminista, una musica operistica machista, un’esposizione fotografica genderista… a questo saremo condannati!
Cancellare oggi il linguaggio universalista per sostituirlo con un linguaggio inclusivo femminilizzato significa assestare un altro colpo mortale alla speranza di ciascuno di noi di condividere lo stesso mondo con gli altri esseri umani. Significa estendere ulteriormente la logica della lotta per il potere come criterio di definizione di tutti i rapporti umani, inclusi quelli fra uomini e donne. Ma, come scrive Bérénice Levet,
«Questa narrazione è estremamente povera, completamente staccata dalla realtà che è sempre complessa e viva: non solo non ci sono soltanto rapporti di forza tra i due sessi – c’è complicità, gioco, soprattutto il gioco della seduzione -, (…) I due sessi ci vengono presentati come due comunità separate, due gruppi antagonisti, mentre fin dal principio si potrebbe dire che, se si pensa al racconto della Genesi, il loro destino è legato, l’uno discende dall’altro e insieme vengono cacciati dal Paradiso. Non si tratta di sviluppare una qualche pastorale, quale che sia, questi due sessi sono diversi e suscitano delle divergenze che non verranno mai superate. Non ci sarà mai la fine della storia. La narrazione è cominciata con la creazione di Adamo ed Eva e continuerà fino a quando questi due sessi si attrarranno, così simili e così diversi».
Decisamente abbiamo bisogno di più Levet e di meno Boldrini.

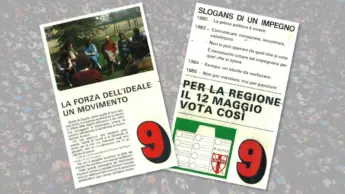

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!