
Contro il culto del progresso. Intervista a Bellamy

Articolo tratto dal numero di marzo 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
François-Xavier Bellamy, professore di filosofia, per oltre dieci anni vicesindaco di Versailles, fondatore nel 2013 a Parigi delle Serate della filosofia e dal 2019 parlamentare europeo eletto tra le fila dei Repubblicani, si conferma una delle figure più vivaci del panorama intellettuale francese. Dopo essersi fatto conoscere in Italia con il libro I diseredati ovvero l’urgenza di trasmettere, appassionato e coraggioso richiamo a concentrarsi sull’emergenza educativa come grande sfida del nostro tempo, torna in libreria con Dimora. Il volume, coeditato in Italia da Itaca e Fondazione De Gasperi, prende di petto un’altra grande malattia del mondo occidentale: la religione del progresso, abbracciata con entusiasmo o rassegnazione dai politici di ogni colore e schieramento. Una fede cieca nel futuro e nel superamento della natura umana così come la conosciamo che porta alla svalutazione nichilistica del presente e che spinge l’uomo verso il baratro del movimento perpetuo, dove non esistono più valori o tradizioni cui ancorarsi per orientare la propria vita.
Bellamy, tra le caratteristiche più preoccupanti dell’era del movimento perpetuo lei individua la «crisi del linguaggio». A prima vista sembrerebbe un problema secondario.
Invece non lo è, perché parola e pensiero sono intimamente legati e controllando la prima si può influire sul secondo. Nel nostro mondo domina il relativismo, non esistono più verità assolute e il linguaggio ne risente. Quando non si ha più niente da dire, perché niente di certo può essere detto, si può dire tutto e il linguaggio diventa onnipotente, perché non ha più regole da rispettare.
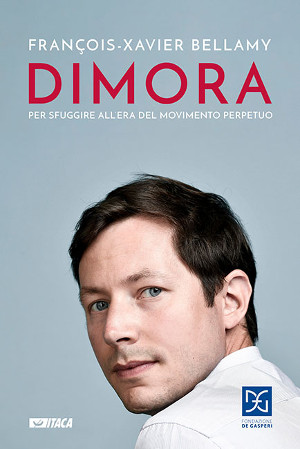
È per questo che nei documenti dell’Onu, ad esempio, non si parla più di “aborto” ma di “salute riproduttiva”, mentre in Francia si sta cercando di eliminare la differenza tra i generi con l’introduzione della “scrittura inclusiva”?
È normale che il linguaggio cambi e si evolva, ma ha un suo ritmo specifico e una sua vita particolare. La scrittura inclusiva, ad esempio, non è altro che un tentativo politico di cambiare la lingua dall’esterno. La logica è diversa e dietro questi tentativi c’è sempre una tentazione totalitaria. Oggi la politica cerca di cambiare il linguaggio per allinearlo ai nostri desideri di possesso e onnipotenza, in tanti campi dell’esperienza umana. Se ci sta davvero a cuore la libertà di pensiero, dobbiamo preoccuparci di più del modo in cui la politica vuole cambiare il nostro linguaggio.
Lei attacca la religione del progresso. Ma progredire non è certo qualcosa di negativo.
Il desiderio di progresso è universale e non è certo legato soltanto all’Occidente. Il problema della modernità è che identifica il progresso con ciò che è nuovo. Nuovo è diventato sinonimo di buono, ogni giorno ci dicono che il mondo nuovo sarà per forza migliore del vecchio. Questo è il problema. Oggi si profila una dicotomia insuperabile tra chi vuole cambiare a tutti i costi e chi vuole restare legato al passato. In realtà, la politica comincia quando si chiede: che cosa è bene per l’uomo? Chi dice che il progresso non si può fermare, che il mondo va avanti e che bisogna adattarsi non fa che abdicare alla sua responsabilità politica.
In Francia sta per essere approvata la legge di bioetica, che tra le altre misure estenderà la fecondazione assistita alle coppie di donne omosessuali e alle donne single con la conseguente eliminazione della figura del padre anche dal certificato di nascita. Progresso?
Si tratta di una sfida enorme perché per la prima volta nella storia si cerca di cambiare la natura della medicina. In passato il suo ruolo era quello di “riparare” l’uomo, di curare una malattia che debilita il fisico o la mente. Ora invece si chiede alla medicina di aumentare le potenzialità dell’uomo, superando i limiti della sua natura. Se due donne, pur desiderandolo, non possono avere un figlio non è perché sono malate, perché hanno un difetto, ma perché la natura umana non lo permette. Mettere il nostro potere tecnico al servizio del desiderio per andare al di là della condizione umana, significa entrare nella logica del transumanesimo. E io sono convinto che il transumanesimo è una forma di disumanità.

Progettare bambini affinché nascano senza padre è disumano?
Sì. Leggi come queste aprono una grande questione politica: vogliamo preservare e trasmettere alle generazioni future la natura umana oppure vogliamo dichiararle guerra scegliendo i nostri stessi corpi come campo di battaglia?
C’è ancora spazio per il dibattito politico su questi temi? A volte il destino sembra ineluttabile.
Il mio partito, i Repubblicani, si è opposto alla legge all’Assemblea nazionale e l’ha migliorata in Senato, per evitare il peggio, però è vero che la pressione sulla politica è ormai enorme. Troppi politici per la paura di opporsi e di non essere rieletti si adeguano all’opinione comune. Ma non deve per forza essere così: credo che la politica ritroverà la sua dignità quando tornerà a difendere ciò che in coscienza ritiene giusto.
Lei scrive che questo progressismo estremo non è altro che una forma di nichilismo: se il cambiamento, in quanto tale, è positivo «significa che questo mondo non vale nulla». Perché?
Se l’avvenire è in sé migliore del presente, allora il presente è disprezzabile. Se io sogno l’uomo aumentato, significa che attualmente sono un uomo diminuito. Il progressismo nasconde e alimenta una frustrazione collettiva che fa molto comodo alla società dei consumi: non abbiamo mai avuto la possibilità di soddisfare così rapidamente i nostri desideri e allo stesso tempo non siamo mai stati tanto frustrati e incapaci di amare ciò che abbiamo come adesso.
Il ragionamento si può applicare anche a un certo ambientalismo che individua nell’uomo il nemico numero uno della natura?
L’ecologismo non può limitarsi al discorso colpevolizzante che riduce l’uomo a un pericolo. Se i nuovi movimenti saranno invece in grado di farci riscoprire la fragile bellezza del mondo, allora saranno utili. L’uomo tra l’altro fa parte di questo patrimonio da proteggere, perché lo sguardo dell’uomo è l’unico in grado di contemplare il mondo. Il nostro dovere, allora, non è combattere l’uomo e opporlo alla natura, ma riscoprire che l’umano può salvare la bellezza del mondo attraverso una coscienza rinnovata.
La Commissione europea ha lanciato il Green Deal per fare dell’Europa il primo continente a impatto zero entro il 2050. Da eurodeputato come lo valuta?
Il progetto può essere importante, soprattutto se aiuterà i paesi a riscoprire che non esistono solo economia e commercio. L’Unione Europea può fare da apripista però non deve sottovalutare un pericolo: qui non si tratta solo di un problema economico, ma soprattutto politico che riguarda il mondo intero. E come tale va affrontato. Potremo essere utili se sapremo offrire una visione per servire il mondo e l’uomo ispirata alla nostra identità e alle nostre radici.
Esiste un antidoto al fascino del movimento perpetuo che travolge le nostre società?
L’antidoto che evoco nel libro, me ne rendo conto, può essere scioccante. Sono tuttavia certo che la letteratura, e in particolare la poesia, possano davvero aiutarci a mettere un freno a un mondo dove tutto è flusso, algoritmi e big data. In una vita dominata dal digitale e da internet è sempre più difficile leggere libri, ma frequentare il mondo della parola, con la pazienza e la distanza che questo esige, può aiutarci a tornare a contemplare la realtà. Per rinunciare al nichilismo della religione del progresso dobbiamo ritrovare nella poesia l’origine dello stupore che ci permetterà di guardare il reale senza distorsioni e che ci darà la forza di preservare la vita per le generazioni future. Gilbert Keith Chesterton diceva: «Il mondo non finirà per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia». La più grande urgenza politica è poetica.
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!