
Il sugo della storia
Come Alessandro Manzoni si convertì al cattolicesimo grazie al matrimonio

Papa Francesco ha sorpreso tutti proponendo I promessi sposi come un’opera formativa sul fidanzamento: «In Italia avete un capolavoro sul fidanzamento, non lasciatelo da parte, i giovani debbono leggerlo […]. È un capolavoro dove si racconta la storia dei fidanzati che hanno subito tanto dolore, hanno fatto una strada di tante difficoltà, fino ad arrivare alla fine al matrimonio. Non lasciate da parte quest’opera, andate avanti a leggerla e vedrete la sofferenza e anche la fedeltà di questi fidanzati».
Di tutto si era scritto sul romanzo, l’opera era stato letta come l’epopea della provvidenza, il romanzo sugli umili, un testo in cui il Seicento diventa il protagonista assoluto, l’emblema dei potenti che schiacciano gli umili. L’elenco delle interpretazioni potrebbe non finire mai. Ripartiamo allora dal fatto che I promessi sposi non è soltanto il romanzo più importante che sia stato scritto nella nostra letteratura, ma rappresenta in forma concreta e incarnata il genio del cristianesimo. Bisogna riscoprire prima il percorso di fede e di conversione dello scrittore.
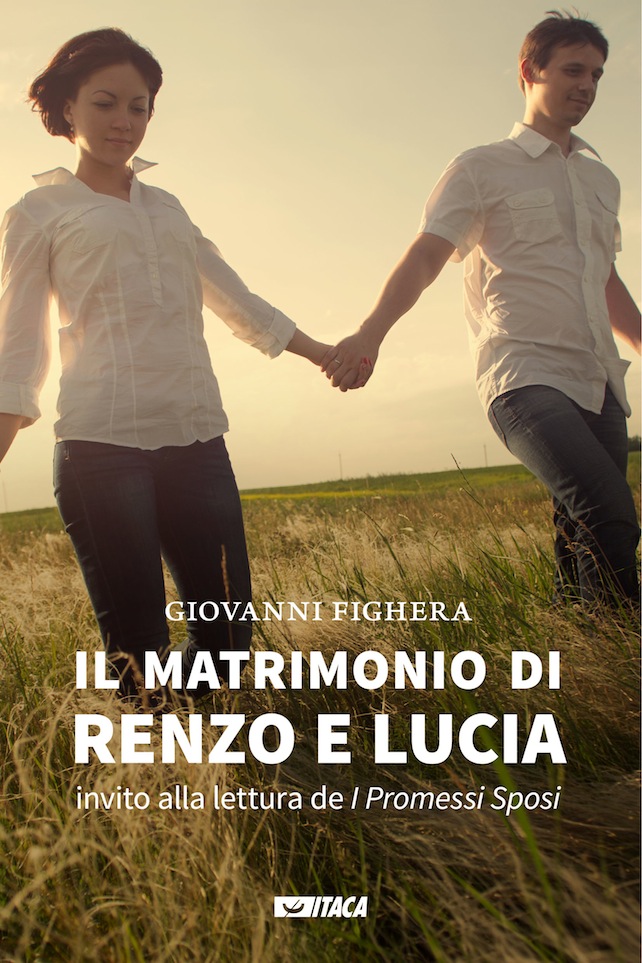 Si è scritto che Manzoni è stato sempre refrattario a parlare della sua conversione. L’aneddotica riduce questo percorso lungo, durato qualche anno, al celebre episodio accaduto nella chiesa di San Rocco a Parigi. Durante il matrimonio di Napoleone (2 aprile 1810) la moglie sviene, Manzoni si perde e in una crisi di agorafobia si rifugia in chiesa a pregare. Ne esce convertito e ritrova la moglie. In realtà, molte sue lettere riferiscono i passi compiuti nel cammino di conversione. Ermes Visconti, uno degli amici più intimi di Manzoni, comprende che il cammino di fede di Alessandro è adombrato nella vicenda centrale dei Promessi sposi, la conversione dell’Innominato.
Si è scritto che Manzoni è stato sempre refrattario a parlare della sua conversione. L’aneddotica riduce questo percorso lungo, durato qualche anno, al celebre episodio accaduto nella chiesa di San Rocco a Parigi. Durante il matrimonio di Napoleone (2 aprile 1810) la moglie sviene, Manzoni si perde e in una crisi di agorafobia si rifugia in chiesa a pregare. Ne esce convertito e ritrova la moglie. In realtà, molte sue lettere riferiscono i passi compiuti nel cammino di conversione. Ermes Visconti, uno degli amici più intimi di Manzoni, comprende che il cammino di fede di Alessandro è adombrato nella vicenda centrale dei Promessi sposi, la conversione dell’Innominato.
Sono milleottocento le lettere scritte da Manzoni dall’età di diciotto anni fino al 1873, l’anno della morte, pubblicate per conto dell’editore Adelphi. Rivolte ad amici, intellettuali, parenti e conoscenti, perfino al Papa, ci informano anche della sua vita privata e sentimentale, con quel riserbo che diverrà cifra caratteristica del letterato lombardo.
Particolarmente interessante è la lettura della corrispondenza del Manzoni dal momento in cui si fidanza con Enrichetta Blondel fino al matrimonio, prima con rito calvinista e poi con rito cattolico. Permette di comprendere meglio il percorso di conversione spesso tramandato a noi attraverso l’aneddotica.
A Giovanni Pagani nel 1808 Manzoni così si rivolge: «Ho trovato una compagna che riunisce tutti i pregi che possono rendere veramente felice un uomo, e me particolarmente». Nell’ottobre del 1809 Manzoni scrive a papa Pio VII informandolo del fatto che si è unito in matrimonio con Enrichetta Blondel secondo il rito della religione riformata e che è nata una «fanciulla la quale è stata battezzata cattolicamente, secondo il rito della S. Romana Chiesa». Ora, lo scrittore intende riparare al suo errore sposandosi di nuovo con l’amata secondo il rito cattolico. La data di questa lettera è ben precedente l’aneddoto della chiesa di San Rocco, che risale all’aprile del 1810, come lo è la celebrazione del matrimonio con rito cattolico il 15 febbraio 1810 ad opera dell’abate Costaz, «curato della parrocchia della Madeleine, nella residenza di Ferdinando Marescalchi, ministro degli Esteri del Regno Italico in Parigi, il quale fu anche testimonio per Alessandro Manzoni».
Il 29 giugno 1810 da Torino Manzoni informa Gaetano Giudici, abate giansenista, che Enrichetta si è risoluta a entrare in seno alla Chiesa cattolica grazie all’aiuto dell’abate Eustachio Degola. Il 22 maggio 1810 l’amata ha abiurato alla propria religione provocando la collera della famiglia Blondel, in particolar modo della madre. Per questo Manzoni chiede a Giudici, che è stimato dai Blondel, di farsi intermediario per la riconciliazione. Enrichetta, assai sensibile e affezionata ai genitori, già incinta, soffre immensamente per questo contrasto. Manzoni si dice disposto a incontrare in qualsiasi momento i suoceri e aggiunge, parlando dell’amata moglie: «Essa sta ora scrivendo all’amatissimo suo Padre, e si unisce a me per caldamente pregarla di avvalorare le tenere sincere ed umili supplicazioni ch’essa porge ad un Padre, verso del quale non è rea per nulla, non avendo fatto altro che disporre liberamente della propria coscienza».
Manzoni parla dell’atto della moglie come «innocentissimo e legittimo». Come prosegue la relazione di Enrichetta con i genitori? Si risolve? E in caso affermativo, come? Al riguardo leggiamo la lettera che Manzoni indirizza al padre spirituale Degola nel luglio 1810: «Questi [i genitori di Enrichetta], dopo aver continuato per primi giorni nella durezza loro, si mossero finalmente a proporre a mia moglie di andarli a trovare, promettendo di non far parola dell’occorso. La lettera fu scritta da sua madre, che ricevé la figlia a braccia aperte. Né mia madre né io non potemmo assistere, essendo stata mia madre esclusa assai incivilmente, ed io invitato in un modo che considero come un discacciamento. Qualche giorno dopo mia moglie tornò sola a casa sua, dove le fu fatto qualche rimprovero, che se, grazie a Dio, non influì in nulla sulle determinazioni sue, le cagionò però amarezza assai».
Nella stessa lettera Manzoni informa Degola che il canonico Tosi ha fatto visita a lui e alla madre Giulia promettendo di «preparare sollecitamente Enrichetta ai Sacramenti, ed alla Confermazione in ispecie». Manzoni chiede al Degola di continuare a offrire il suo sostegno alla moglie con le lettere, i conforti e le consolazioni. In seguito alla richiesta di Degola, Tosi diviene padre spirituale del Manzoni, incarico che tiene fino al 1823, quando è eletto vescovo di Pavia e viene a quel punto sostituito da Giudici. L’influenza di Tosi sugli Inni sacri, sulla Morale cattolica e sul romanzo è notevole: ad esempio, la soppressione dell’episodio della monaca di Monza sarebbe in parte dovuta a lui.
Nel 1811 si nota come l’affetto e la stima per il nuovo padre spirituale Tosi crescano tanto che Manzoni può a lui parlare della sua «profonda indegnità» e, nel contempo, di quanto possa in lui operare «la Onnipotenza della Divina Grazia». Al Tosi, nel giugno del 1811, Manzoni scrive «di pregare il buon Gesù che non si stanchi di farne risplendere i miracoli in un cuore che ne ha tanto bisogno».
Il 27 agosto 1811 Manzoni si reca dal padre spirituale per la confessione, che avverrà nel giorno di sant’Agostino (28 agosto), un grande convertito. Tosi scrive il giorno stesso a Degola: «Alessandro ha intrapresa la carriera con estrema docilità e sommessione; domani avremo ancora una lunga conferenza e, se il Signore conserva e accresce il lui le sue benedizioni, egli pure sarà per fare gran passi».
Nel settembre nasce Luigina Maria Vittorina Manzoni, che sopravvive solo alcune ore. Nella lettera del 7 settembre, Manzoni scrive a Degola: «In mezzo ai suoi travagli il Signore le [ovvero alla moglie Enrichetta] diede la consolazione di aver presente il canonico Tosi […]. Egli la confortò e consolò assai, e quel che più importa, spero l’avrà aiutata a cavare dai suoi travagli un maggior profitto spirituale […]. Preghi ella perché piaccia al Signore scuotere la mia lentezza nel suo servizio e togliermi da una tepidezza che mi tormenta, e mi umilia; giusto castigo per chi non solo dimenticò Iddio, ma ebbe la disgrazia e l’ardire di negarlo. Ma se il desiderio mio è per la gloria di Lui, e se sarà avvalorato dalle sue orazioni spero vederlo esaudito».
Articoli correlati
4 commenti
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!



Per quanto mi riguarda credo in Dio e rispetto l’istituzione ecclesiastica al punto di non guardare al sinodo come si guarda ad una partita di calcio. Per il resto penso che alla mia età sia abbastanza normale scegliere di perseguire un ideale di giustizia. Non potrei dirmi praticante perché sono consapevole del fatto che la mia fede non è tanto forte da farmi entrare nell’ottica della misericordia. Questo non significa che io non ci creda o che non sarei in grado di concepirla per le grandi questioni. Per quanto riguarda la mia persona non dimentico… per carità: mi fa piacere vivere in maniera armoniosa, ma lo vedo come un dovere di civiltà. Per il resto ho le mie opinioni ed è molto difficile che le cambi… in teoria potrei anche praticare perché non è necessario essere santi per far parte della Chiesa. Si tratta di un cammino!
Uno studio che farà molto discutere, proveniente dagli USA, sostiene che la possibilità di credere in Dio diminuisce con l’aumentare dell’intelligenza. Il team di ricerca composto da Miron Zuckerman e Jordan Silberman della University of Rochester e da Judith Hall della Northeastern University di Boston ha esaminato i risultati di 63 studi precedenti condotti tra il 1928 ed il 2012, conducendo una meta-ricerca sul rapporto tra intelligenza e religiosità.
Per il loro studio, pubblicato su Personality and Social Psychology Review, i tre psicologi hanno definito l’intelligenza come “l’abilità di ragionare, pianificare, risolvere problemi, pensare in modo astratto, comprendere idee complesse, imparare velocemente ed apprendere dall’esperienza”. La religiosità è stata invece definita come il coinvolgimento in alcuni degli aspetti della religione (o anche in tutti), come il credere ad un entità soprannaturale o il prendere parte a rituali che affermino queste credenze.
Lo studio più datato analizzato dai tre ricercatori è quello condotto da Lewis Terman della Stanford University nel 1921, che analizzò 1.500 bambini che all’età di 10 anni avevano un QI superiore a 135. I risultati, confermati anche da due revisioni precedenti rispetto allo studio di Zuckerman, Silberman e Hall, mostrarono che questi bambini avevano un livello di religiosità inferiore alla media, e questo nonostante il fatto che oltre il 60% di loro fosse cresciuto in famiglie fortemente religiose.
Un altro studio preso in esame è stato quello condotto dalla Hunter College Elementary School di New York, che ha preso in esame laureati con un’età compresa tra 38 e 50 anni, e con un QI pari o superiore a 140. Solamente il 16% di loro ha affermato di aver ottenuto una qualche forma di soddisfazione personale dalla religione.
Delle 63 ricerche prese in esame, 53 mostrano una correlazione negativa tra religiosità ed intelligenza (quando una aumenta l’altra diminuisce) e 10 mostrano una correlazione positiva (all’aumentare di una aumenta anche l’altra).
“La nostra conclusione non è nuova. Ciò che abbiamo fatto è ottenere questa conclusione in modo più accurato attraverso l’analisi statistica”, ha affermato Zuckerman, precisando come il team si sia concentrato sull’elaborazione di possibili spiegazioni della correlazione negativa.
Una prima possibilità riguarda il fatto che le persone più intelligenti tendono ad essere anti-conformiste e, di conseguenza, avranno più probabilità di “resistere al dogma religioso”, come dimostrato dalla meta-analisi di sette studi condotta nel 1992, che mostra come le persone intelligenti abbiano una maggiore possibilità di diventare atee se crescono in comunità fortemente religiose.
Una seconda opzione sostiene che le persone intelligenti tendono ad utilizzare uno stile di pensiero analitico, e non amano accettare alcuna credenza che non sia soggetta a test empirici e ragionamenti logici.
La terza possibile spiegazione sostiene che varie funzioni ottemperate dalla religiosità, come senso di controllo, auto-regolazione, auto-arricchimento ed il fatto di avere un’entità alla quale “connettersi emozionalmente” in caso di necessità, possano essere ottenute anche tramite l’intelligenza.
da dove arriva questo studio ? Ah dagli Stati Uniti….Chissà mai chi lo ha commissionato …
Milioni e milioni di imbecilli dunque , secondo queste intelligenze statunitensi, nei secoli dei secoli ? vien da sorridere per non sghignazzare.
E se la gran parte di questi cosidetti INTELLIGENTONI, consci della loro condizione intellettuale privilegiata, diventassero semplicemente SUPERBI (il più grave dei peccati non dimentichiamolo…)?? A questa eventualità, ovvoamente, questi “intelligenti” ricercatori non hanno pensato, vero??? Ma che strano……