
Chiavi (musicali) per capire la realtà

Articolo tratto dal numero di febbraio 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
La musica è una preziosa chiave di lettura per comprendere il reale in profondità. È questo, secondo il maestro Stefano Mainetti, il primo e più importante valore aggiunto che l’arte dei suoni e della composizione può offrire alla formazione dei più giovani e al sistema scolastico italiano nel suo complesso, che pure non sembra ancora essersene reso conto del tutto. Romano, classe ’57, Mainetti è compositore e direttore d’orchestra, con una lunga esperienza, non soltanto nel campo della musica “assoluta”, ma anche di quella “applicata”: al cinema, al teatro, alla televisione e ai nuovi media. Un percorso che gli consente di avere una chiara visione anche dei reali sbocchi che lo studio della musica può offrire sul mercato del lavoro, comprese le nuove professionalità legate al digitale.
Dopo il liceo, frequenta a Roma il Conservatorio di Santa Cecilia dove conclude il corso di composizione con il massimo dei voti e dove oggi è docente di Composizione per la Musica applicata alle immagini. Mainetti è anche tra i fondatori dell’Associazione compositori musica per film ed è uno dei compositori degli album Abba Pater e Alma Mater che hanno avuto due protagonisti d’eccezione: le voci di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ecco cosa ci ha detto in una conversazione che ha spaziato dal valore pedagogico della musica al sound design, da Johann Sebastian Bach ad Alfred Hitchcock.
Quale fattore caratterizza la musica classica dal punto di vista educativo?
Tutta la musica offre una chiave di lettura in più sulla realtà, è uno strumento di interpretazione potente: è ciò che dico sempre ai miei alunni. Come materia della scuola primaria, ritengo che la musica dovrebbe avere la stessa dignità delle altre discipline umanistiche così come di quelle scientifiche, invece non è così: purtroppo, in Italia, l’ora di musica è spesso equiparata a un momento di ricreazione, di svago, ma soprattutto manca una vera preparazione all’ascolto.
In che modo la musica aiuta a comprendere la realtà?
Prendiamo come esempio il contrappunto bachiano, alla cui base ci sono regole che subiscono un forte influsso della matematica, con incastri molto complessi: è evidente che un simile linguaggio contribuisce a sviluppare una sensibilità profondamente legata alla logica. Senza dimenticare il contributo che la musica può dare alla comprensione della profondità dimensionale: la musica, infatti, si sviluppa sia in senso orizzontale (melodia) sia in senso verticale (armonia); ma ci sono anche la dimensione temporale e quella dello spazio, argomento peraltro su cui si basa il mio progetto di musica aumentata “Rendering Revolution”, che dopo la presentazione al Maxxi di Roma sarebbero felici di ospitare al Fad (The Fostering Arts and Design) di Barcellona.
Sono spunti che possono essere compresi da tutti?
Chiunque può comprendere il linguaggio della musica e tutti possono progressivamente arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. Ciò non significa che non sia utile adottare una certa gradualità nell’insegnamento. Anzi è opportuno. Sarebbe sbagliato, infatti, partire con l’ascolto di Stockhausen per un bambino di 3 anni; molto meglio prendere le mosse da un approccio semplice, da basi tonali più facili da comprendere, e pian piano alzare l’asticella fino a strutture musicali via via più complesse.
Quali sono, a suo avviso, i più evidenti limiti dell’insegnamento scolastico della musica in Italia?
Sono aspetti che si possono facilmente cogliere prendendo in esame i programmi delle scuole primarie e paragonandoli al resto d’Europa. Ciò che più di tutto salta all’occhio è la mancanza dell’educazione all’ascolto e mi riferisco in particolare ai protagonisti fondamentali della storia della musica. Il flauto, poi, è uno strumento nobilissimo, sia chiaro, ma è monodico; ritengo che non sia l’ideale per schiudere a un giovane l’orizzonte più ampio dell’armonia. Così facendo si preclude fin da subito la possibilità di capire cosa sia la musica nella sua complessità. E perché, mi domando, limitarsi a un’ora soltanto di musica alla settimana quando abbiamo tra le mani un così potente strumento di educazione per sviluppare la sensibilità dei nostri ragazzi?
Cosa si sente di consigliare a un giovane che dovesse avere il “pallino” della musica, un particolare talento oppure anche soltanto un gusto e un interesse genuino per essa?
Intanto di ascoltare, di ascoltare molto e non limitarsi ad un solo genere: anche se lo diamo per scontato, in fondo, resta la cosa più semplice da fare. E poi di andare ai concerti (noi italiani siamo tra i popoli europei che vanno meno ai concerti di musica classica secondo dati Siae), di confrontarsi, di studiare e infine di valutare se questa particolare sensibilità necessiti di essere affinata ulteriormente ed eventualmente indirizzarsi verso percorsi di formazione come scuole professionali e conservatori, che oggi hanno assunto una struttura universitaria. Dalla riforma Gelmini in poi, infatti, l’offerta in questo campo è cresciuta notevolmente, con la possibilità per di più di conseguire un titolo universitario.
Oggi è ancora possibile fare della musica una professione?
È la musica che sceglie te, non viceversa e se ti ha scelto non ne puoi fare più a meno. Nonostante ciò credo che non sia questo il periodo storico più favorevole al fiorire delle arti; forse è più il momento della scienza, anzi direi della tecnologia. Per quanto riguarda il nostro settore, quando io decisi di fare musica da film, cinema, teatro o televisione, e per tutti gli anni ’70 e ’80 si producevano in Italia qualcosa come 400 film all’anno. Oggi se ne producono dieci volte di meno, ma sono aumentate le produzioni all’estero e si è allargata la base di quelle che guardano al mercato delle piattaforme e dello streaming, aprendo a nuove professioni proprio grazie alla tecnologia.
Poi ci sono anche brand globali, per esempio quelli di note case automobilistiche o istituti di credito, che sono alle prese con la ridefinizione dell’identità sonora e che per avere un audio logo efficace investono in creatività.
Il discorso dell’identità sonora riguarda anche la musica da film e più in generale tutta la musica applicata. In questo senso si avverte un cambiamento in favore di nuove sonorità che aprono di conseguenza a nuove professionalità; c’è la possibilità di andare ad occupare quegli spazi che sono a metà strada tra la musica e il computer, tra la tecnologia e l’arte. Mi riferisco in particolare al sound design e a quello spettro di figure professionali che sono derivate dai rumoristi di un tempo e che, grazie proprio alla tecnologia, si pongono come interfaccia tra il compositore e la colonna sonora in senso stretto. È vero anche che l’elettronica oggi ha invaso il nostro settore e spesso questo è motivo di arricchimento. D’altro canto già grandi compositori di colonne sonore del passato si erano cimentati con suoni “altri” non compresi negli organici classici, e questo avveniva ben prima dell’avvento del computer. Uno su tutti: Bernard Hermann, il compositore di elezione di Alfred Hitchcock.
Lei in carriera si è occupato anche di musica sacra: che esperienza è stata?
Ho avuto la possibilità e l’onore di far cantare due papi, prima Giovanni Paolo II, registrando Abba Pater, insieme a Leonardo De Amicis, e poi Benedetto XVI, componendo insieme a Simon Boswell il cd Alma Mater, registrato a Londra negli studi di Abbey Road (episodio che, con mia sorpresa, è stato citato anche nel film I due Papi). È stato senza dubbio un percorso diverso rispetto alle colonne sonore, un percorso di musica sacra e assoluta, in quanto svincolata dalle immagini, e che mi ha messo in contatto con il mondo della fede e della religione. Ne sono uscito arricchito, soprattutto da un punto di vista spirituale.


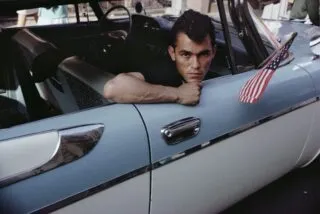
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!