
Centri di salute e ascolto accompagnano le donne immigrate nella gravidanza
Si è opposta risolutamente a un taglio cesareo, tanto che è dovuta intervenire la polizia per calmare gli animi in reparto. È il caso di una ragazza appena ventunenne, originaria del Burkina Faso. È successo a Treviso, nell’ospedale di Ca’ Foncello, ma potrebbe trattarsi di una qualsiasi struttura italiana. È un episodio limite, certo, che fa notizia, ma che mette in luce l’esistenza di un problema con cui il sistema sanitario sta facendo i conti da anni.
In una società in cui la presenza di immigrati conta 4 milioni e 300 mila persone, e il tasso di natalità è ormai sostenuto soprattutto dalle donne straniere, il tema degli aspetti cosiddetti transculturali non può essere ignorato. «In particolare la gravidanza, il parto, e il puerperio in terra straniera richiedono agli operatori un’attenzione particolare: l’assenza della rete familiare e l’incontro con un sistema simbolico differente dal proprio pone le madri immigrate in una posizione di maggiore fragilità». Elena Gavazzi è presidente della Cooperativa Crinali, che ha attivato due “Centri di salute e ascolto per le donne immigrate e i loro bambini” presso due strutture milanesi.
Obiettivo? Accompagnare, sostenere e accogliere la donna nella sua gravidanza, per evitare episodi emergenziali come quello di Treviso. «In linea generale questi irrigidimenti sono dovuti alle incomprensioni reciproche, prima di tutto linguistiche, e poi culturali. Possono esserci pregiudizi da parte degli stranieri rispetto alla struttura italiana: c’è sospetto, c’è timore». Per questo è essenziale trovare un ponte di comunicazione, e la figura del mediatore linguistico-culturale sta diventando sempre più diffusa e capillare. In due ospedali ad alta affluenza come il San Carlo Borromeo e il San Paolo, a Milano, i centri di ascolto sono aperti dal 2002, grazie ai finanziamenti della regione Lombardia destinati all’immigrazione. Un’esigenza fortemente sentita dal territorio: lo scorso anno gli utenti totali sono stati quasi duemila. Il Centro è aperto tre giorni a settimana, ed è ad eccesso diretto: dopo un primo colloquio di accoglienza sono previste visite ginecologiche e ostetriche, colloqui pre/post interruzione di gravidanza (con consulenza sulla contraccezione), colloqui sociali, psicologici, visite pediatriche per il primo anno di vita del neonato alla presenza di una neuropsichiatra infantile, corsi di accompagnamento alla nascita.
Si crea così una rete sia interna che esterna all’ospedale, tramite i contatti con gli altri servizi dedicati alle problematiche degli immigrati. Inoltre la presenza costante delle mediatrici contribuisce a diminuire le difficoltà che il reparto di Ginecologia e Ostetricia può incontrare con le donne migranti: «In Italia la gravidanza è cadenzata da visite ed ecografie, monitorate da specialisti e garantite dal sistema sanitario nazionale. Molte immigrate non sono a conoscenza della possibilità di accedervi e spesso cominciano l’iter medico a gravidanza inoltrata: spesso le nordafricane arrivano al Centro al settimo o ottavo mese di gravidanza, quindi nel momento in cui si preoccupano realmente della struttura dove andranno a partorire».
Le operatrici, che si servono delle mediatrici per comunicare con le utenti, devono quindi spiegare loro le procedure a cui vengono sottoposte, in modo che apparecchiature sconosciute non vengano viste come più intrusive di quanto non siano. Strumenti come l’ecografia o le pratiche per la diagnosi prenatale possono andare incontro al rifiuto o alla disapprovazione di alcune donne, che considerano alieno e spaventoso vedere il feto prima della nascita. «Il disagio e le problematiche di tipo fisico che le pazienti migranti esprimono sono spesso strettamente intrecciati con problemi di ordine psicologico o sociale», spiega Elena Gavazzi. Non bisogna generalizzare: «Non è il caso di chi proviene da una grande città, e aveva una fascia di reddito medio-alta». Per tutte le altre, però, ci sono tutta una serie di barriere culturali da abbattere.
La prevenzione, per esempio è un concetto fuori dalle loro aspettative. C’è poi un aspetto legato alle culture del Maghreb, che spesso entra in conflitto con la medicalizzazione: «In Italia siamo abituate a ostentare la gravidanza, è un atteggiamento che nasce dalla fierezza, dalla contentezza, dall’emancipazione. In Nord-Africa invece prevale l’idea di protezione: il feto va nascosto da possibili influssi negativi che possono arrivare dal mondo esterno. Dagli sguardi d’invidia, che potrebbero attaccargli il malocchio». Una superstizione per alcune e un’attitudine alla discrezione per la maggioranza. Cosa si fa in questi casi? «Si agisce con un po’ di buonsenso. Si spiega di cosa si tratta, innanzitutto. E nell’80% dei casi, è sufficiente. Nel restante 20% la donna acconsente all’ecografia, ma magari preferisce non guardare il monitor».
Un periodo sensibile come quello dell’attesa di un figlio, viene appesantito dal senso di solitudine e nostalgia che le migranti provano lontano da casa. Essere distanti dalla propria madre e dalle altre figure che normalmente si prenderebbero cura di loro contribuisce a rendere le future madri più vulnerabili: «L’ambiente estraneo può rivelarsi un impedimento anche alla messa in atto di tutte quelle regole, tradizioni, norme alimentari e tabù che nel proprio paese sarebbero dati per scontati». La dimensione di gruppo, persa con la migrazione, può però essere recuperata mediante la disposizione di spazi in cui rielaborare le rappresentazioni della nascita e della maternità. E lo scambio di saperi fra donne di culture differenti può aiutare a ricreare un senso di fiducia nella propria capacità.
«Gli incontri predisposti dal Centro prevedono una parte di lavoro corporeo, un’altra in cui vengono fornite informazioni pratiche essenziali (sulla gravidanza, sul parto, sull’ospedale) e infine una fase di conversazione libera, in cui le donne del gruppo possono portare i propri dubbi, curiosità o esprimere i propri stati d’animo. Molta importanza viene data alla condivisione di rappresentazioni e abitudini relative alla gravidanza, al parto e alle pratiche di cura dei diversi paesi di provenienza, con l’obiettivo di valorizzarle e di elaborare insieme molteplici possibilità di essere madri». È fondamentale, perché «rielaborare le sofferenze relative alla migrazione influenza tanto la vita della madre, quanto un domani quella dei figli».


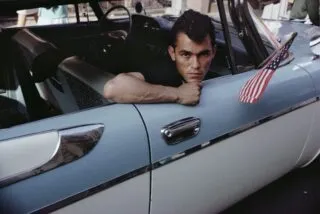
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!