
Il Deserto dei Tartari
Accecato dall’odio per Berlusconi, l’Economist prende un granchio dietro l’altro
Nelle ultime settimane abbiamo più volte manifestato il nostro apprezzamento per la stampa anglosassone, che ha saputo guardare con obiettività alla crisi dell’euro e alle sue radici e mettere nella giusta prospettiva il caso rappresentato dall’attacco al debito pubblico italiano. Dal Wall Street Journal al Daily Telegraph e al New York Times, sono stati numerosi i commentatori che hanno avuto il buon gusto di spiegare che non è stata l’Italia ad infettare l’euro, ma le debolezze intrinseche dell’euro e dei trattati che ne regolano la governance ad infettare il debito pubblico italiano. Fa eccezione in negativo The Economist che, troppo condizionato dalla sua storica animosità nei confronti di Silvio Berlusconi, mostra ancora una volta una straordinaria miopia per tutto ciò che riguarda la politica italiana, e anche una preoccupante mancanza di intelligenza sul significato della crisi dell’euro.
L’eccesso di antagonismo fa sì che il settimanale londinese cominci subito col piede sbagliato, attribuendo al presidente del Consiglio uscente “otto e mezzo disastrosi anni al potere”, quando in realtà, disastrosi o meno, sono stati più di nove. E arriva a intitolare un paragrafo del suo editoriale sulle dimissioni di Berlusconi “The man who screwed an entire currency”, “L’uomo che ha fottuto un’intera valuta”: una forzatura di giudizio che nemmeno il più animoso dei critici di Berlusconi riuscirebbe a sottoscrivere, e che serve solo a far tornare alla mente che l’Economist è il giornale su cui scrisse dell’Italia Tana De Zulueta, poi deputato al parlamento italiano nelle file prima dell’Ulivo e quindi dei Verdi, e che fu diretto da Bill Emmott, colui che nel 2001 fece titolare una copertina “Why Berlusconi is unfit to lead Italy” e che recentemente si è manifestato come un estimatore delle posizioni politiche di Nichi Vendola.
Il passaggio più interessante del commento, quello che esprime perfettamente i limiti intellettuali del team dell’Economist, è però il seguente: «L’Economist ha a lungo sostenuto che il signor Berlusconi era inadatto a governare, ma noi stessi siamo rimasti scioccati dal modo in cui, nel momento in cui la crisi dell’euro si è avvicinata all’Italia, si è dedicato alle occasioni sociali e al bricolage politico, ignorando la necessità di riforme». In modo ancora più chiaro qualche tempo fa aveva espresso la sua sorpresa e incapacità di trovare spiegazioni Bill Emmot in un articolo sulla Stampa: «Avevamo ragione a descrivere Silvio Berlusconi come “inadatto a guidare l’Italia”, ma non avevamo capito che la parola cruciale non era “inadatto”, ma “guidare”. Né lui né nessun altro nella politica italiana mostra alcun interesse a guidare l’Italia». Non vorremmo sembrare irrispettosi con i colleghi anglosassoni, ben più bravi di noi, ma compito del giornalista, specie se presunto autorevole, non è quello di esprimere la propria meraviglia di fronte a comportamenti politici inesplicabili, ma di capire quei comportamenti e di spiegarli ai lettori. Accecati dall’orribile visione di Berlusconi, Emmott e soci in questi anni non hanno avuto occhi e cervello per analizzare e quindi spiegare ai propri lettori la paralisi della politica italiana e più in generale l’impasse della sua classe dirigente. Non hanno saputo spiegare che dopo Mani Pulite e la fine della Prima Repubblica la politica italiana è rimasta ostaggio di forze che hanno creato i loro presidi in mezzo alle macerie: la magistratura, i sindacati, il ristretto circolo della finanza e la più inefficiente associazione degli imprenditori d’Europa (Confindustria).
Costantemente rintuzzato e tenuto all’angolo da queste forze (soprattutto da un circolo mediatico-giudiziario senza uguali nel mondo, sulle cui origini e modalità di funzionamento l’Economist non ha mai speso uno sputo di analisi), l’indebolito Berlusconi è rimasto esposto a tutte le trame di alleati che non pensavano ad altro che a disarcionarlo (Casini e Fini) o che approfittavano della situazione per alzare continuamente il prezzo della propria lealtà (Lega Nord). Berlusconi ha fatto poco, d’accordo. Ma forse non per pigrizia o incapacità. Forse perché le fortezze a cui Berlusconi aveva promesso di dare l’assalto non erano espugnabili. Il fatto che, come dice Emmott, non solo Berlusconi ma tutti i politici italiani diano un’impressione di impotenza, non dovrebbe fare alzare le antenne a giornalisti di razza? L’incapacità di approfondimento del settimanale londinese diventa vera e propria confusione mentale quando ricorda le carte che l’Italia può ancora giocare: «Senza il signor Berlusconi, l’Italia ha ancora una possibilità di farcela. Il suo stock di debito, benchè elevato, è stabile. Non ha sofferto una bolla immobiliare o fallimenti di banche. Prima del pagamento degli interessi, l’Italia presenta addirittura un avanzo primario di bilancio». Ma come, non sono stati otto anni e mezzo (errata corrige: nove e più) disastrosi? Troppo compromettente ammettere che l’impresentabile Berlusconi è riuscito almeno a non far degradare alcuni fondamentali dell’Italia?
L’ingenuità dell’Economist non si limita alle questioni italiane. Sul tandem franco-tedesco che guida (per modo di dire) l’Europa riesce a produrre la seguente perla: «I rischi che l’euro si frantumi sono veramente cresciuti. Il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy hanno riconosciuto per la prima volta al recente summit del G20 che potrebbero abbandonare la Grecia al suo destino – un devastante riposizionamento da parte di leader che avevano sempre insistito che l’euro sarebbe sopravvissuto a qualunque prezzo. Si dice che stiano contemplando l’idea di un nuovo club di paesi del nocciolo duro dell’euro che saprebbero rispettare le regole, e di liberarsi di tutti gli altri». Qui a noialtri ci scappano due grosse risate. La prima riguarda il “devastante riposizionamento” del duo Merkel-Sarkozy: qui quelli dell’Economist o ci sono, o ci fanno. Tutti lo sanno che il destino della Grecia è segnato da tempo, e quel che l’Europa sta facendo è semplicemente guadagnare tempo per limitare i danni alle banche francesi e tedesche che hanno sottoscritto titoli pubblici greci e preparare l’eurozona all’inevitabile fallimento della Grecia.
La seconda risata riguarda la minaccia franco-tedesca di mandare tutti al diavolo e creare un supereuro per paesi virtuosi. In realtà, se questo accadesse, ad andare al diavolo sarebbe soprattutto l’export di Francia e Germania, che in questo decennio è cresciuto impetuoso non solo grazie agli innegabili aumenti di produttività, ma anche grazie a una moneta come l’euro sottovalutata rispetto alla realtà dell’economia tedesca; una valuta che fa per l’export tedesco quello che lo yuan fa per la Cina. Nel medio e lungo termine l’Italia e paesi come Spagna e Irlanda avrebbero solo da guadagnare da un’ipotesi come quella delle due valute, che è quella che tirerebbe fuori i maggiori vantaggi dai sacrifici che stanno per essere imposti alle nostre società. Con una valuta diversa da quella franco-tedesca, meno forte e direttamente governabile da noi stessi, potremmo ricominciare a fare concorrenza a tedeschi e francesi. Quella che l’Economist considera una soluzione devastante è in realtà la seconda soluzione ragionevole possibile dopo la numero uno: che francesi e tedeschi accettino di trasformare la Bce in una banca centrale sul modello della Fed americana, prestatore di ultima istanza e dedita a politiche di sviluppo e non solo di stabilità monetaria. Se tedeschi e francesi non si fanno una ragione della soluzione numero uno, non resta che la due. È triste che dobbiamo essere noi a dare lezioni su questo argomento al prestigioso staff dell’Economist.
Forse a monte di questa impasse del famoso settimanale c’è una questione storico-culturale: il mondo anglosassone ha avuto grandissimi teorici politici come Thomas Hobbes e John Locke, ma non ha avuto un genio della “realtà effettuale” della politica come Niccolò Machiavelli. Senza l’empirismo anglosassone oggi non avremmo stati liberal-democratici, e questo è un debito che dovremo sempre riconoscere. Ma quando si tratta di indagare le motivazioni e le origini delle azioni politiche umane e di soppesare gli equilibri fra la fortuna e la virtù, l’empirismo deve lasciare il passo al realismo di Guicciardini e di Machiavelli. Altrimenti anche spocchiosi commentatori britannici rischiano di fare una meschina figura di fronte ai loro critici italiani.

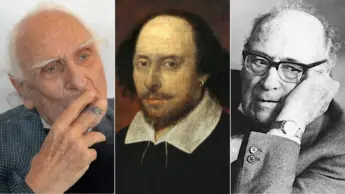

1 commento
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!