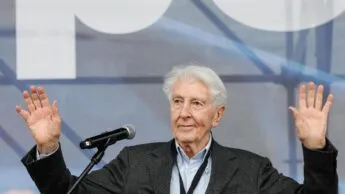
Abolizione del cartellino: controindicazioni

Pochi giorni fa la notizia che Fastweb aveva seguito l’esempio di Siemens, delle aziende della Silicon Valley e di precursori italiani come la Graphistudio di Pordenone e aveva abolito i cartellini di entrata e uscita dal lavoro è stata salutata da grandi hurrà: finalmente le grandi aziende hanno capito che nel rapporto coi lavoratori la fiducia è meglio del controllo, che il senso del lavoro sta nel raggiungimento dei suoi obiettivi e non nella quantità di tempo trascorsa in ufficio, che elasticità e flessibilità di orari permettono al dipendente di organizzare meglio la sua vita, di conciliare il lavoro con la famiglia, di risparmiarsi lo stress degli spostamenti negli orari di punta. Ma è tutto oro quel che luccica? Davvero sta per arrivare il tempo in cui il lavoratore non dovrà più essere pagato per il tempo di vita che ha ceduto al datore di lavoro firmando il contratto, ma per l’opera che effettivamente realizza? Difficile crederlo. Sembra piuttosto che stia per diventare vero l’opposto: come nelle economie schiaviste, presto tutto il tempo di vita delle persone sarà a disposizione delle aziende per cui lavorano, e più in generale del sistema produzione-consumo.
Più smart working
La decisione di Fastweb, leggiamo, è stata accelerata dall’esperienza dello smart working generalizzato nei mesi del confinamento a causa del Covid, ovvero del “lavoro agile” da casa. La dirigenza ha notato che il rendimento del lavoro “da remoto” era superiore a quello del lavoro in presenza. Come ha scritto recentemente Repubblica, citando la direttrice dell’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano, «nelle società che hanno sperimentato questo modello, la produttività sale in media del 10-15 per cento». Già nel settembre scorso sul Sole24Ore era apparso un articolo che spiegava che i direttori delle risorse umane e i top manager erano d’accordo a favorirne l’uso in tutti i casi in cui era possibile. «Una survey di Aidp (Associazione italiana dei direttori del personale)», si leggeva nell’articolo, «spiega che oltre il 68 per cento del campione ha dichiarato che prolungherà le attività di smart working anche nella fase di ritorno ad una “nuova normalità”». Se top manager e direttori delle risorse umane sono d’accordo a confermare ed estendere il “lavoro agile”, ciò significa evidentemente che hanno riscontrato un incremento della produttività. Certamente ci sono dei vantaggi che riguardano anche i lavoratori, sia i dirigenti che i quadri intermedi.
Dopo un paio di film su Netflix
In un articolo dell’agosto scorso il New York Times li aveva descritti con toni quasi lirici:
«Nell’era pre-Covid», si leggeva, «Dan O’Leary, direttore di partnership commerciali di una compagnia tecnologica, spendeva dalle due alle tre ore al giorno per gli spostamenti e volava per lavoro settimanalmente. Si atteneva a un programma molto rigido: sveglia alla cinque di mattina, biciclettata di gruppo, doccia e via a prendere il treno: le sue giornate lavorative erano piene di meeting. Da quando il coronavirus ha sospeso la vita in ufficio nel marzo scorso, le sue giornate lavorative sono molto diverse, addirittura idilliache. Talvolta lavora seduto su una coperta da picnic in un parco vicino a casa sua a San José in California, o partecipa a meeting online mentre fa passeggiate. Lavora lo stesso numero di ore di prima, circa 50 alla settimana, ma dice di essere diventato più creativo e produttivo perché può scegliere liberamente il suo programma. Come manager, permette alla sua squadra di fare lo stesso. “Non ho bisogno di vederli alla loro scrivania alle sei di pomeriggio” dice. “Posso verificare il loro lavoro alle dieci di sera, seduto nel mio letto, dopo che mi sono sparato un paio di film su Netflix”».
Secondo lo stesso articolo, un sondaggio aveva rilevato che l’86 per cento dei lavoratori da remoto si dichiarava soddisfatto della sua esperienza.
Un campo di lavoro
Eppure più che idilliaca l’immagine di un signore che lavora dal letto di casa sua nel cuore della notte o mentre prende il sole in un parco cittadino risulta inquietante: fa venire in mente una vita totalmente assorbita dal lavoro, senza nessun diaframma fra il pubblico e il privato, fra tempo del riposo e tempo dell’impegno. Viene in mente un brano tutt’altro che idilliaco di Nello sciame – Visioni del digitale di Byung-Chul Han:
«(…) oggi siamo liberi dalle macchine dell’epoca industriale che ci schiavizzavano e sfruttavano; i dispositivi digitali, tuttavia, producono una nuova costrizione, una nuova schiavitù. Ci sfruttano in modo ancora più efficiente perché – grazie alla loro mobilità – trasformano ogni luogo in un posto di lavoro e ogni tempo in un tempo di lavoro. La libertà della mobilità si rovescia nel fatale obbligo di dover lavorare ovunque. Nell’epoca delle macchine, già soltanto per via dell’immobilità di queste ultime, il lavoro era circoscritto rispetto al non-lavoro: il posto di lavoro, sul quale ci si doveva appositamente recare, era nettamente separato dai luoghi del non-lavoro. Oggi questa distinzione è stata completamente abolita in molte professioni: anche il lavoro è reso mobile dal dispositivo digitale. Ciascuno si trascina appresso il posto di lavoro come un campo di lavoro. Così, non possiamo più sfuggire al lavoro». (pp. 50-51)
Re a casa mia
La notizia dell’abolizione dei cartellini e delle macchine timbracartellini, obsolete come strumenti di controllo del lavoro dopo che questo è stato in gran parte digitalizzato e può essere effettuato da casa, va letta piuttosto in combinazione con quella che ci informa che l’università di Torino aveva steso una bozza di regolamento per gli esami a distanza che prevedeva che lo studente non potesse mostrare nel corso del collegamento online simboli politici o religiosi. La decisione è stata criticata come un attacco ai diritti civili e alla libertà religiosa degli esaminandi, ma la cosa è in realtà ancora più grave. Imponendo agli iscritti un regolamento di questo tipo, l’università di Torino trasformava in luogo pubblico quello che è il più privato di tutti i luoghi privati: casa propria. Così veniva spazzata via la più preziosa acquisizione del pensiero liberale, quella che più meriterebbe di essere preservata: il diritto alla privacy. Che William Pitt conte di Chatham, primo ministro britannico a metà del Settecento, descriveva con queste alate parole: «Il più povero degli uomini nella sua casetta può sfidare tutte le forze della Corona. Essa può essere fragile – il suo tetto può essere pericolante – il vento può soffiare attraverso di esso – la tempesta può entrare – la pioggia può entrare – ma il re d’Inghilterra non può entrare! Tutte le sue forze non osino attraversare la soglia di quella proprietà in rovina!». L’università di Torino pretendeva di fare quello che il primo ministro britannico negava fosse nel diritto della Corona: violare la residenza di un cittadino. E proprio per il motivo che spingeva i teorici del liberalismo a considerare la privacy un diritto irrinunciabile: imporre a un cittadino un certo punto di vista sulla politica e sulla religione, in questo caso consistente nel cancellarle dalla vista come se si trattasse di pornografia.
Privacy in cambio di comodità
Grazie alle proteste degli studenti e di organi di stampa il paragrafo della bozza di regolamento che conteneva la disposizione suddetta è stato eliminato, ma in molti altri casi siamo noi padroni di casa a consegnare le chiavi della dimora al Grande Fratello che entra e ci controlla 24 ore su 24. Gli altoparlanti intelligenti, gli assistenti personali intelligenti come Alexa di Amazon rappresentano un sintomo della facilità con cui stiamo cedendo la nostra privacy in cambio di tante comodità. Il prezzo alla fine sarà molto salato. Come ha scritto Rod Dreher in Live not by Lies,
«il consumismo è il modo in cui stiamo imparando ad amare il Grande Fratello. Del resto il Grande Fratello non è esattamente come ci aspettavamo che fosse: un dittatore politico. Anche se un giorno potrebbe diventarlo. Al momento presente, la principale occupazione del Grande Fratello è di tipo capitalista. È un venditore, un intermediario, un raccoglitore di dati grezzi, un fabbricante di desideri. Controlla virtualmente ogni vostro movimento per trovare il modo di vendervi più cose, e facendo questo impara come può dirigere il vostro comportamento. In questo modo il Grande Fratello sta gettando le fondamenta di un totalitarismo morbido, sia creando e rendendo operativa la tecnologia per il controllo politico e sociale, sia preparando la popolazione ad accettare ciò come normale».
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!