
A tu per tu con la Madonna di Foligno, l’opera di Raffaello che divenne “manifesto artistico” della Controriforma
Una goccia. Una goccia di colore, rossa come il fuoco. A guardarla sui libri sembra un errore di stampa, un tocco sfuggito al pennello o lasciato lì, come un vezzo, dall’artista. Dal vivo invece si nota che questa macchia ha una coda filante; è un fulmine globulare, o un meteorite; è un segno dal cielo. Sarebbe caduto diritto sul tetto della casa se la Vergine Maria non l’avesse protetta e risparmiata. Questa lacrima, vermiglia come la veste della Madonna e dell’offerente inginocchiato a destra, è il centro della composizione, intorno al quale ruota anche la sua ragion d’essere. È il perché di questo capolavoro; un omaggio di Sigismondo de’ Conti alla sua mamma celeste: il donatore commissionò il quadro a Raffaello alla fine del 1511 per ringraziare la Vergine della sua materna protezione.
L’episodio è raffigurato sullo sfondo con un naturalismo reso del tutto irreale dall’intensità e dalla ricchezza della gamma cromatica impiegata. La Madonna è circondata da un cerchio di sole, lo stesso nimbo che nei mosaici bizantini e poi negli affreschi medioevali circondava in una mandorla iridata il Cristo redentore, signore del cosmo e della storia. Anche il gesto del Bambino Gesù che, in braccio alla Madre, si copre il capo con il suo velo, riprende il tema della Madonna della Misericordia, seppure radicalmente modificato. Siamo davanti a una tradizionale pala d’altare, ma l’immagine è concepita in modo rivoluzionario per il tempo.
La Madonna di Foligno (foto a lato: copyright Governatorato S.C.V. – Direzione dei Musei) nasce come un grande ex voto, perché grande è il miracolo che evoca e grandi sono gli uomini di fede coinvolti: un potente della corte pontificia da un lato e l’artista più in voga nella Roma di Giulio II dall’altro.
Si chiama “di Foligno”, ma non fu dipinta per quella città. In realtà vi giunse soltanto dopo il 1564 per volere di una monaca, nipote del donatore. Sigismondo de’ Conti era segretario domestico di papa Giulio II della Rovere e Prefetto della Fabbrica di San Pietro e aveva destinato il dipinto di Raffaello all’altare maggiore della chiesa di Santa Maria in Aracoeli a Roma, di proprietà dei Frati Minori. Non a caso, inginocchiato a sinistra, nel registro inferiore del dipinto, si vede san Francesco d’Assisi. Il committente è inginocchiato a destra. Alle loro spalle in piedi stanno san Giovanni Battista – il più grande tra i figli d’uomo, che viveva nel deserto, indossava pelli di cammello, mangiava locuste e predicava penitenza e conversione in attesa del Messia – e, a destra, san Girolamo, con la mano posta paternamente sulla nuca del committente, quasi a trasferirgli tutta la sua sapienza e benedizioni. San Girolamo, teologo e dottore della Chiesa vissuto nel IV secolo, aveva tradotto la Bibbia dal greco e dall’ebraico in latino e aveva lasciato la mondanità della corte papale romana per finire i suoi giorni da eremita a Betlemme. Al centro un putto regge una tavoletta (tabula ansata) priva di iscrizioni; il suo significato resta ancora misterioso, ma probabilmente ricordava il voto dell’offerente.
L’attribuzione a Raffaello non fu subito scontata, mancando firma o documenti d’archivio ad avallarla. Alcuni studiosi del XIX secolo come Giovanni Battista Cavalcaselle o del primo Novecento come Roberto Longhi riferirono l’opera all’ambito ferrarese e alla bottega dei Dossi, mentre sembrano più convincenti le osservazioni di chi vedeva un influsso veneto nell’uso della luce e del colore, portato a Roma dai veneziani Sebastiano del Piombo e Lorenzo Lotto. Proprio negli anni in cui Raffaello affresca le Stanze Vaticane, gomito a gomito con loro, la sua ricerca pittorica si concentra sulla luce e sugli effetti speciali come i bagliori notturni.
La Madonna di Foligno è la sua prima pala d’altare dipinta a Roma dopo gli anni giovanili trascorsi tra Marche, Perugia e Siena e dopo il soggiorno fiorentino (1504-1508). Giunto nell’Urbe nel 1509 aveva subito ottenuto l’incarico di decorare le stanze dei nuovi appartamenti papali in Vaticano e di affrescare le logge della villa sul Tevere del banchiere Agostino Chigi (l’attuale Farnesina).
L’originalità dell’opera
Con questa tavola, dipinta a tempera grassa e olio tra il 1511 e il 1512, Raffaello supera lo schema tradizionale dell’ancona d’altare quattrocentesca e scrive una pagina originale, che diventerà il manifesto dell’arte sacra negli anni della Controriforma. Sarà infatti una sessione del Concilio di Trento (1545-1563) a definire i dettami per pittori e scultori e lo farà ispirandosi proprio alle opere di soggetto religioso del Raffaello romano.
Nel registro superiore della tavola è sempre dipinta l’apparizione celeste e in quello inferiore i santi sono i campioni della fede, testimoni eroici ma accessibili. Il quadro commuove e istruisce i fedeli, accendendo al tempo stesso i loro sentimenti e la loro ragione. I continui rimandi tra cielo e terra creano un equilibrio di linee e di colori che bene esprimono l’armonia celeste, dando forma all’invisibile. Il volo di angioletti intorno al sole, bianchi e azzurri come le nubi, morbidi e soffici come neonati, è un tocco di domestica poesia.
Al tempo di Raffaello la “propaganda fide” non era ancora decollata, ma cinquant’anni dopo le sue pale d’altare con la Madonna Sistina (1513) e la Santa Cecilia (1514) diventeranno l’esempio da imitare. La Madonna di Foligno finì in Francia come bottino di guerra, sottratto dalle truppe di Napoleone nel 1797. Restaurata tra il 1800 e il 1801, durante la sua permanenza a Parigi, subì una delicatissima operazione di trasporto del colore dalla tavola alla tela. Questo intervento, considerato oggi fortemente invasivo, permise però di conservare nel tempo il capolavoro, giunto a noi intatto nella sua cromia originale. Restituita all’Italia, giunse nei Musei Vaticani, dove continuò a godere di una popolarità sorprendente fino ai giorni nostri.
Da Roma a Foligno, dalla Francia alla Città del Vaticano, fino ad oggi a Milano, lo spazio si azzera davanti alla bellezza senza tempo della Madonna di Foligno.
LA MOSTRA
La Madonna di Foligno a Palazzo Marino
Piazza della Scala, 2 – Milano
Curatori: Valeria Merlini, Daniela Storti
Enti promotori: Eni, Comune di Milano, MiBACT, Musei Vaticani
Aperta fino al 12 gennaio 2013
Ingresso libero
Per informazioni: 800.14.96.17
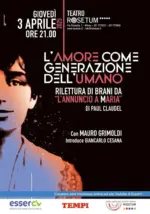
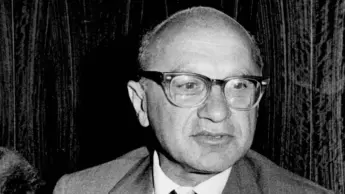

0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!