
A scuola ha vinto Gramsci (purtroppo)

Articolo tratto dal numero di settembre 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
Fu arrestato l’8 novembre 1926 dalla polizia fascista e morì il 27 aprile 1937 in una clinica romana. Durante la detenzione carceraria e il periodo di libertà vigilata che lo accompagnò sino alla fine scrisse lettere e appunti che divennero i Quaderni dal carcere la cui prima edizione avvenne sotto la guida di Palmiro Togliatti. Stiamo parlando di Antonio Gramsci che fu tra i fondatori del Partito comunista italiano e la cui opera intellettuale è stata riconosciuta, in tutto il mondo marxista, di grande valore e originalità. Ci interessa estrarre dal suo pensiero e dalle sue opere le due questioni più attinenti la storia italiana: il problema dell’egemonia e la questione cattolica.
Egemonia. Gramsci ben comprende che in Occidente è impossibile attuare un evento rivoluzionario che porti ad una dittatura del proletariato guidata dal Pci come nell’Urss di Lenin e Stalin. Le condizioni sociopolitiche dell’Italia spingono invece verso un’altra direzione: realizzare un’egemonia culturale confidando nel ruolo degli intellettuali capaci di rivolgersi alle masse trasmettendo modelli culturali a-religiosi e laicisti.
Dunque, rispetto al marxismo classico che tende alla conquista dello Stato con il ricorso alla violenza rivoluzionaria, il gramscismo ha come obiettivo la società civile intesa come rapporti, relazioni, cultura, educazione, corpi intermedi. All’interno della società civile la cultura deve veicolare un’immagine dell’uomo e della storia, occupandosi in primo luogo dell’educazione delle masse attraverso la scuola.
L’egemonia che ha in mente Gramsci può attuarsi solo in tempi lunghi perché la classe (borghese) dominante prenda coscienza del suo ruolo e riesca a persuadere le masse e le altre classi della propria funzione ideologica mostrando e convincendo che i propri obiettivi e interessi sono, alla fine, quelli di tutti. E questa è la responsabilità dell’intellettuale organico.
Questione cattolica. Per Gramsci la religione non è un elemento secondario ma riveste un’importanza decisiva nella strategia del Pci e dei suoi epigoni attuali. Osserva acutamente Augusto Del Noce che per Marx l’estinzione della religione è una conseguenza della società senza classi che porta con sé la liberazione dai falsi bisogni come quello di Dio; per Gramsci l’eliminazione della religione è la pre-condizione di una profonda rivoluzione culturale. Quest’ultima si realizza in modo non violento, indolore, iniziando a demitologizzare fatti ed eventi che la forte e popolare educazione cattolica ha diffuso negli strati più popolari della società. A partire dall’immediato Dopoguerra, l’Istituto di studi comunisti esortava a studiare filosofia e ad entrare nelle scuole per demolire credenze e princìpi religiosi: la Riforma protestante, il processo a Galileo, l’Inquisizione spagnola, la Chiesa di Pio IX, iniziando così una vera controffensiva laicista e anticattolica.
Nelle scuole dell’infanzia è noto che in certe classi ai bambini si sostituisce la festa del Natale con quella della neve e fare oggi un presepe sembra una indecente provocazione al mondo islamico. Ai conflitti di classe, ignorati o silenziati, si preferiscono campagne ideologiche sul gender e sul transumanesimo allo scopo di rendere omogeneo un dissolvimento religioso generalizzato.
E Gramsci che c’entra? C’entra la sua filosofia della prassi e della storia. Da rigoroso storicista e illuminista, Gramsci nega l’al-di-là e lo sostituisce con l’idea di futuro: stiamo facendo un cammino in avanti verso il sol dell’avvenire senza magari vedere l’addensarsi di nebbie e più serie perturbazioni. Si vuole a tutti i costi eliminare – e le nuove generazioni sono obiettivi privilegiati – il movente della desiderabilità che è in ogni uomo il segno di uno scarto esistenziale, come osservava il filosofo comunista Cesare Luporini. Vige, nel nostro tempo, il divieto di un oltre, perché l’oltre è sottratto al dominio del potere.
Se l’uomo è solo il processo dei suoi atti (Gramsci) non si può credere più a nessuna promessa e si dissolve anche l’escaton che il marxismo classico attribuiva alla propria ansia di cambiamento. Rimane la sterile consolazione, o anestesia collettiva, di un nichilismo gaio, una sorta di Nirvana rivisitato, ove darsi per non più riaversi. Ma è davvero dolce il naufragare in questo mare?
Foto Ansa


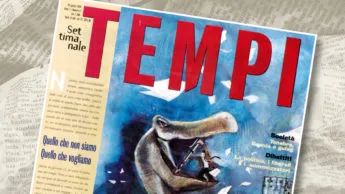
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!