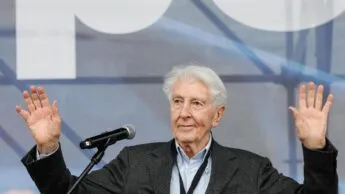
Non ci sarà nessun boom, nessuna Italia verde e digitale senza nuovi figli

Non ci sarà nessun boom economico, nessuna «Italia che vogliamo», più verde, inclusiva, digitale (come auspicato dal decreto Rilancio), senza demografia, ciò che fornisce l’infrastruttura umana di ogni paese. Cosa ci aspetta alla fine del Covid non è ad oggi un’Italia attrezzata a pensare e nemmeno a immaginare il futuro. «È stato il peso delle nuove generazioni a dare slancio alla ripresa nel secondo Dopoguerra, quel 72 per cento di popolazione under 45 anni censita nel 1951. Oggi quella percentuale si è ridotta al 47 per cento e secondo l’Istat calerà fino al 43,7 alla fine del decennio. In parole povere, l’Italia sta depotenziando anno dopo anno quella che è la base su cui appoggiare qualunque piano di rilancio, crescita e sviluppo del paese», spiega a tempi.it Alessandro Rosina, docente di Demografia e statistica sociale presso l’università Cattolica del Sacro cuore di Milano.
OGNI ANNO UN NUOVO RECORD DI CULLE VUOTE
La demografia è una scienza implacabile e l’Italia un paese che da decenni non vede o finge di non vedere la gravità del quadro oggi colpito dalla pandemia: «Nel 2019 il numero medio di figli per donna è stato pari a 1,29: sono anni che vediamo scendere a precipizio il tasso di fecondità sotto la soglia del rimpiazzo generazionale (2,1 figli per donna), ogni anno battiamo il record negativo. E questo si paga caro». Dalle oltre 560 mila nascite nel 2010 siamo passati alle circa 435 mila nel 2019, «in altre parole, non si è registrata nessuna ripresa delle nascite dopo la crisi economica iniziata nel 2008, che al contrario ha lasciato enormi fragilità sulle nuove generazioni. Il rischio è che questa emergenza sanitaria inasprisca ulteriormente le criticità tutte italiane».
POCHI FIGLI E RIMANDATI NEL TEMPO
Non siamo solo il paese della depressione delle nascite, siamo anche il paese con il record di Neet in Europa (gli under 35 che non studiano e non lavorano) e con la più tardiva età delle madri alla nascita del primo figlio (oltre 32 anni). Eppure, dall’indagine che Rosina ha coordinato per l’Osservatorio giovani dell’Istituto Toniolo, «è emerso che la maggior parte dei ventenni considera il diventare genitore parte integrante della propria realizzazione e non c’è differenza tra numero di figli desiderato, o l’età in cui averli, rispetto ai coetanei degli altri paesi europei come la Francia, che presenta il tasso di fecondità più alto dell’Unione Europea». Il progressivo riadattamento al ribasso delle aspettative e degli obiettivi, spiega Rosina, avviene via via nel confronto con le condizioni reali del mondo del lavoro e della società: chi desidera due figli ne fa uno solo, chi ne desidera uno non ne fa affatto e (complice la carenza di misure di conciliazione tra lavoro e famiglia, flessibilità, part-time reversibili e congedi adeguati) l’arrivo del primo figlio si posticipa sempre di più.
LA NASCITA HA PERSO VALORE
«In altre parole manca totalmente una comunità che dia valore alla scelta e al desiderio di fare figli, che metta il giovane nelle condizioni reali e concrete di affrontare quel passaggio alla vita adulta che si chiama genitorialità. Non aiutare i ragazzi a realizzare appieno le proprie potenzialità – vale in ogni ambito – e, al contrario, indebolire la popolazione giovanile, a cui è affidata nei prossimi decenni la crescita economica, la sostenibilità del welfare nonché il peso del debito pubblico, significa camminare ostinatamente verso una strada senza uscita».
VERSO L’1 A 1 TRA PENSIONATI E LAVORATORI
La già fragile posizione lavorativa ed economica delle giovani generazioni e delle famiglie, in un paese in cui dagli anni Novanta il saldo naturale (cioè la differenza fra nascite e decessi) continua ad essere negativo e il numero degli ottantenni ha superato quelli dei nuovi nati, rischia di venire ulteriormente compromessa dall’emergenza sanitaria accentuando fino al disastro gli squilibri sociali. Rosina lo ha denunciato a chiare lettere: più aumenta il rapporto tra la componente anziana e quella in età lavorativa più si riduce la capacità di produrre ricchezza rispetto ai costi (previdenziali e sanitari) dell’invecchiamento della popolazione. Tradotto in cifre: se in Europa il rapporto tra chi ha 65 anni e più rispetto a chi è tra i 25 e i 64 anni è pari al 35 per cento (contro il meno del 10 per cento dell’Africa) in Italia questo indicatore è già oltre il 40 per cento ed è previsto salga oltre l’80 per cento entro il 2050: «Questo significa che stiamo andando di fatto vero un rapporto 1 a 1 tra pensionati e lavoratori italiani. Uno scenario assolutamente incompatibile con qualsiasi possibilità di ripresa, crescita, sostenibilità e inclusività. Vogliamo che il futuro sia questo, assistere al crollo di un’Italia sempre più vecchia e povera?».
RIPARTIRE DALL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Possiamo invertire la rotta, ma in un modo solo: «Per prima cosa dobbiamo tornare a ragionare su un assegno unico universale, a sostegno del principio che per il paese i figli non sono un costo privato a carico delle famiglie ma ciascuno ha un valore per la collettività. Una misura solida, destinata a tutti i nati e con un orizzonte temporale ampio, così da sostenerne la formazione e l’autonomia. Dobbiamo impedire che la povertà generata dalle crisi diventi povertà educativa. Secondo, dobbiamo garantire ai giovani una formazione non solo adeguata ma la migliore possibile, dotarli delle competenze richieste dal mercato del lavoro così che possano collocarsi, realizzare appieno le proprie potenzialità e i progetti di vita: quanto più avremo ridotto le attese per mettere al mondo il primo figlio tanto più avremo una generazione responsabile, autonoma, capace di immaginare il futuro, capace di vedere un futuro per i propri figli ed essere attori di quel cambiamento che ha trascinato il paese verso il miracolo economico».
UNO SVEZZAMENTO CULTURALE
Terzo, «dobbiamo puntare su un pacchetto di misure integrate e di conciliazione che davvero traducano in fatti la necessità di incidere sul tasso di fecondità, il tasso di occupazione femminile, la povertà infantile materiale ed educativa». E questo non ha nulla a che vedere con l’assistenzialismo. Le culle sempre più vuote sono il risultato di un Paese impaurito, ripiegato sul presente, incapace di pensare al futuro e per Rosina la cura necessaria consiste in uno svezzamento pratico e culturale: aiutare i giovani a smetterla di concepirsi come figli ma soggetti generativi, capaci di immaginare il domani perché capaci di immaginarlo per i propri figli, «renderli protagonisti di un nuovo inizio per il Paese».
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!