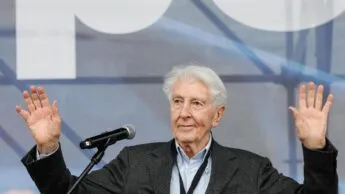
Non basterà il bonus asilo per riempire le culle

Tra un peana e l’altro alla «coraggiosa Elly Schlein» e alla generazione di trentenni che non hanno paura di dire chi amano e viaggiano e sono abituati a spostarsi per lavoro o per studio in tutta Europa o in tutto il mondo e condividono la scrivania con un collega spagnolo e l’appartamento con un inquilino giapponese e mettono a tavola cibo indiano e hanno l’abbonamento al New Yorker (sic, sic e sic, «e vivono felici «fuori da quegli steccati che qualcun altro ha voluto tirare su, non vedendo che piano piano stanno cadendo uno dietro l’altro»), Fanpage, pardon, donna.fanpage affronta il tema della denatalità: dati Istat dimostrano che tra i 25 e i 44 anni si è smesso di fare figli, e un sondaggio Swg ha sottolineato che un genitore su quattro non rifarebbe un figlio se potesse tornare indietro, «perché è una scelta che comporta troppi sacrifici, primo tra tutti il dover rinunciare al tempo da dedicare a se stessi». L’articolista scagiona i 25-44enni dalle accuse di irresponsabilità (dopotutto, sottolinea il pezzo, il 57 per cento di loro ritiene ancora che senza un figlio la vita di una persona sia incompleta, pensa che sgravi fiscali e servizi alla famiglia più accessibili risolverebbero ogni problema), e “rilancia”: «È davvero responsabile mettere al mondo un bambino a tutti i costi, anche quando questo significa non potergli assicurare un’infanzia serena dal punto di vista economico?».
Proiettarsi in avanti
Non sappiamo cosa Giuseppe De Rita, fondatore del Censis, pensi dei trentenni che amano con l’abbonamento al New Yorker, ma quanto ha detto allo Stampa sull’inverno demografico italiano risponde perfettamente alla domanda: non alla precarietà o “responsabilità” dei 25-44enni va attribuito il crollo delle nascite, bensì a «una dinamica culturale malata».
Per riempire le culle non bastano bonus o asili nido gratis, sostiene il sociologo, ma è necessario «ricostruire un’idea di comunità»: non solo la denatalità diminuisce la ricchezza sociale attraverso effetti negativi sulla mobilità economica e sulla psicologia collettiva (alla faccia della generazione che non ha paura di amara apertamente «le culle sempre più vuote sono il risultato di un Paese impaurito, ripiegato sul presente, incapace di pensare al futuro»), ma «non si è più disposti a fare sacrifici per proiettare in avanti, attraverso i figli, le proprie speranze».
Una società che non dice “noi”
Considerare fare figli un atto irresponsabile, un salto nel buio, è diventato l’alibi degli egolatri dei social, sempre più autoreferenziali, ossessionati dall’idea di fare cassetto del proprio capitale senza investirlo in quel coraggioso passaggio alla vita adulta che si chiama genitorialità: certo, la crisi ha pesato su tutto, anche su questo desiderio, «ma non è detto che le coppie sarebbero più propense ad allargare la famiglia se migliorassero gli interventi pubblici. È un problema più profondo, di mentalità e di dittatura dell’io. Una società che non sa più dire “noi” non fa figli. Si è perso l’equilibrio nei rapporti sociali necessario per stare bene insieme, uno accanto all’altro». E infatti le generazioni viaggiano, vivono oltre gli steccati, condividono scrivanie e appartamenti all’estero. Lasciando il paese in declino o alla metafora della mucillagine usata da De Rita: «Monadi scomposte che si riaggregano in poltiglie indistinte, senza un collante che le unisca in nome di un bene comune o di un progetto familiare». Bella responsabilità.
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!