
Dunkirk e la prosecuzione della guerra in sala


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Dunkerque. Wikipedia ci illumina sull’etimologia del nome di questa cittadina fiamminga che le tempeste della storia hanno portato entro i confini francesi; esso deriverebbe dalla fusione di due termini mutuati, appunto, dall’olandese antico: duin (duna) e kerke (chiesa). Christopher Nolan, per il suo film sull’“operazione Dynamo”, l’evacuazione del Corpo di spedizione britannico (Bef) dalle spiagge della Francia settentrionale nel maggio-giugno 1940, ha scelto la versione inglese del toponimo: Dunkirk.
Si tratta forse della tessera di un puzzle politico più complesso, o quanto meno dell’indizio di uno straordinario intuito che Nolan aveva già mostrato nella trilogia su Batman. Infatti, se è vero che il regista inglese stava pensando a questo soggetto già dagli anni Novanta, le riprese sono iniziate proprio mentre infiammava il dibattito sulla Brexit e si consumava la dura battaglia per le primarie statunitensi; e in entrambi gli eventi aveva assunto un carattere centrale la serrata (e a volte feroce) critica del ruolo egemonico della Germania nel quadro dell’Unione Europea.
Dicevamo dell’intuito politico di Nolan già manifestato nella famosa trilogia su Batman, che ha in qualche modo anticipato e descritto in modo originale l’elezione di Obama e l’evoluzione di movimenti come Occupy Wall Street. Un tema sviscerato in Batman e Joker: maschere e volti dell’America (Medialibri), un bel saggio scritto da uno spettatore appassionato, Giuseppe Sacco, favorito nella decriptazione del “pensiero politico di Batman” (e quindi di Nolan) dal fatto di essere stato professore di Relazioni internazionali.
In questo caso, il tema e la tempistica dell’uscita di Dunkirk ne farebbero un film, se non proprio sulla Brexit, sulle (periodiche) ritirate della Gran Bretagna dal continente, che peraltro sappiamo essere state sempre tattiche: l’operazione Dynamo, infatti, in qualche modo anticipa “Overload”, lo sbarco in Normandia. A ciò si aggiunga anche un altro indizio: quando Donald Trump è entrato alla Casa Bianca, nella Sala ovale è stato riposizionato il busto di Churchill (che Obama aveva sostituito con quello di Martin Luther King), e questa “iniziativa” sarebbe stata accompagnata dalla battuta del consigliere strategico Steve Bannon, allora in auge: «Prossima tappa, la Normandia».
A questo punto vale la pena di ricordare un’osservazione di Riccardo Pesce, professore di Drammaturgia multimediale all’Accademia di Brera, nonché importante “creativo” della Disney: «Il cinema d’evasione, in senso stretto, non esiste; durante gli spettacoli d’intrattenimento, quando le barriere del pubblico sono abbassate, si fa politica». Proviamo a fare qualche altro esempio. Il ruolo oppressivo, o quanto meno ambiguo, della Germania in Europa è descritto anche in alcuni degli ultimi film di Steven Spielberg: War Horse (2011) e Il ponte delle spie (2015). In una scena del primo alcuni stalloni inglesi (sopravvissuti a una folle carica: siamo all’inizio del primo conflitto mondiale) vengono usati per trascinare cannoni Krupp in salita e nel fango, sotto le sferzanti e feroci frustate degli ottusi ufficiali tedeschi; un ruolo a cui non sono assolutamente preparati. Una metafora del genio, della forza, della potenza dell’Europa frustrati dalle politiche di austerity? Più sfumato, ma altrettanto interessante, il messaggio del secondo film (arrivato nelle sale durante la crisi ucraina), in cui negoziatori americani e russi, in piena Guerra fredda, riescono a dirimere una difficile controversia nonostante i tentativi dei tedeschi (dell’Est) di sabotare la trattativa.
L’epopea e le sue revisioni
Ma torniamo al film di Nolan. Il regista ha scelto di concentrarsi sull’azione, e il punto di vista è quello degli uomini sul campo: ciò non permette di descrivere il quadro strategico complessivo. Egli, inoltre, ripropone una vulgata ormai demitizzata; in particolare l’autorevole storico Nicholas Harman ha mostrato come questo evento, a lungo commemorato come uno dei più grandi trionfi nella storia britannica, sia stato in effetti una grave sconfitta con pesanti ombre politiche generate dal comportamento nei confronti degli alleati belgi e francesi. L’evacuazione di quasi 400 mila uomini è stata certamente un fatto d’arme straordinario, ma allo stesso tempo una catastrofe da un punto di vista militare. Catastrofe che avrebbe potuto avere conseguenze ancora peggiori se i tedeschi avessero invaso l’Isola, visto che i superstiti del Bef, al ritorno in patria, erano praticamente disarmati.
Il 22 maggio 1940 il generale Heinz Guderian con le sue forze corazzate raggiunse il fiume Aa presso Gravelines, a circa 15 chilometri dai sobborghi di Dunkerque. Il giorno dopo, con le truppe di Reinhardt, conquistò diverse teste di ponte sulla sponda opposta. Nell’autorevole ricostruzione di Basil Liddell Hart, solo un battaglione britannico era schierato fra i nazisti e il porto francese, ultima via di evacuazione per le truppe inglesi sconfitte. Proprio in questo drammatico frangente i tedeschi ricevettero l’ordine di arrestarsi sulla linea del canale. L’ordine giunse direttamente da Hitler, e su ciò concordano tutti i più importanti ufficiali tedeschi (Guderian, Kleist, Thoma, Brauchitsch, Siewert e Halder). Per Liddell Hart nella decisione di Hitler si sarebbero intrecciati vari fili (il terreno non adatto allo sfondamento corazzato, l’esigenza di dover ancora affrontare i due terzi delle divisioni francesi sul campo), ma su tutto ci sarebbe stata una valutazione di ordine politico; il fermo dell’avanzata sarebbe stato parte di disegno finalizzato al raggiungimento della pace: «Se il Corpo di spedizione britannico fosse stato catturato a Dunkerque, gli inglesi si sarebbero sentiti feriti nell’onore, una macchia da cancellare. Lasciandoli fuggire Hitler sperava di venire a più miti consigli con loro».
Fino all’ultima pallottola
Quindi la seconda mossa, dopo l’arresto dell’avanzata su Dunkerque, sarebbe stato il volo di Rudolf Hess, che avrebbe dovuto portare a termine la missione di pace rivitalizzando le simpatie filotedesche di una parte dell’aristocrazia inglese. Simpatie raccontate in Quel che resta del giorno di James Ivory (1993). Sappiamo che – per fortuna – la storia è andata diversamente grazie alla tenacia di Churchill.
Comunque, proprio il 22 maggio 1940, il suo gabinetto di guerra decise di ritirare dalla Francia le truppe britanniche. Sempre secondo Nicholas Harman, Anthony Eden avrebbe formalmente ordinato al comandante del Bef, il generale Lord Gort, di ingannare i francesi sulle loro reali intenzioni. Churchill stesso contribuì a questo raggiro, rassicurando il premier francese Reynaud che la Gran Bretagna avrebbe continuato a battersi in Francia: a sud-est di Dunkerque gli inglesi ritirarono le loro unità, lasciando solo 7 divisioni francesi ad affrontare i tedeschi che avanzavano. I francesi, e i belgi con loro, si batterono fino all’ultima pallottola.
A settant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, ci rendiamo ancora conto che tanti angoli di quella tragedia non sono illuminati, mentre molti dei nodi irrisolti della nostra storia tornano a sfidare il nostro presente.


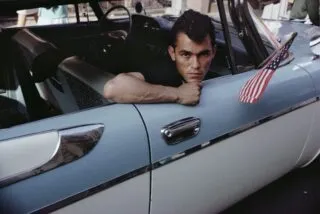
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!