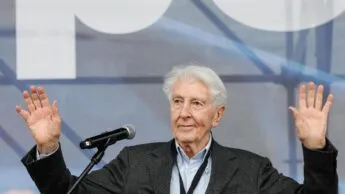
«La vita cambia la vita. Io non sono solo la mia malattia»


Nasci, cresci e vivi: anche il testamento consegnato all’associazione Luca Coscioni da dj Fabo prima di trovare la morte con il suicidio assistito in Svizzera inizia un giorno preciso, «io, Fabiano Antoniani, Dj Fabo, nato a Milano il 9 febbraio 1977, all’età di sette anni, frequento la scuola di musica per imparare a suonare la chitarra. Da bambino spesso suono come primo chitarrista e partecipo a numerosi saggi…». Nasci, cresci e vivi: molti anni più tardi una marcia a ritroso biologica ci porta al settimo mese di gestazione di Lorenzo Moscon, un bimbo piccolissimo e già in sofferenza a causa del cordone ombelicale stretto intorno alla gola. È il 18 agosto 1993 quando un parto d’urgenza lo mette al mondo: questo non c’è scritto nella lettera indirizzata 3 marzo al Parlamento, in cui Lorenzo si presenta come «uno studente universitario di 23 anni affetto dalla nascita da una triplegia spastica a causa della quale sono disabile al 100 per cento, costretto su di una sedia a rotelle». Eppure la sua battaglia per vivere affonda alle radici della vita: «Sono nato in sofferenza respiratoria, a due mesi mi è collassato un polmone, sono stato operato da allora almeno sei volte, quattro interventi dagli 0 ai 6 anni, due agli occhi a 18; sono cresciuto in carrozzella, senza poter utilizzare gli arti inferiori e il braccio destro».
Le storie di questi due ragazzi non si somigliano per niente, eppure l’epilogo della vicenda dj Fabo «ci ha messo tutti nei guai», spiega Lorenzo a tempi.it. «Su quell’onda emotiva il Parlamento legifererà sulla possibilità di sopprimere un malato per alleviarlo da una sofferenza terribile. Uccidere invece di curare, in nome di una pietà che non è disposta ad intraprendere percorsi per lenire il dolore estremamente efficaci come quelli delle cure palliative. E sappiamo tutti dove portano misure legislative come queste: in Olanda e Belgio si sta discutendo l’estensione dell’eutanasia ai malati di mente, ed a quelli in terapia intensiva». Al centro, sempre il dolore, e il ricatto morale per chi ne è immune di “voi non sapete cosa fareste in quella situazione”, «e quindi a cosa servono le Dat? Nessuno può sapere a priori cosa farà davanti al dolore. È un inferno che conosco, la sofferenza cambia radicalmente i convincimenti davanti alla vita e alla morte e rende carta straccia tutto quello si è deciso nel tempo della “sanità”. Ma non solo la sofferenza cambia la vita. La vita cambia la vita. Io non sono solo la mia malattia».
Lorenzo è un figlio, un fratello, un nipote, un alunno alle scuole Faes di Milano, dove dice orgoglioso «non mi sono stati fatti sconti. Avevo un carattere un po’ dispotico, pensavo che quella carrozzella mi imprigionasse nel diritto di restare spettatore mentre altri attori agivano, operavano nella realtà. Invece sono stato educato a sporcarmi le mani e sporcarmele bene anche io. A scuola ricevevo incarichi settimanali come i miei compagni. Non sono cresciuto a morsi di pane e sorsate di buonismo, ma sentendomi amato sulla faccia della terra. Sono caduto tantissime volte con la carrozzella, giocando a calcio con gli amici, rompendomi gli occhiali, spesso ribaltandomi e riportando traumi cranici da corse immediate in ospedale. Ma ho anche imparato a cadere, le cadute sono sane, ti ricordano che vivi la realtà e non un film di Walt Disney. E con l’urgenza che mi ha messo al mondo volevo capire come girasse il mondo». Alle superiori si sente chiamato in causa ad ogni dibattito o lezione di filosofia che affronta temi bioetici, impastato com’è da quel senso del limite e di finitezza umana che non è dato ai giovani onnipotenti: «Non è mai stato un problema di dignità, ma di autostima: quando sei piccolo non te ne accorgi ma crescendo inizi a sperimentare la vergogna, più cresci in coscienza più la dipendenza e l’accudimento materiale del tuo corpo genera la vergogna. Ma questo non ha niente a che vedere con la dignità: la vergogna è un peso umanissimo e fa parte della pienezza della mia vita. Così come il dolore».
In quegli anni la famiglia Moscon si trasferisce da Milano a Cernusco sul Naviglio, in una casa più grande e capace di garantire autonomia a Lorenzo che sta diventando un uomo. Studia, Lorenzo, si iscrive all’Università Cattolica in Scienze Linguistiche e letterature straniere, si laurea alla triennale con 110 e lode, frequenta ora la magistrale in Scienze del linguaggio, terminologie e tipologie dei testi. Vuole fare il traduttore, «si dice che i talenti andranno restituiti, no? Ebbene io ho talento nel non sopportare le intermediazioni e le interpretazioni. Ricordo un Natale, arrivarono dei cuginetti dall’America e senza qualcuno che traducesse per me non riuscivo a parlare né a capire cosa dicessero e quindi chi fossero. A me piace sapere le cose come stanno. Questo mi appassionava alla filosofia, alla bioetica, alla lettura di testi e giornali e professori che fossero padri e maestri, cioè capaci di informare e non educare, specie nel mio caso, alla scuola delle buone creanze, dei pensieri pericolosissimi della non discriminazione, che è la religione dei sani. L’inglese e poi lo spagnolo mi hanno aiutato ad avvicinarmi ai testi originali, mi hanno dato modo di essere protagonista delle cose che studiavo e studio. E soprattutto, in un mondo di grandissimi fraintendimenti, di non essere frainteso. Specie quando parlo di vita, di famiglia, del dolore».
Il dolore è una costante nella vita di Lorenzo, porta ancora le cicatrici del percorso post operatorio di bambino, quando le sue gambe, che ancora si aggrovigliano di notte, venivano distese e subivano torsioni da parte dei fisioterapisti. Per questo è favore della sedazione profonda nell’imminenza della morte, «ma questo non ha nulla a che vedere con un processo eutanasico: eliminazione del dolore non è sinonimo di alcuna azione che nelle intenzioni vuole procurare la morte. Io non ho mai chiesto di morire, né ci ho pensato. Mi sono chiesto, questo sì, nell’inferno del dolore che non sembrava finisse mai se questa era vita. E la risposta è sì. Ma per dire sì hai bisogno di qualcuno caro al tuo fianco».
L’affetto è una cura palliativa potentissima. E a volte terribile: «Tutti conoscono la vulnerabilità, pochi conoscono l’impotenza in senso etimologico: non possum, non possiedo le capacità e le abilità per fare da solo, ho bisogno di un altro anche per alzarmi dal letto. E nel letto conosci la sofferenza, la depressione, la sconfitta. Per questo ho scritto questa lettera al Parlamento insieme a un medico, Lorenzo, che frequenta il quarto anno di Medicina. È uno dei miei angeli custodi fin da quando eravamo piccoli. Conosce la mia storia, mi ha aiutato a mettere insieme i pensieri, dopo una serie di altre lettere scritte alle istituzioni». Era al primo anno di università quando sentì dire da Giorgio Napolitano «È indispensabile che il Parlamento si occupi dell’eutanasia». «Mi sento molto chiamato in causa da un argomento di bioetica così importante e decisivo in ragione della mia esperienza personale – scrisse al presidente –. Posso assicurare grazie a tale esperienza che nella condizione di malattia ho sempre avvertito il bisogno manifesto e oggettivo di essere voluto bene ed amato. La sofferenza, che è uno stato psicologico in questo caso determinata da un dolore fisico, può essere eliminata, anziché intraprendendo un sentiero definitivo come quello dell’eutanasia, mediante una relazione interpersonale che rammenti al malato il valore incommensurabile della propria dignità». La riposta di Napolitano si riassume nelle ultime righe “prendo atto della sua condizione” , “la saluto con cordialità”. «Ma è sulla dipendenza che deve giocarsi l’aiuto dello Stato: se qualcuno non mi alzasse dal letto mi troverei nella condizione di qualunque paziente in stato non responsivo transitorio, nonostante io sia in grado di intendere e di volere. E se qualcuno volesse potrebbe prevaricare sul mio corpo in ospedale, potrebbe farlo. Prima o poi qualunque uomo sarà costretto ad affrontare la dipendenza a causa dell’oggettiva deteriorabilità del proprio corpo. L’eutanasia è il tentativo di occultare o di eliminare questo dato incontrovertibile che è la condizione di dipendenza e di finitezza della vita biologica dell’uomo».
Lorenzo sa di essere trattato come un “caso” dai medici, così come dj Fabo è stato “il caso” per sfondare la porta dell’eutanasia. «Era immobilizzato, cieco, attaccato a un respiratore. Io non lo so come potrei sentirmi al suo posto, so però cosa doveva provare sentendosi un peso per le persone che amava. E so che è quell’amore a fare la differenza e a renderti libero nel legame, nella dipendenza. Lo so perché lo vivo, perché la libertà di vivere è presupposto fondamentale che permette di esercitare ogni altra forma di libertà. E l’eutanasia la distrugge: per questo non chiedo compassione ma compagnia, una compagnia all’assistenza. Questo termine è stato sostituito dalla parola accudimento e lì il pendìo è diventato scivoloso. Assistere da Ad-sistere. Ti sono accanto nella cura. Fino alla fine».



1 commento
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!