
ARTempi
Dossier – Tra capolavori e opere di “serie B”, Palazzo Barberini non è forse più quello di una volta
C’era una volta Palazzo Barberini, dimora sfarzosa progettata da architetti del livello di Maderno, Bernini e Borromini, simbolo del buongusto e della magnanimità di una della più prestigiose famiglie romane (di origini toscane) del Seicento e del potere pontificio di Papa Urbano VIII Barberini che la fece costruire, a partire dal 1627, come sede di rappresentanza. Dotata di un giardino che si estendeva sul retro con un intreccio regolare di viali fiancheggiati da siepi di bosso, con un parco ornato con bulbi da fiore e alberi da produzione dove si allevavano cervi, struzzi, cammelli e altri animali esotici, la villa splendeva di stucchi e volte affrescate, come quello straordinario Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona (nell’omonimo salone sabato 30 novembre 2013 si terrà, in occasione di Una notte al museo, il Gran Ballo a Palazzo Barberini in costume dell’800) dalle dimensioni colossali (m 24×14) e dal raffinato intreccio tematico elaborato da Francesco Bracciolini che celebra, attraverso allegorie e rappresentazioni mitologiche, l’apoteosi della divina provvidenza, oltre a quella del pontefice e della sua famiglia, ovviamente. All’interno di questa epopea della magnificenza di cui Roma è piena fino alla nausea, dal 1893 è ospitata la Galleria Nazionale d’Arte Antica, che vanta “capolavori” come la Fornarina di Raffaello, Giuditta che taglia la testa ad Oloferne e Narciso di Caravaggio (il terzo presunto Caravaggio, il San Francesco in meditazione, è stato attribuito al Merisi solo dopo un restauro), e altre opere di artisti come El Greco, Tiziano, Andrea del Sarto, Domenichino, Bronzino, Tintoretto.
[internal_gallery gid=134605]
C’era una volta lo splendore di Palazzo Barberini, ma cosa è rimasto adesso? Sale chiuse e piani aperti a giorni alterni, intonaci che cadono a pezzi, scaloni monumentali trascurati, serra dismessa e giardini poco curati. Certo, al di là di quei due Caravaggio, dell’Enrico VIII di Hans Holbein, del Ritratto di Erasmo da Rotterdam di Quentin Metsys e di sua grazia la Fornarina, l’acquisto delle opere di altri autori – da molto a troppo noti – pare sia avvenuta seguendo uno scrupoloso risparmio. Lorenzo Lotto non sembra in sé con quella Madonna dal volto paffuto del Matrimonio mistico di Santa Caterina; lo stesso si può dire di Tintoretto con Cristo e l’adultera, e di Tiziano, con quella Venere che goffamente tenta di trattenere Adone nel dipinto Venere e Adone. Si distinguono tra queste scelte di “serie B”, una mistica e dalla elegante sensualità Maddalena firmata Guido Reni, un’altra bellissima – ma questa volta decisamente terrena – Maddalena di Simon Vouet, e la Madonna col Bambino e San Giovannino di Domenico Beccafumi, opera non finita datata tra le fine del III e l’inizio del IV decennio del XVI secolo che testimonia l’influenza di Leonardo sul meno noto pittore senese che si annovera dei fondatori del manierismo. Ma di manierista in quest’opera c’é ben poco, data l’intensa espressività dei teneri protagonisti. Aveva ragione, a questo punto, Bino Sanminatelli quando affermava che quest’olio su tavola non è altro che <<la più inquieta interpretazione data dell’ermetismo espressivo leonardesco>>.
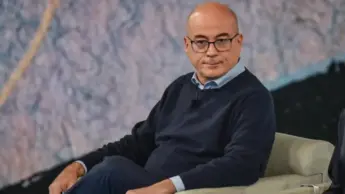


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!