
Posseduto da un esorcista


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)
«Il salto di Karras [dalla finestra] – compiuto solo per impedire al demone di riprendere il controllo della ragazza e di ucciderla – è il suo trionfo totale. È esclusivamente questo atto – un atto di amore e di sacrificio di sé – che costituisce l’esorcismo di Regan MacNeil. È stato uno scrittore che ammiro, Ray Bradbury, a capirlo nel modo più chiaro quando ha parlato de L’esorcista come di “una grande storia d’amore”. Pensateci». (William Peter Blatty alla rivista Gadfly, ottobre 1998)
O William Peter Blatty è stato un furbone di sette cotte, oppure si deve pensare che tutta la sua vita in un certo senso sia stata posseduta. Posseduta dalla sua opera sulla possessione. Posseduta da una fede cattolica vissuta come una realtà più oggettiva di qualunque suo possibile dubbio, successo o fallimento. È un peccato che alla sua morte, avvenuta il 12 gennaio scorso, cinque giorni dopo il suo compleanno numero 89, i giornali italiani si siano limitati ai colonnini di rito.
Nato nel 1928 a New York in una famiglia libanese molto cattolica, madre devotissima e prozio arcivescovo, laureato in letteratura inglese alla Georgetown, l’università dei gesuiti di Washington, ovviamente William Peter Blatty è famoso per aver scritto, sceneggiato e prodotto L’esorcista. Ha fatto paura a mezzo mondo e forse di più, tanto che nel 1997 è stato insignito del premio alla carriera dalla Horror Writers Association of America. Molto onorato, ma Blatty non si è mai sentito uno scrittore horror. Tutt’altro. «Prima de L’esorcista avevo una bella reputazione come autore comico», diceva con rimpianto. Era entrato nel mondo del cinema per essere risultato simpatico alla moglie di un dirigente della Columbia Pictures che lo aveva visto per caso in tv: una comparsata di pochi minuti per promuovere il suo primo libro, più autoironico che autobiografico.
«I tuoi genitori sono arabi, giusto?», gli fece il conduttore. «E dove li hai presi quegli occhi azzurri?». «Le Crociate», rispose Blatty. Il suo primo incarico a Hollywood, nel 1963, fu trasformare un giallo in commedia. Ne uscì la sceneggiatura di Uno sparo nel buio, il sequel de La Pantera rosa con Peter Sellers nei panni di Clouseau. Prima ancora, a Los Angeles, dove lavorava come addetto alle relazioni dell’università, per un anno intero si era finto il figlio scapestrato di un principe saudita per potersi imbucare alle feste dell’alta società e attirare su di sé i peggio tentativi di arruffianamento. Poi aveva raccontato tutto sul Saturday Evening Post.
Un’idea coltivata a lungo
Dopo L’esorcista, provò a recuperare la sua «bella reputazione» con una specie di parodia della sua stessa opera (Demons Five, Exorcists Nothing), ma non riuscì mai a tornare il re della commedia di cui il New York Times era arrivato a dire: «Nessuno sa scrivere battute più divertenti di William Peter Blatty». «L’eredità di questo autore comico è un film horror», ha scritto il Washington Post celebrando nel 2013 il quarantennale dell’opera da cui Blatty era posseduto.
Prima di dedicarsi alla scrittura, Blatty aveva fatto di tutto, anche il rappresentante di aspirapolveri. Poverissimo in gioventù, aveva potuto studiare solo in virtù dei propri meriti e della generosità dei gesuiti. Nel 1961 riuscì a liberarsi dall’obbligo di un lavoro fisso anche grazie ai 10 mila dollari vinti allo show di Groucho Marx You Bet Your Life, dove si era presentato facendo la gag del principe saudita. Con sceneggiature e romanzi cominciò a girargli bene, finché, molto presto, il filone commedia farsesca si rinsecchì e Blatty rimase disoccupato. Fu allora che arrivò L’esorcista.
L’idea gli si agitava in testa dal 1949, quando durante un corso all’università aveva appreso del caso, reale, di un 14enne vittima di possessione demoniaca. Si era detto: assurdo, queste cose succedono ancora ai giorni nostri. In un momento di crisi di fede, il fatto lo aveva colpito profondamente per la sua oggettività. Così come nel romanzo la presenza del demone Pazuzu nel corpo della giovanissima Regan finisce per sconvolgere lo scetticissimo padre Karras, l’esorcista del titolo, un sacerdote gesuita e psichiatra guarda caso cresciuto con la madre a New York nella miseria più totale, «scappato verso l’amore» alla Georgetown a Washington e poi precipitato in una disperata aridità interiore di fronte al «silenzio di Dio».
Vent’anni dopo, Blatty capì che era giunta l’ora di accantonare le commedie e di raccontare quella realtà che non lo lasciava tranquillo. Vedendosi negato l’accesso agli atti dell’episodio del 1949, deviò sulla fiction. Si mise a studiare. Per otto mesi lesse «ogni singolo libro sulla possessione uscito in inglese dal 1940», fino a diventare in materia «il massimo esperto in America, magari perfino nel mondo». Poi scrisse per nove mesi, 14-18 ore al giorno. Il libro uscì nel 1971.

Un giallo soprannaturale
Più di 13 milioni di copie vendute solo in America, 18 traduzioni, 57 settimane consecutive di permanenza nella “New York Times bestseller list”, 17 delle quali al numero 1. Due anni dopo, nel 1973, l’adattamento hollywoodiano si guadagnò 10 nomination agli Oscar e se ne aggiudicò due, di cui uno alla miglior sceneggiatura non originale firmata proprio da Blatty. Si narra di code interminabili ai botteghini, addirittura tentativi di sfondamento, moltissimi casi di malori in sala. Le riviste più prestigiose degli Stati Uniti e del mondo, da Newsweek a Mad, dedicarono raffiche di copertine alla “Exorcism Frenzy”. L’esorcista è ancora oggi in testa alle più importanti classifiche dei migliori film horror di sempre (vedi Entertainment Weekly), è ritornato più volte in programmazione in occasione dei vari anniversari, ed è rimasto primo del suo genere per incassi fino al 1999, quando è stato superato da Il sesto senso. La mitica scalinata di Washington giù per la quale precipitano prima il povero regista ubriacone Burke Dennings e poi padre Karras è diventata meta di attrazione turistica.
E dire che non doveva neanche essere un horror, almeno non nei piani iniziali di Blatty. Lui voleva scrivere un «thriller teologico». Una «supernatural detective story». Cominciò a intuire che avrebbe potuto funzionare osservando la sua assistente che «era troppo terrorizzata per lavorarci quando era sola nello studio». Ovvio che il libro è un “page-turner”, come si dice in inglese, e sembra scritto con il film già in testa. Ovvio che la pellicola almeno in parte era un successo annunciato. Del resto al cinema si va per ridere, per piangere o per farsela sotto dalla paura. E L’esorcista riesce benissimo nell’intento. Ma oltre a tenere la gente incollata alle pagine e alle poltrone Blatty aveva un altro scopo, quando scrisse quel libro, e lo ha sempre ripetuto con la massima tranquillità: «Il mio intento era di fare un’opera “apostolica”».
«Se esistono forze del male immateriali e intelligenti, già solo questo suggerisce la possibilità che esistano altre forze dello stesso tipo che sono buone. E dal momento che l’intelligenza demoniaca risponde al rituale usato dai gesuiti, appare chiaro che Dio c’è». (Ibidem)
Dice il regista William Friedkin nella sua autobiografia: «La mia intenzione e quella di William Blatty era quella di raccontare una storia sul mistero della fede e della vita. Alle alte sfere cattoliche L’esorcista piacque. Qualche importante prelato aveva addirittura la sua copia personale». Nelle scuole gesuitiche americane il libro divenne un vero e proprio oggetto di studio, e Blatty ricordava con soddisfazione la «ampia e favorevole» ricezione del film da parte della stampa cattolica, in particolare la «recensione molto positiva» della Civiltà Cattolica e quella di Catholic News, organo della diocesi di New York, oltre al fatto che una volta un brano del suo romanzo fu letto durante un’omelia niente meno che dal cardinale John Joseph O’Connor per mettere in guardia i fedeli dal potere del diavolo.
La guerra dei trent’anni
Tuttavia ebbe sempre il cruccio di quelli che pensavano che il gesto estremo di padre Karras rappresentasse la vittoria di Pazuzu. Nel 1974 prese carta e penna per spiegarlo di suo pugno alla rivista dei gesuiti America, che in un numero speciale dedicato a L’esorcista aveva accreditato questa lettura. Se al centro della storia c’è l’oggettività di un male e di un bene che sono tali indipendentemente da quello che pensano e fanno i personaggi coinvolti (atei o credenti, medici o preti, madri o poliziotti che siano), Blatty ha sofferto a lungo perché nel montaggio del film erano saltate un paio di scene che riteneva dirimenti. Pensava di non essere riuscito a dire tutto. I film ognuno li interpreta come vuole, certo, ma l’oggettività è un’altra cosa. Blatty sembrava posseduto da questa sensazione e ci ha combattuto per quasi trent’anni, finché nel 2000 ha convinto l’amico ebreo agnostico Friedkin a uscire con L’esorcista – Versione integrale.
In realtà il messaggio «apostolico» di Blatty a quanto pare era passato alla grande nonostante il filtro “laicizzante” di Friedkin. Di “propaganda cattolica” si parlò subito e apertamente in alcuni paesi islamici, dove il film è vietato. La stessa accusa comparve in molte recensioni dell’epoca non certo neutrali. Quella de L’espresso firmata da Alberto Moravia, per esempio; in America fu una regina della critica cinematografica come Pauline Kael a inveire sul New Yorker: «Un film assolutamente spietato sui miracoli». «Il più grande manifesto di reclutamento che la Chiesa cattolica abbia avuto dai giorni felici di La mia via e Le campane di Santa Maria». «Come si esorcizzano gli effetti di un film come questo? Non c’è modo. L’industria del cinema è tale che uomini privi di gusto e di immaginazione possono esercitare un’influenza incalcolabile». «Sicuramente sono le persone religiose che dovrebbero sentirsi le più offese».
Si può dibattere all’infinito su quanto fosse necessario ripristinare le scene tagliate, ma Blatty non voleva che si potesse discutere il suo intento. Quel dialogo tra padre Karras e l’esorcista esperto padre Merrin sullo scopo della possessione e la possibilità dell’amore di Dio era imprescindibile per lui. Una cosa che andava detta. Oggettivamente. «Lo scopo del demone – disse un giorno alla rivista Filmfax per spiegare il dissidio con Friedkin – è di farci rifiutare la nostra umanità, di farci credere, ultimamente, che se ci fosse davvero un Dio, non potrebbe mai amarci. Se questo fosse rimasto nel film di Friedkin, avrebbe permesso agli spettatori di non odiare se stessi per averlo apprezzato».
Forse scottato da questa esperienza, la sua “trilogia della fede” Blatty se la completò da solo: diresse e sceneggiò in prima persona La nona configurazione (1980) e pure L’esorcista III – Legione (1990), dopo aver preso tutte le distanze possibili dal disastroso L’esorcista II («Mi spiace, ma questa storia non si può affrontare con un approccio non cattolico o non ebraico. John Boorman ha provato evidentemente a fare qualcosa di mozzafiato e di originale, ma è un orangista, un protestante. Non funziona»).
William Peter Blatty in qualche occasione si è definito un «cattolico rilassato». Ma rilassatissimo non doveva essere uno che ha avuto quattro mogli e sette figli e che certe volte le rogne sembrava proprio cercarle. A parte le sue repliche ai critici e la calorosa difesa della Passione di Cristo di Mel Gibson («una grandiosa rappresentazione del male»), bisogna annoverare, nel 1983 una causa legale da 6 milioni di dollari intentata (e perduta) contro il New York Times che a suo dire aveva deliberatamente escluso Legione dalla classifica dei libri più venduti causandogli un danno commerciale. Poi, nel 2001, ci fu quella, con Friedkin, contro la Warner Bros che secondo i due per anni aveva sottostimato gli incassi de L’esorcista per non pagare loro tutta intera la dovuta percentuale (alla fine le parti si accordarono).
Il tradimento dell’alma mater
Soprattutto, il 31 maggio 2012 Blatty ha cominciato a raccogliere firme per una petizione indirizzata al cardinale Donald Wuerl, arcivescovo di Washington, per chiedergli di ritirare alla Georgetown il diritto di definirsi università “cattolica”. Oltre duemila sottoscrittori tra ex alunni, docenti e relativi parenti, quasi 200 pagine, 476 note, 91 appendici, 124 testimonianze di «scandali» a dimostrazione del tradimento della costituzione apostolica Ex Corde Ecclesiae e di una secolarizzazione neanche troppo strisciante. A parte una lettera di monsignor Angelo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica, che definiva la protesta capitanata da Blatty «un reclamo fondato», la cosa non ha avuto sviluppi noti.
«Bill, cosa stai facendo?, gli domanda la gente. Bill, i tempi cambiano, lascia stare. Bill, perché vuoi punire la scuola che ami, la scuola che con le sue borse di studio ti ha salvato dalla povertà, la scuola che ti ha reso possibile questa vita, che ha cementato la tua fede? “Se ami davvero qualcuno che credi che abbia bisogno di disintossicazione, farai tutto il possibile per farlo ricoverare”, dice Blatty. L’ultima goccia, spiega, è stato l’invito della Georgetown a Kathleen Sebelius, segretario del dipartimento della Sanità, a parlare alla cerimonia di consegna dei diplomi a maggio dell’anno scorso. Sebelius detiene un record di voti favorevoli all’aborto, e l’aborto è il tema che fa veramente infuriare Blatty. Descrive con voce tremante una particolare procedura abortiva con dettagli espliciti. Fa una pausa. La sua voce è quasi un sussurro. “Questo è demoniaco”». (Dan Zak, Washington Post, 30 ottobre 2013)
La sua ultima opera, ultima in tutti i sensi anche nei progetti di Blatty, è uscita nel 2015 e riguarda suo figlio. Finding Peter. In un certo senso, quella cosa inspiegabile e oggettiva che si era impossessata della vita di Blatty, Peter Vincent Galahad la incarnava direttamente. «C’era qualcosa di soprannaturale» in lui, «era un mistero». Già da piccolissimo, Peter diceva cose che lasciavano tutti di stucco. «Mamma, sai perché sono venuto qui? Sono venuto qui per aiutare le persone». «Sai come imparo io papà? Imparo dal cielo, è Dio che mi insegna». Amatissimo dai genitori, fu portato a Washington per essere educato cattolicamente in una scuola dell’Opus Dei. Dopo qualche anno però sviluppò un grave disordine bipolare e prese a drogarsi. Stava facendo un percorso di disintossicazione quando, nel 2006, a 19 anni, rimase improvvisamente ucciso da una miocardite virale.
Nel libro Blatty racconta i segni che secondo lui il figlio perduto ha continuato a mandargli in questi dieci e passa dolorosi anni. Un giorno doveva tenere un discorso in pubblico, era nel panico come al solito; Peter gli fece trovare nel pavimento della doccia la medaglia con le tre croci del Calvario che era appartenuta a lui e che il padre aveva perduto da tempo. Era come se Peter, giunse a pensare lo scettico Blatty, volesse fargli sapere di essere ancora in comunione con lui. Quasi come a confermargli l’oggettività di tutto quello per cui aveva vissuto. La morte non vince. «Non sono sprofondato nell’oblio».
«Alla fine de L’esorcista, la madre riesce a credere al diavolo perché “continua a farsi tutta quella pubblicità”; e Dyer risponde: “Ma allora come si pone di fronte a tutto il bene che c’è nel mondo?”. È questa la domanda che pongono il mio romanzo e implicitamente il film: e cioè, se l’universo è un meccanismo e l’uomo non è altro che strutture molecolari, com’è che esiste un amore come l’amore di cui è capace Dio e che un uomo come il gesuita Damien Karras offre deliberatamente la propria vita per un’estranea, per il corpo alieno di Regan MacNeil? È certamente un enigma più misterioso e molto più degno di riflessione dello scandaloso problema del male; è il mistero del bene. È il punto che mancano tutti i critici». (William Peter Blatty, lettera alla rivista America in risposta al numero speciale su L’esorcista, 23 febbraio 1974).
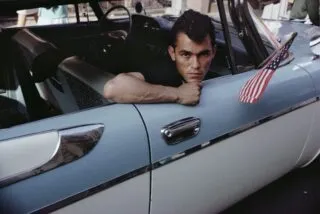


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!